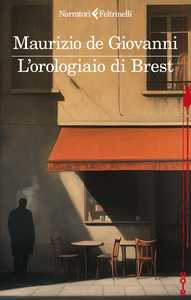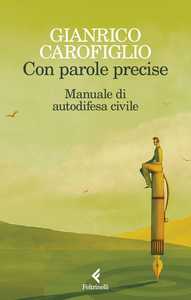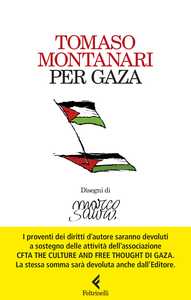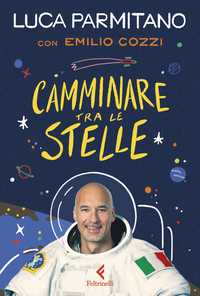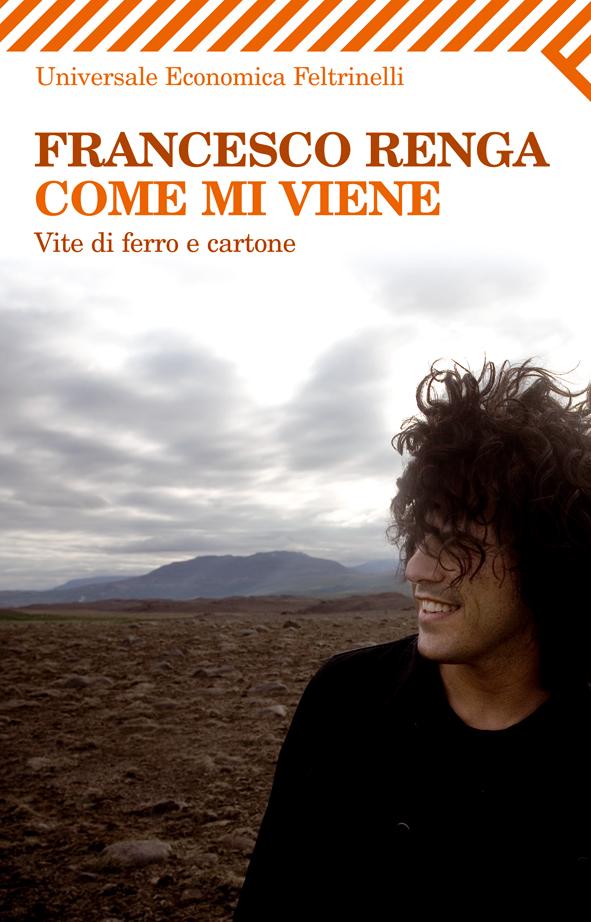
Tre domande a Francesco Renga
Francesco Renga è il ritratto della serenità. Eppure quel sorriso disarmante nasconde l’inquietudine alla base di Ferro e cartone, il nuovo album, e di Come mi viene, il suo primo romanzo...
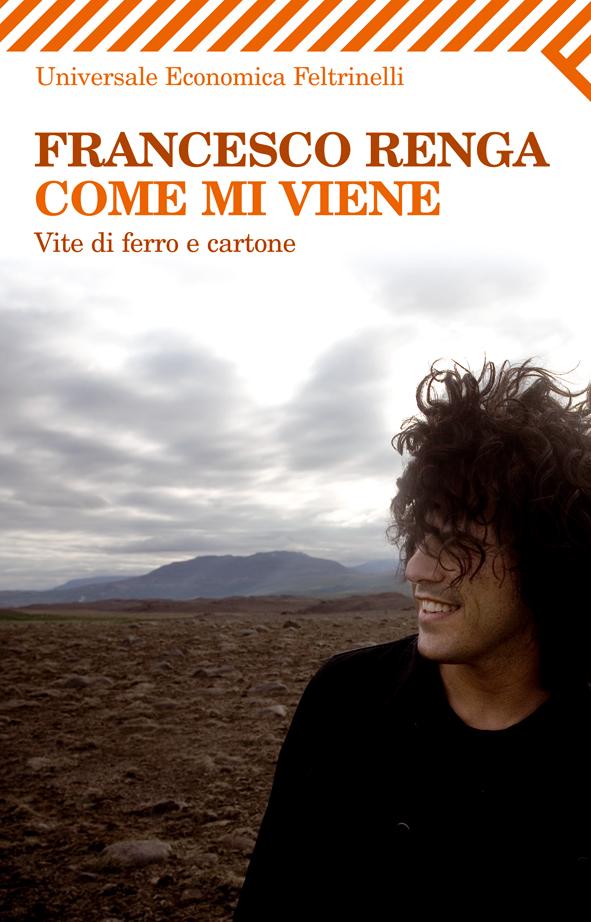
Che paura la felicità. Intervista a Francesco Renga
‟Io ho perso mia madre a 19 anni. Lo so che è una cosa puerile, ma non le ho mai perdonato di avermi lasciato da solo. Lo spavento della felicità ce l’ho ancora quotidianamente, la paura che non duri. Come in Coralli, che infatti è il più autobiografico... però finisce con un suicidio, e io non mi sono suicidato: lo vedi che non è proprio tutto vero?”
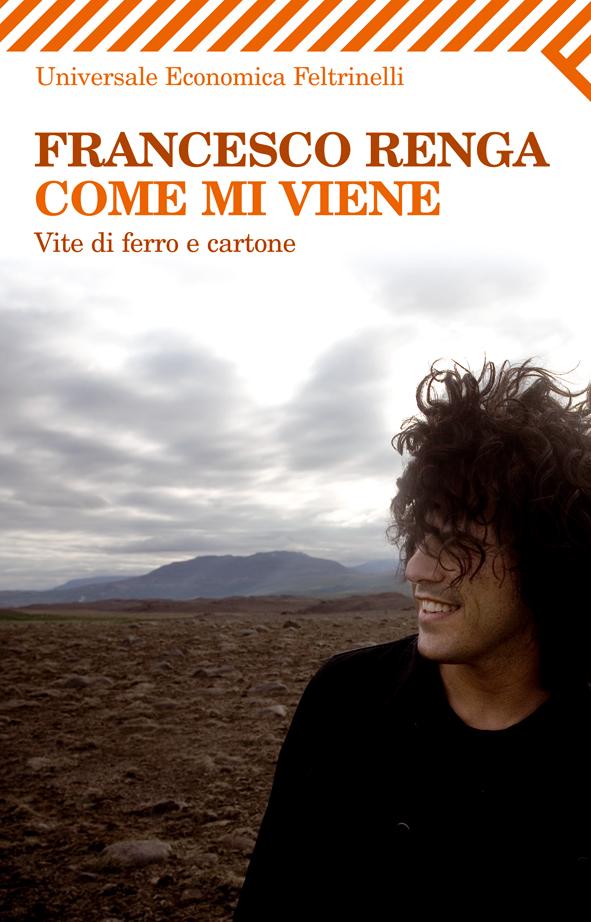
‟Cerco di smarcarmi dallo stile italiota”. Colloquio con Francesco Renga
Dal video girato in Islanda, al romanzo, ai nuovi progetti: ‟Alla vigilia dei quarant'anni mi sono rimesso in movimento. Mi piacerebbe un film. Mi vedo bene in un poliziesco provinciale, sarei perfetto nei panni di un Tomas Milian bresciano”.
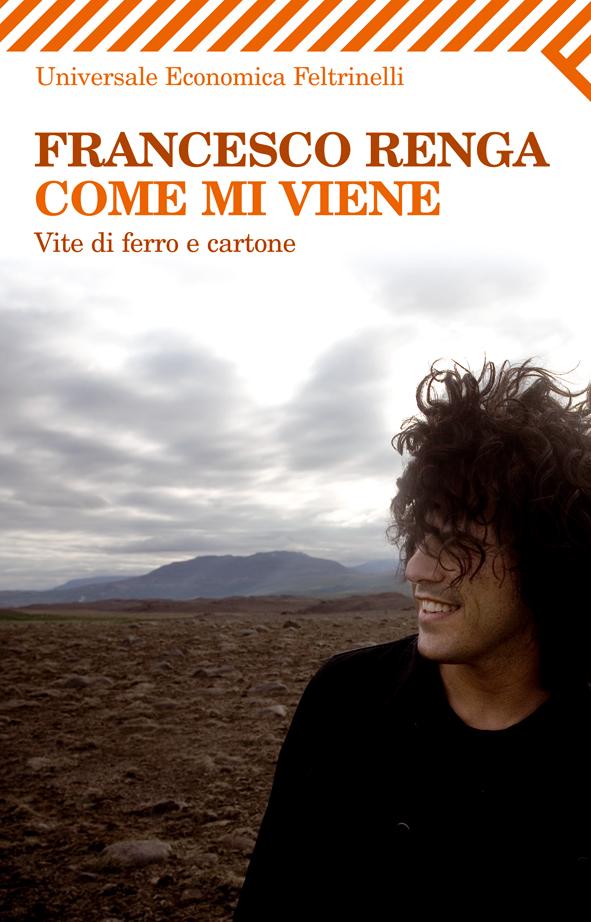
Ho voglia di un abbraccio. Speed date con Francesco Renga
"Una volta volevo scrivere delle frasi d’amore a una donna che mi piaceva moltissimo. Così cercai nei cassetti di casa una busta e un biglietto e non mi accorsi che erano listati a lutto: lei non mi ha più voluto vedere."