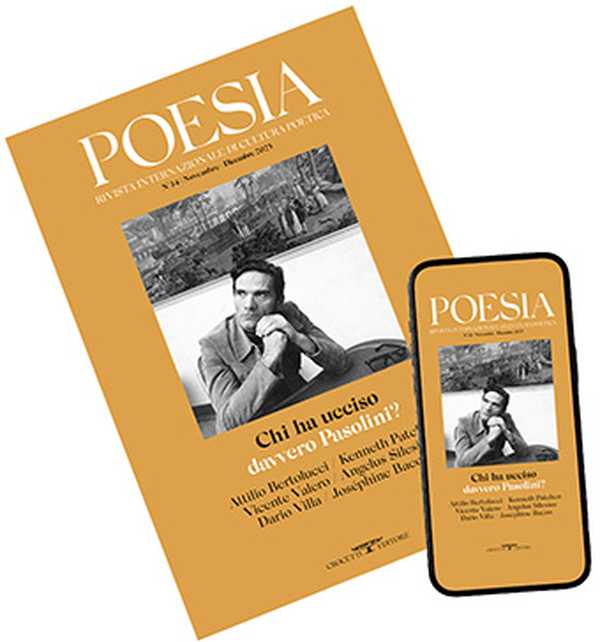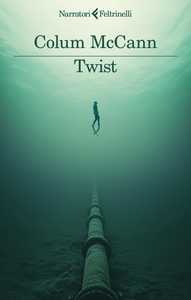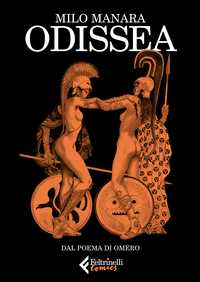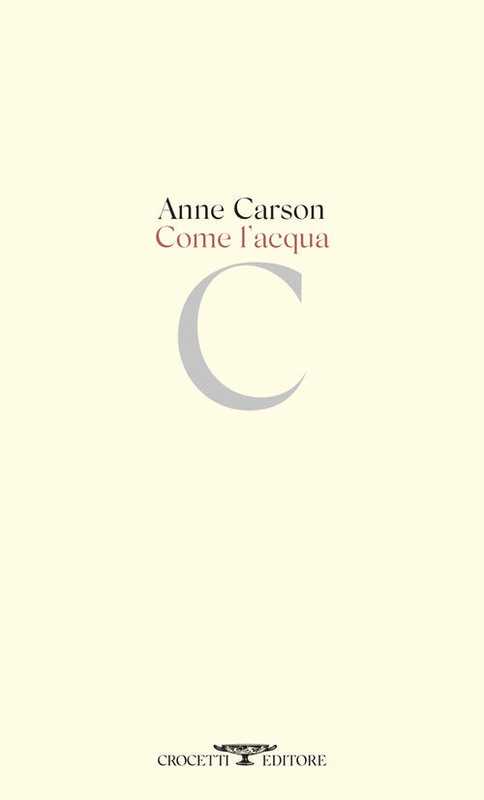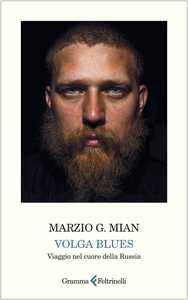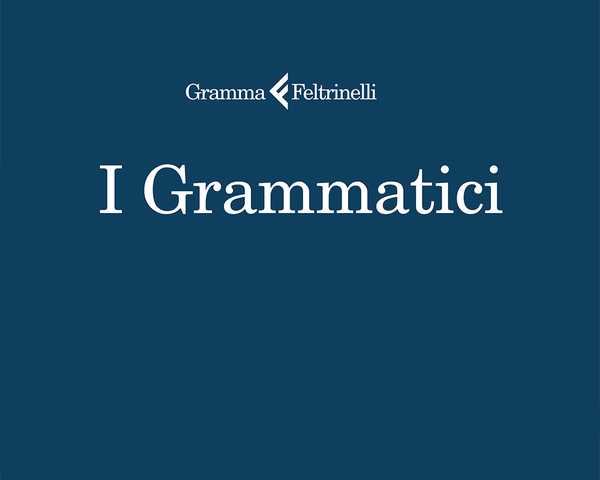Paolo Rumiz: I forzati della sala macchine
01 Settembre 2004
Mi svegliano le urla del Comandante. Le guarnizioni di testa del motore sono partite e per riparare il guasto, gli dicono al telefono, c'è da aspettare quattro giorni, forse cinque. La bagnarola tace, Fabrizio manda "in mona" tutti i meccanici del pianeta. Gli succede proprio oggi che deve traversare il golfo del Quarnaro: il canale leggendario dove la bora urla e cominciano le isole. Mi dice di andare avanti, di prendere un traghetto fino a Lussino o Zara, chissà che nel frattempo non si rimedi il guaio. So quanto gli costa: davanti a noi passa la processione agostana delle vele, un "liston" che, procedendo a Oriente, diventa carovana. Per intanto vado in auto a Capo Promontore, la penisola rocciosa, aspra, quasi bretone, dove l'Istria finisce e lo spettacolo è ancora più grandioso. Le barche vanno nel maestrale, regolari e silenziose, inclinate di bolina, doppiano il faro sull'isolotto di Porèr, e allora capisci che è vero, l'Adriatico è un "canàl", come dicono a Venezia, nient'altro che il Canal Grande che continua. Ne conto più di cento in mezz'ora, mi chiedo se quelli a bordo sanno di far parte di una leggenda che dura da oltre mille anni, se hanno la minima idea del mare di storia su cui navigano. Ragazzi si tuffano dai faraglioni nell'acqua verde bottiglia, arriva uno sloveno con la fisarmonica diatonica, un piccolo strumento austroungarico da saloon che trovi solo tra Istria e Klagenfurt. Suona ballate in bilico fra Grecia e Danubio, scatena un'allegria contagiosa, attira centinaia di giovani. Tutti cantano, ballano, bevono, applaudono, si tuffano da dieci metri. Facce magre di adolescenti in gara, in un gioioso rito di iniziazione. Magnifico: niente telefonini, videogiochi, sbadigli. Aggrappati alle rocce, sembrano una colonia di pinguini in mutande. Dalle baie intorno arriva altra gente in barca a godersi questa scena da film di Kusturica, la baraonda slava che si affaccia sul Mediterraneo.
Al ritorno trovo il Comandante rassegnato. Mi scarica i bagagli, consegna la Carta del viaggio e il bandierone di San Marco. C'è un traghetto che va a Lussino, stasera posso già essere sull'isola. Un abbraccio sulla banchina, tanto magone. La nave in partenza è il Marina, gloriosa unità costruita in Danimarca nel 1936 (nome originario Kronprinsessan Ingrid), una guerra alle spalle e 35 anni di onorato servizio di pace sulle isole. A bordo il tempo si è fermato: pontone d'accesso laterale, macchinari svedesi d'epoca, odore di ferro, legno e vernice, una sala ristorante da ‟Orient Express”, il rassicurante ron-ron del motore. Un luogo letterario unico. In piccolo, la nave de La leggenda del pianista sull'oceano. Si salpa, tutto vibra, sopra di noi una nube diafana e luminosa a forma di aringa naviga nella stessa direzione, l'isoletta di Fener rimanda a un faro sul Bosforo con lo stesso nome. Non ci seguono gabbiani, gli spazzini del mare si sono tutti inurbati. Il capitano dorme, la sua cabina è chiusa come quella di Achab alla partenza del Pequod. Il primo ufficiale Miljenko Mataja mi porta in sala macchine dove, in una foresta di pompe, guarnizioni in bronzo, imbuti, aeratori, tubi e pistoni, i ragazzi del liceo nautico di Lussino fanno pratica. Non c'è niente di elettronico, comunicano solo a gesti e sguardi, in quel frastuono parlare è inutile. Ridono, sono cresciuti alla vecchia scuola del tornio e dell'olio di macchina.
Il Quarnaro delle tempeste è liscio come una prateria. In mezzo ha uno scoglio solo, Gagliola. Novant'anni dopo, quelli di Pola ancora si chiedono come Nazario Sauro sia riuscito a centrarlo col suo sommergibile, lui che era di quelle terre. L'imperizia lo spedì dritto al capestro, visto che era suddito austriaco passato all'Italia. Dietro Gagliola, la prima vera isola, Unije, solitaria e appartata. Si attracca, sulla tolda i comandi di manovra conservano le parole-chiave in lingua veneziana. "Lasca!" per dire allenta. "Guanta!", tieni forte. E poi "Vira", "Bando". Anche le bestemmie-chiave sono in italiano, segno pure quello di una continuità di lingua che arriva fino a Cipro. Ma nel gergo della ciurma spuntano anche parole turche, con buona pace dei pasdaràn della purezza croata. Colgo al volo un "Mahala" per dire villaggio, "Pàpuce", ciabatte. Tutta roba filtrata dalla Bosnia, ex ottomana. Il viaggio a Lepanto è anche questo. Mediterraneo, spazio che amalgama i conflitti. I segni di Venezia e del Bosforo già si sovrappongono. Anche nel cibo. Spuntino in Dalmazia si dice "Marenda", l'acqua tagliata col vino "Bevanda". Ma nel menu di bordo trovo carne alla brace e ajvar, un purée di melanzane chiaramente turco. Compaiono le sarme, foglie ripiene di carne e riso, altra delizia orientale. Che strano: mentre l'impero ottomano arretrava, ammalato e corrotto, il suo cibo avanzava, contaminava le nazioni contermini. Sul tavolo di mia nonna, triestina, arrivarono i "curabié", dolcetti a mezzaluna dalla Bosnia appena conquistata. Con Tito, sfondarono verso nord i "cevapcici", polpettine alla brace. Poi in Germania sbarcò il "Kebab", la più grande industria turca nell'Europa Unita.
Pensierino della sera, con le luci di Lussinpiccolo in vista. Se i segni della Turchia arrivano fino a Venezia e quelli di Venezia fino in Turchia, Lepanto fu davvero uno scontro di civiltà? Venezia con Istanbul ebbe tanti più anni di pace che di guerra. Con i turchi, anzi, la Serenissima fece fortuna, e col più antico dei trucchi, il contrabbando. Istanbul era soggetta alle sanzioni del Papa, guai se un cattolico commerciava con gli infedeli. I veneziani aggirarono l'embargo e divennero ricchi portando ferro, legno e schiavi. I Cavalieri di Malta, paladini della purezza cattolica, ce l'avevano a morte con loro proprio per questo disinvolto pragmatismo. E non a caso i pellegrini della Terrasanta, viaggiando per mare dall'Adriatico, avevano quasi più paura dei maltesi che dei turchi. Dopo Lepanto, Venezia fece una pace separata con gli Ottomani. Troppi erano gli interessi in comune per vivere in stato di continua belligeranza. Venezia e Istanbul erano entrambe potenze marinare di Levante, e il loro nemico era lo stesso. Stava a Ponente, era l'Atlantico. Nonostante lo scuoiamento di Bragadin, la leggenda del turco demoniaco non nacque affatto a Venezia. Fu il frutto tardivo di una manipolazione romantica nordica, lontana dal Mediterraneo, e servì a giustificare lo sconfinamento degli stati-nazione verso quelle terre e quel mare. D'Annunzio disse: "La patria è sulla nave", contrabbandò la guerra come erotismo, e cominciarono i disastri.
Lussinpiccolo rimineggia, c'è un carnaio di turisti, ragazzi col gel, braghe a mezz'asta e skateboard ai piedi. "Attento ai teppisti che picchiano gli stranieri", mi avverte un barista. Un disastro, non un buco per dormire. La leggenda di Lussino, l'isola dei capitani coraggiosi, è perduta. l'unica cosa vera sono i pescherecci. Uno si chiama Andrea, che qui è nome di femmina. A bordo, pescatori con anelli pirateschi all'orecchio si passano cassette, la plancia è piena di procaci donne nude su carta. Notte sotto le stelle con rimbombo di discoteche.
Al ritorno trovo il Comandante rassegnato. Mi scarica i bagagli, consegna la Carta del viaggio e il bandierone di San Marco. C'è un traghetto che va a Lussino, stasera posso già essere sull'isola. Un abbraccio sulla banchina, tanto magone. La nave in partenza è il Marina, gloriosa unità costruita in Danimarca nel 1936 (nome originario Kronprinsessan Ingrid), una guerra alle spalle e 35 anni di onorato servizio di pace sulle isole. A bordo il tempo si è fermato: pontone d'accesso laterale, macchinari svedesi d'epoca, odore di ferro, legno e vernice, una sala ristorante da ‟Orient Express”, il rassicurante ron-ron del motore. Un luogo letterario unico. In piccolo, la nave de La leggenda del pianista sull'oceano. Si salpa, tutto vibra, sopra di noi una nube diafana e luminosa a forma di aringa naviga nella stessa direzione, l'isoletta di Fener rimanda a un faro sul Bosforo con lo stesso nome. Non ci seguono gabbiani, gli spazzini del mare si sono tutti inurbati. Il capitano dorme, la sua cabina è chiusa come quella di Achab alla partenza del Pequod. Il primo ufficiale Miljenko Mataja mi porta in sala macchine dove, in una foresta di pompe, guarnizioni in bronzo, imbuti, aeratori, tubi e pistoni, i ragazzi del liceo nautico di Lussino fanno pratica. Non c'è niente di elettronico, comunicano solo a gesti e sguardi, in quel frastuono parlare è inutile. Ridono, sono cresciuti alla vecchia scuola del tornio e dell'olio di macchina.
Il Quarnaro delle tempeste è liscio come una prateria. In mezzo ha uno scoglio solo, Gagliola. Novant'anni dopo, quelli di Pola ancora si chiedono come Nazario Sauro sia riuscito a centrarlo col suo sommergibile, lui che era di quelle terre. L'imperizia lo spedì dritto al capestro, visto che era suddito austriaco passato all'Italia. Dietro Gagliola, la prima vera isola, Unije, solitaria e appartata. Si attracca, sulla tolda i comandi di manovra conservano le parole-chiave in lingua veneziana. "Lasca!" per dire allenta. "Guanta!", tieni forte. E poi "Vira", "Bando". Anche le bestemmie-chiave sono in italiano, segno pure quello di una continuità di lingua che arriva fino a Cipro. Ma nel gergo della ciurma spuntano anche parole turche, con buona pace dei pasdaràn della purezza croata. Colgo al volo un "Mahala" per dire villaggio, "Pàpuce", ciabatte. Tutta roba filtrata dalla Bosnia, ex ottomana. Il viaggio a Lepanto è anche questo. Mediterraneo, spazio che amalgama i conflitti. I segni di Venezia e del Bosforo già si sovrappongono. Anche nel cibo. Spuntino in Dalmazia si dice "Marenda", l'acqua tagliata col vino "Bevanda". Ma nel menu di bordo trovo carne alla brace e ajvar, un purée di melanzane chiaramente turco. Compaiono le sarme, foglie ripiene di carne e riso, altra delizia orientale. Che strano: mentre l'impero ottomano arretrava, ammalato e corrotto, il suo cibo avanzava, contaminava le nazioni contermini. Sul tavolo di mia nonna, triestina, arrivarono i "curabié", dolcetti a mezzaluna dalla Bosnia appena conquistata. Con Tito, sfondarono verso nord i "cevapcici", polpettine alla brace. Poi in Germania sbarcò il "Kebab", la più grande industria turca nell'Europa Unita.
Pensierino della sera, con le luci di Lussinpiccolo in vista. Se i segni della Turchia arrivano fino a Venezia e quelli di Venezia fino in Turchia, Lepanto fu davvero uno scontro di civiltà? Venezia con Istanbul ebbe tanti più anni di pace che di guerra. Con i turchi, anzi, la Serenissima fece fortuna, e col più antico dei trucchi, il contrabbando. Istanbul era soggetta alle sanzioni del Papa, guai se un cattolico commerciava con gli infedeli. I veneziani aggirarono l'embargo e divennero ricchi portando ferro, legno e schiavi. I Cavalieri di Malta, paladini della purezza cattolica, ce l'avevano a morte con loro proprio per questo disinvolto pragmatismo. E non a caso i pellegrini della Terrasanta, viaggiando per mare dall'Adriatico, avevano quasi più paura dei maltesi che dei turchi. Dopo Lepanto, Venezia fece una pace separata con gli Ottomani. Troppi erano gli interessi in comune per vivere in stato di continua belligeranza. Venezia e Istanbul erano entrambe potenze marinare di Levante, e il loro nemico era lo stesso. Stava a Ponente, era l'Atlantico. Nonostante lo scuoiamento di Bragadin, la leggenda del turco demoniaco non nacque affatto a Venezia. Fu il frutto tardivo di una manipolazione romantica nordica, lontana dal Mediterraneo, e servì a giustificare lo sconfinamento degli stati-nazione verso quelle terre e quel mare. D'Annunzio disse: "La patria è sulla nave", contrabbandò la guerra come erotismo, e cominciarono i disastri.
Lussinpiccolo rimineggia, c'è un carnaio di turisti, ragazzi col gel, braghe a mezz'asta e skateboard ai piedi. "Attento ai teppisti che picchiano gli stranieri", mi avverte un barista. Un disastro, non un buco per dormire. La leggenda di Lussino, l'isola dei capitani coraggiosi, è perduta. l'unica cosa vera sono i pescherecci. Uno si chiama Andrea, che qui è nome di femmina. A bordo, pescatori con anelli pirateschi all'orecchio si passano cassette, la plancia è piena di procaci donne nude su carta. Notte sotto le stelle con rimbombo di discoteche.
Paolo Rumiz
Paolo Rumiz (Trieste, 1947) ha scritto – in gran parte per l’editore Feltrinelli – più di trenta libri, di cui molti dedicati all’esplorazione dei territori. Figlio di una delle frontiere …