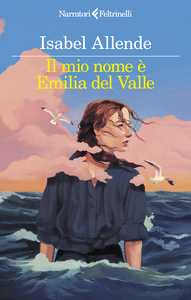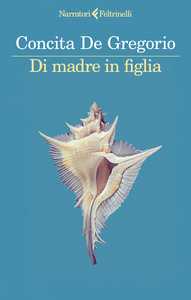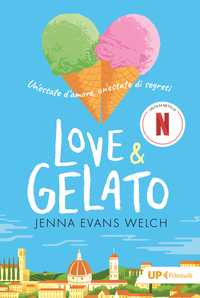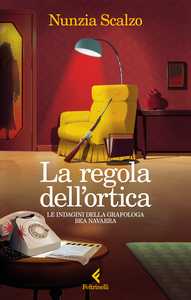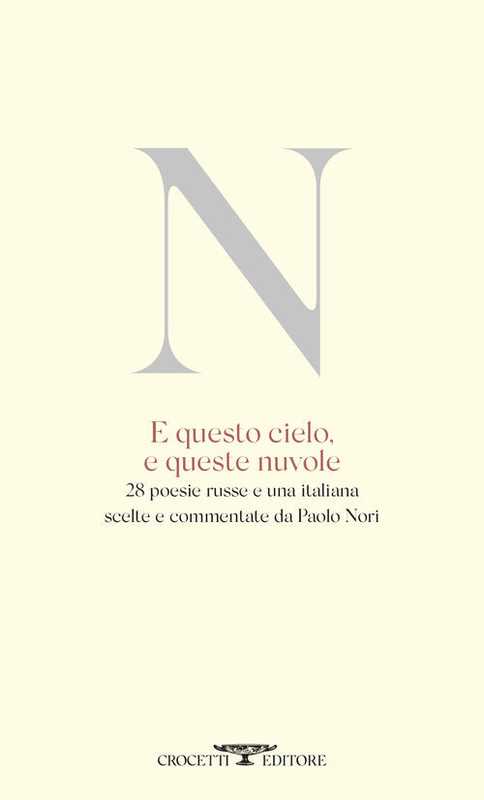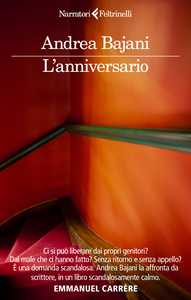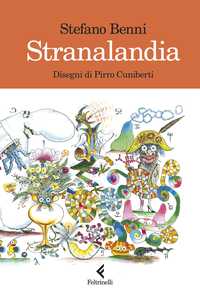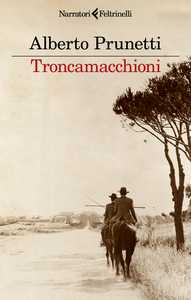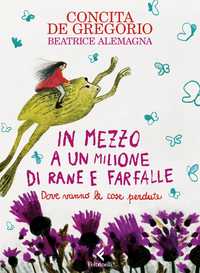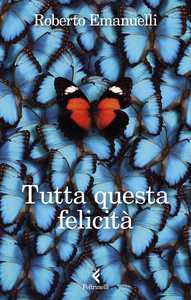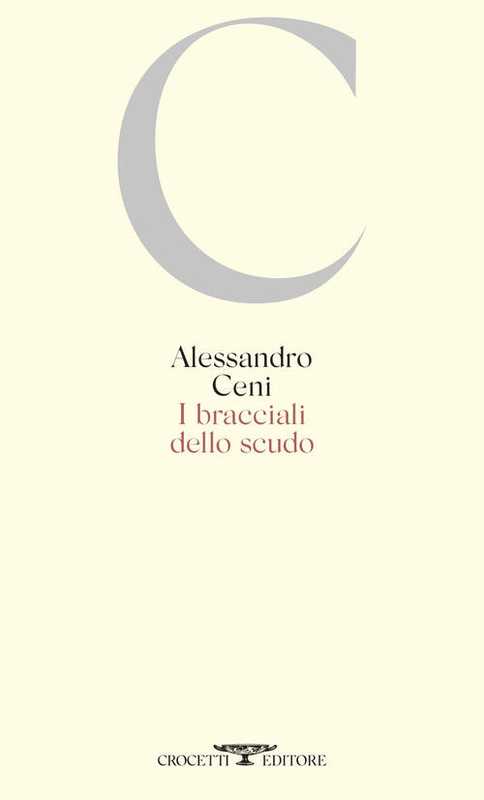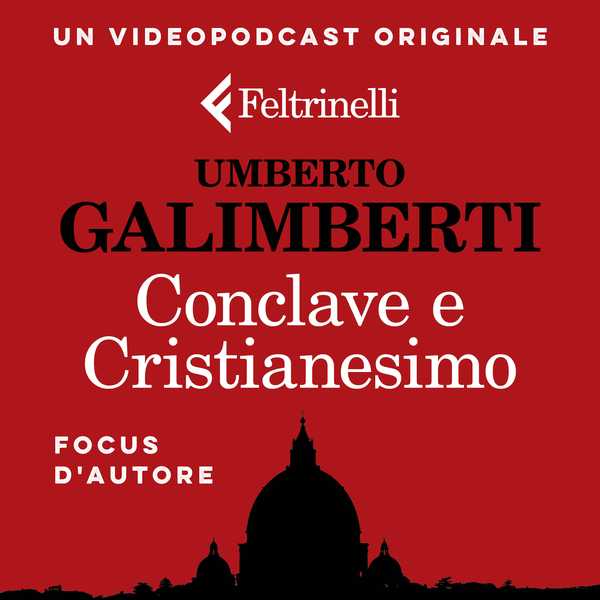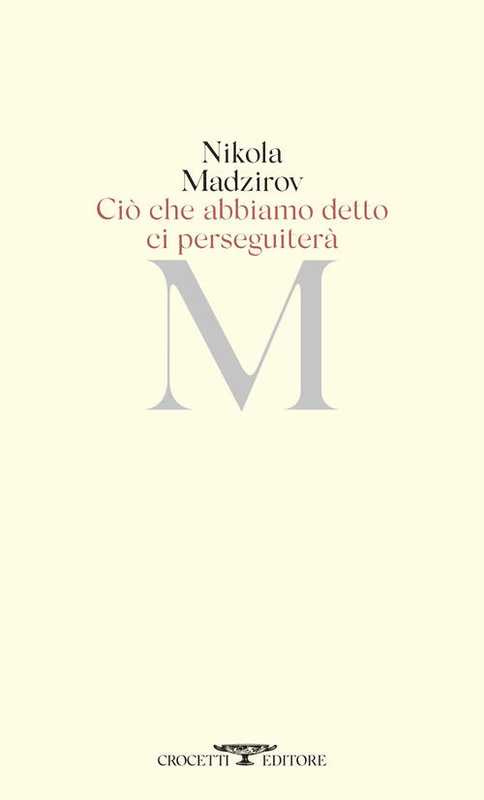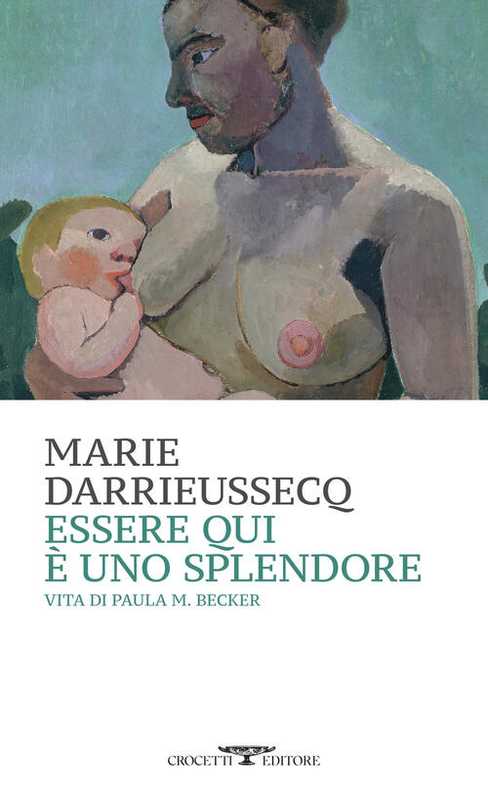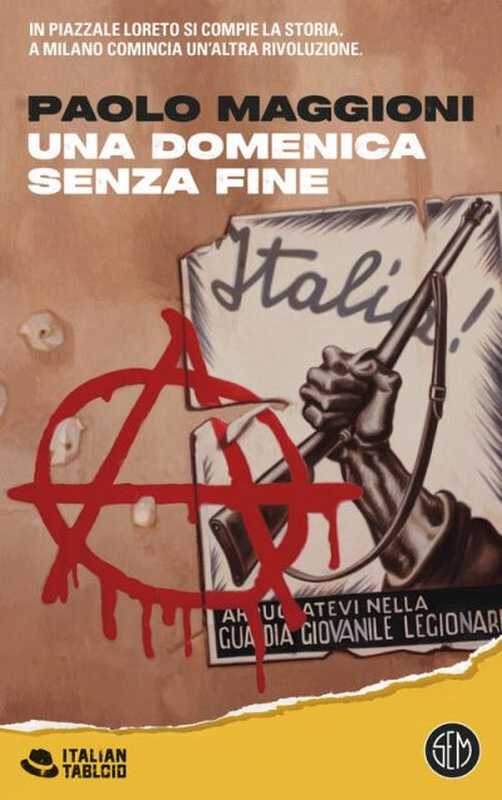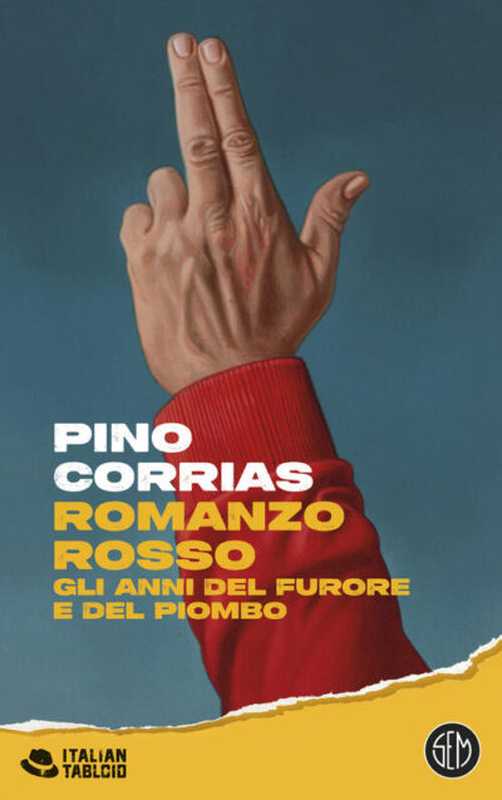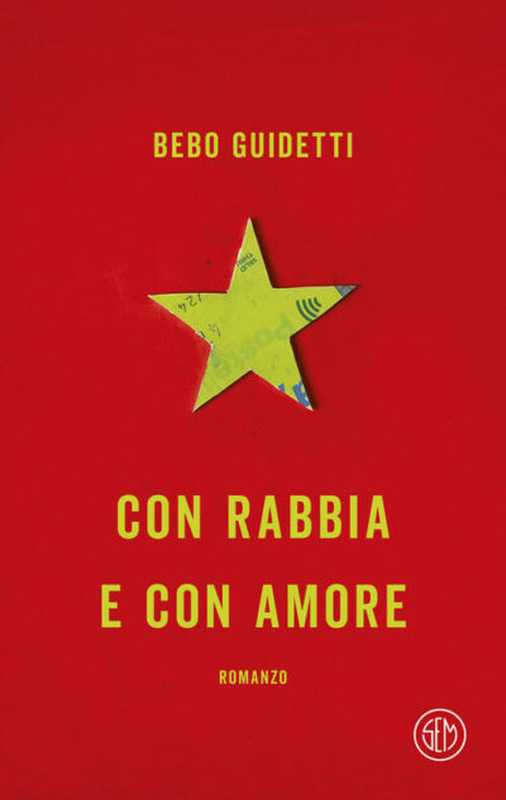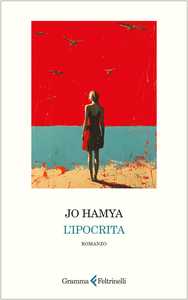Marina Forti: I mille colori di Terra madre
27 Ottobre 2004
Tutti hanno qualcosa da raccontare. Cose normali, ma in fondo straordinarie: come si addomestica la tale erba, come si raccoglie il miele di certe api "selvatiche" che fanno i loro alveari nel tronco degli alberi delle montagne dell'Anatolia orientale. Un signore venuto da Sidamo, Etiopia meridionale, ha portato sacchetti di un caffè che cresce sugli altopiani, fino a 2.000 metri sul mare: c'è il tipo da pieno sole e quello adatto all'ombra, da far crescere sotto piante da frutto - tutto rigorosamente biologico. Un gruppo di imponenti signore del Senegal mostra "campioni" di pescetti e di molluschi essiccati: hanno costruito un'impresa comune con i pescatori per lavorare il pesce e trovare sbocchi di mercato "saltando" gli intermediari. C'è chi ha allestito piccole mostre fotografiche, chi offre assaggi: marmellate di frutta di una cooperativa di piccoli produttori dell'Azerbaijan, vino biologico dell'Austria, formaggio di yak degli altopiani tibetani. Un'associazione di armeni offre pezzetti di formaggio salato insieme alla sfoglia di pane, o gherigli di noce avvolte in un foglio color vino: è una conserva essiccata di frutta. C'è la bottarga di cefalo fatta da una cooperativa di Dalyan, sulla costa della Turchia meridionale, una delle poche zone del mediterraneo dove ancora depone le uova la tartaruga marina caretta-caretta. Ci sono i raccoglitori di un'alga del lago Ciad dalle note proprietà energetiche. Qualcuno si ritrae sospettoso davanti a pezzetti biancastri, un mollusco che i maori della Nuova Zelanda chiamano paua e in America è chiamato abalone: è una grande conchiglia dai riflessi azzurrini, i nativi del Pacifico ormai hanno stabilito che ciascuno non possa raccoglierne più di dieci al giorno, ma "le grandi aziende pescherecce ne ramassano tonnellate, e si sta estinguendo", dice un giovane maori. Ciascuno dei 4.888 partecipanti alla rassegna internazionale Terra Madre, che si conclude oggi a Torino, ha qualcosa da raccontare. E lo hanno fatto, per due giorni interi, in decine di gruppi di lavoro: a volte su temi più che specifici - i "cereali minori", il formaggio a latte crudo, i mieli monoflora, i suini sostenibili, la varietà delle banane, la fermentazione del cacao, la selezione delle razze autoctone di animali da macello, e così via. Altri su questioni generali: conservare l'acqua scarsa, guarire i terreni esauriti dal troppo uno di fertilizzanti chimici, far convivere agricoltura "pesante" e "leggera", migliorare le condizioni di vita dei lavoratori agricoli.
Una rassegna di micro esempi locali che finisce per affrontare grandi questioni globali. Cerchiamo dunque di riassumerle. C'è un principio generale: Carlo Petrini, presidente dell'associazione Slow Food (che ha ideato questa rassegna e allo stesso tempo sta tenendo il Salone del Gusto, sorta di fiera campionaria del buon cibo) lo riassume nella frase "le comunità rurali sono maestre": hanno dei saperi, a volte però hanno bisogno di aiuto per conservarli migliorarli e tramandarli, per far conoscere ciò che fanno e commercializzare i prodotti in modo da trarne un giusto reddito. Qui le chiamano "comunità del cibo" per intendere gruppi che condividono non solo un'attività produttiva ma una cultura, un senso della solidarietà e della giustizia sociale. Dunque: valorizzare le comunità che producono cibo, detta con parole da Slow Food. "Riscattare la dimensione rurale dell'economia attraverso lo sviluppo delle produzioni locali e dei piccoli produttori in modo da garantire la sicurezza alimentare", per dirla con Frei Betto, coordinatore del programma "Fame Zero" del governo del Brasile (non un programma di assistenza ma di inclusione sociale, tiene a precisare).
Proteggere le economie rurali significa proteggere la diversità biologica (le tante varietà vegetali e animali), le diversità dei modi di coltivare e raccogliere e allevare e pescare. Questo è antitetico alle grandi monoculture, il "deserto verde" di cui parlava ieri il presidente dell'associazione dei coltivatori biologici dell'Argentina: "Chiamiamo così le grandi pianure in cui vedete solo soja, a perdita d'occhio: non un albero, né la rotazione con altre piante. Così l'Argentina, che aveva produzioni di grande qualità e aveva una cultura alimentare, oggi è un grande produttore di cibo ma abbiamo livelli record di malnutrizione infantile. Esportiamo in tutto il mondo soja o mais di bassa qualità, destinata al consumo del bestiame, al 90 per cento transgenico".
Per dei produttori biologici, o anche solo convenzionali, il "deserto verde" è la morte: "Non puoi coltivare isole biologiche in un mare transgenico". E Percy Schmeiser può spiegare perché: coltivatore delle grandi pianure canadesi, Schmeiser un giorno si è visto far causa dalla Monsanto, la maggiore multinazionale produttrice di sementi transgeniche, che lo accusava di usare le sue sementi di colza modificata (e brevettata) senza pagare le dovute royalties. Lui in realtà coltivava colza "normale", o così credeva, ma questa era stata impollinata dai vicini campi transgenici. La causa con Monsanto è durata sei anni, lui l'ha persa, e ne ha tratto una prima lezione sulle ambiguità dei concetti di "responsabilità legale" e una lezione più generale: "Scordatevi che le colture transgeniche possano convivere con quelle convenzionali. Non esiste "contenimento" delle coltivazioni geneticamente modificate, è impossibile impedire l'impollinazione incrociata tra specie analoghe. Introdurre varietà transgeniche significa consegnare all'industria il controllo totale delle sementi", perché conservare i semi e ripiantarli come fanno gli agricolturi da sempre sarà illegale. Nella grande varietà dei linguaggi e dei problemi, uno deve constatare che tutti si capiscano benissimo. Sarà il senso pratico dei contadini. Sarà anche il grande lavoro di "sprovincializzazione" fatto dalla Coldiretti, che di questa rassegna è una protagonista importante: garantisce l'ospitalità di circa 1.200 ospiti stranieri. Mobilitate le sezioni provinciali, le aziende agricole, agriturismo, famiglie "da Verbania a Cuneo", spiega Giorgio Albertino, dirigente della Coldiretti piemontese. "E' stato un gran lavoro perché non si tratta solo di posti letto: qui ciascuno ha anche organizzato un'accoglienza, visite per mostrare cosa facciamo, cene, feste". Una festa internazionale della terra.
Una rassegna di micro esempi locali che finisce per affrontare grandi questioni globali. Cerchiamo dunque di riassumerle. C'è un principio generale: Carlo Petrini, presidente dell'associazione Slow Food (che ha ideato questa rassegna e allo stesso tempo sta tenendo il Salone del Gusto, sorta di fiera campionaria del buon cibo) lo riassume nella frase "le comunità rurali sono maestre": hanno dei saperi, a volte però hanno bisogno di aiuto per conservarli migliorarli e tramandarli, per far conoscere ciò che fanno e commercializzare i prodotti in modo da trarne un giusto reddito. Qui le chiamano "comunità del cibo" per intendere gruppi che condividono non solo un'attività produttiva ma una cultura, un senso della solidarietà e della giustizia sociale. Dunque: valorizzare le comunità che producono cibo, detta con parole da Slow Food. "Riscattare la dimensione rurale dell'economia attraverso lo sviluppo delle produzioni locali e dei piccoli produttori in modo da garantire la sicurezza alimentare", per dirla con Frei Betto, coordinatore del programma "Fame Zero" del governo del Brasile (non un programma di assistenza ma di inclusione sociale, tiene a precisare).
Proteggere le economie rurali significa proteggere la diversità biologica (le tante varietà vegetali e animali), le diversità dei modi di coltivare e raccogliere e allevare e pescare. Questo è antitetico alle grandi monoculture, il "deserto verde" di cui parlava ieri il presidente dell'associazione dei coltivatori biologici dell'Argentina: "Chiamiamo così le grandi pianure in cui vedete solo soja, a perdita d'occhio: non un albero, né la rotazione con altre piante. Così l'Argentina, che aveva produzioni di grande qualità e aveva una cultura alimentare, oggi è un grande produttore di cibo ma abbiamo livelli record di malnutrizione infantile. Esportiamo in tutto il mondo soja o mais di bassa qualità, destinata al consumo del bestiame, al 90 per cento transgenico".
Per dei produttori biologici, o anche solo convenzionali, il "deserto verde" è la morte: "Non puoi coltivare isole biologiche in un mare transgenico". E Percy Schmeiser può spiegare perché: coltivatore delle grandi pianure canadesi, Schmeiser un giorno si è visto far causa dalla Monsanto, la maggiore multinazionale produttrice di sementi transgeniche, che lo accusava di usare le sue sementi di colza modificata (e brevettata) senza pagare le dovute royalties. Lui in realtà coltivava colza "normale", o così credeva, ma questa era stata impollinata dai vicini campi transgenici. La causa con Monsanto è durata sei anni, lui l'ha persa, e ne ha tratto una prima lezione sulle ambiguità dei concetti di "responsabilità legale" e una lezione più generale: "Scordatevi che le colture transgeniche possano convivere con quelle convenzionali. Non esiste "contenimento" delle coltivazioni geneticamente modificate, è impossibile impedire l'impollinazione incrociata tra specie analoghe. Introdurre varietà transgeniche significa consegnare all'industria il controllo totale delle sementi", perché conservare i semi e ripiantarli come fanno gli agricolturi da sempre sarà illegale. Nella grande varietà dei linguaggi e dei problemi, uno deve constatare che tutti si capiscano benissimo. Sarà il senso pratico dei contadini. Sarà anche il grande lavoro di "sprovincializzazione" fatto dalla Coldiretti, che di questa rassegna è una protagonista importante: garantisce l'ospitalità di circa 1.200 ospiti stranieri. Mobilitate le sezioni provinciali, le aziende agricole, agriturismo, famiglie "da Verbania a Cuneo", spiega Giorgio Albertino, dirigente della Coldiretti piemontese. "E' stato un gran lavoro perché non si tratta solo di posti letto: qui ciascuno ha anche organizzato un'accoglienza, visite per mostrare cosa facciamo, cene, feste". Una festa internazionale della terra.
Marina Forti
Marina Forti è inviata del quotidiano "il manifesto". Ha viaggiato a lungo in Asia meridionale e nel Sud-est asiatico. Dal 1994 cura la rubrica "TerraTerra" che riporta storie quotidiane in …