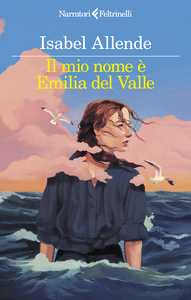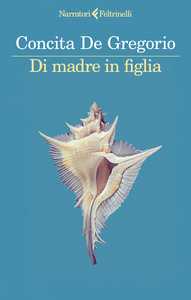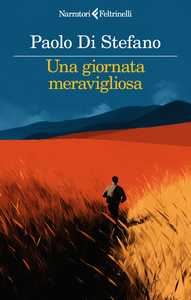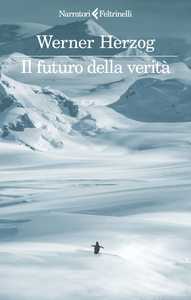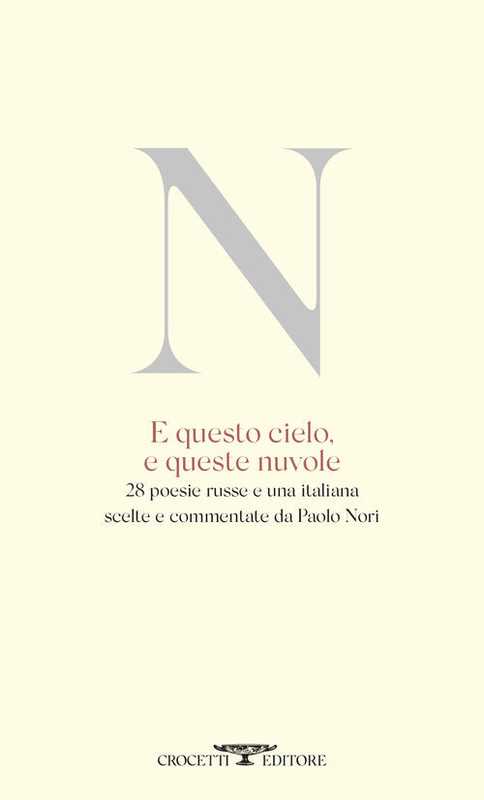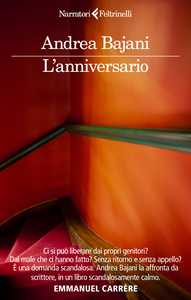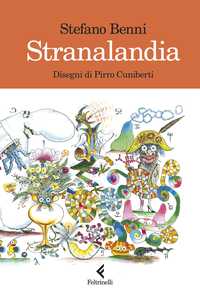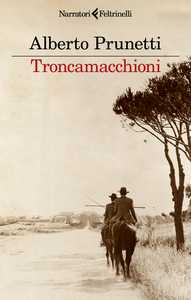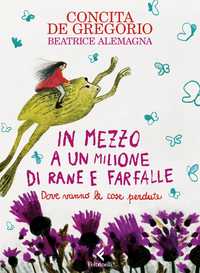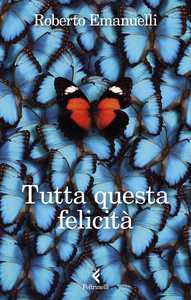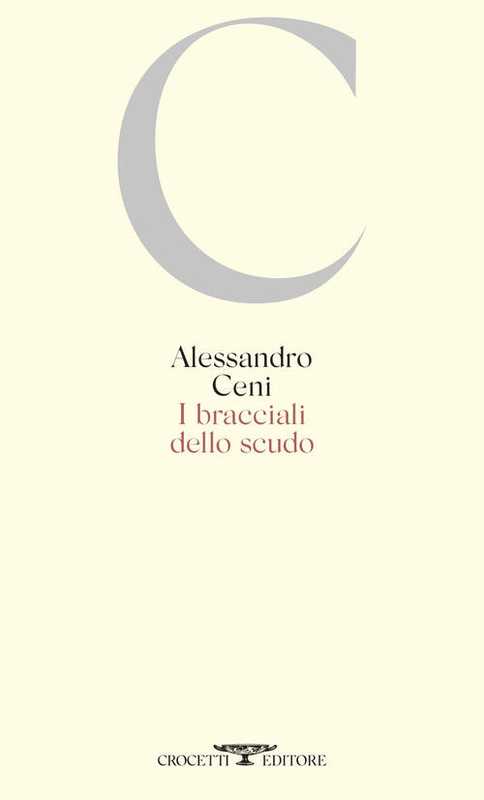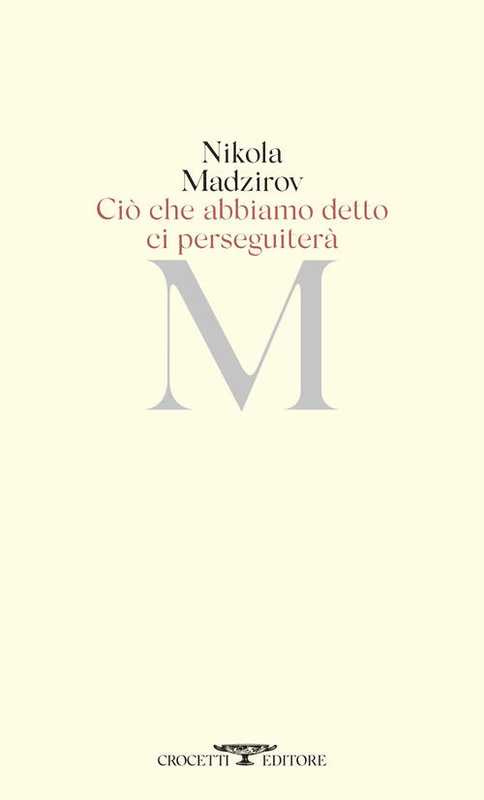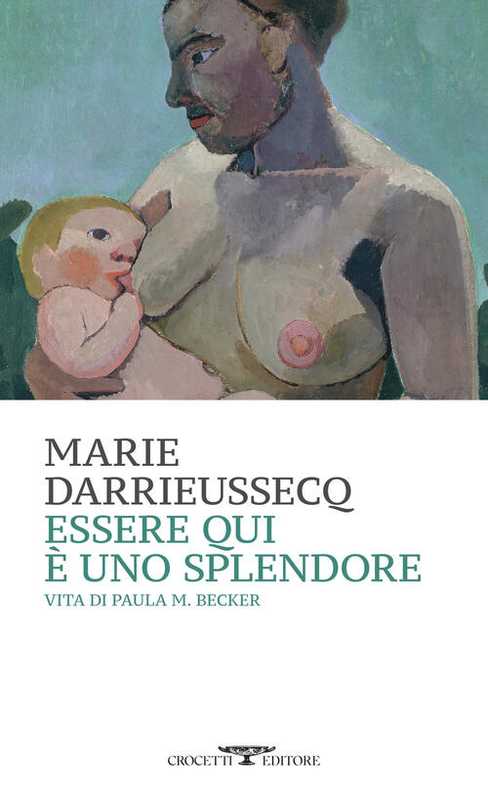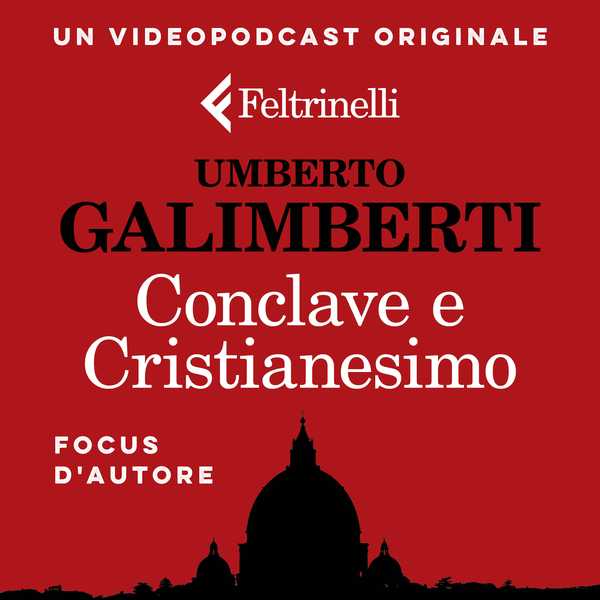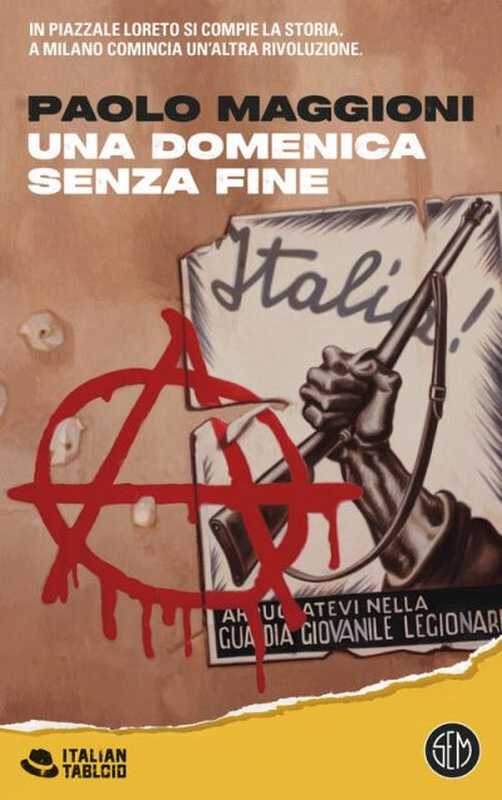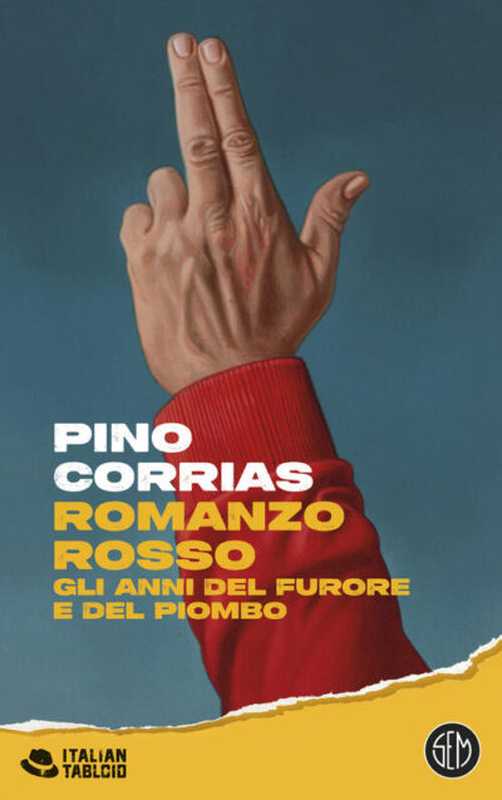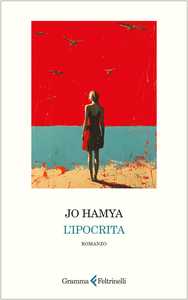Luigi Manconi - Andrea Boraschi: Contro i Pacs soltanto leggende
19 Settembre 2005
Imperversa la buriana, nel dibattito pubblico sui Pacs: e, così, si finisce per dire e scrivere qualunque cosa. Ad esempio, il Sir, il Servizio d’informazione religiosa della Cei, può diramare un comunicato in cui si legge che ‟non appare in alcun modo giustificabile incutere un ‟vulnus”, come si diceva nel linguaggio aulico, oppure più sbrigativamente uno ‟sbrego”, ad una istituzione più che millenaria come la famiglia, come elemento essenziale di civiltà e di civilizzazione, per venire incontro a rivendicazioni di persone o gruppi più o meno significativi”; e così conclude: ‟bisogna uscire una volta per tutte dalla melassa indistinta del politicamente corretto, dei casi pietosi, dei diritti dei singoli. È tempo di scelte: ognuno le faccia e se ne assuma la responsabilità storica”. Bum!, viene da dire, perché, di fronte a una intimidazione di tale calibro, siamo indotti a trascurare codardamente le nostre responsabilità epocali, mentre ci risulta più difficile ignorare ‟le rivendicazioni di persone e gruppi più o meno significativi”. E perché mai andrebbero ignorate, quelle rivendicazioni? Si pensi al semplice fatto che i diritti cui si allude non sono ‟dei singoli”, ma dei molti (le unioni di fatto sono triplicate, negli ultimi vent’anni); e che, seppure volessimo sottovalutare il dato statistico, resta - ed è l’elemento più importante - la forza, morale e simbolica, di quel diritto individuale, che in un sistema democratico é posto a fondamento dei beni comuni e delle garanzie sociali.
Altro riferimento polemico: i ‟casi pietosi”? Ma sanno di cosa parlano, questi pietosissimi e e soavemente efferati censori? Quei ‟casi”, cui forse si riferiscono, sono - spesso - un grande esempio di dignità. Si provi a considerare, a titolo di esempio, la vicenda di Adele Parrillo (raccontata da Claudia Fusani sulla ‟Repubblica” del 15 settembre), compagna di vita di Stefano Rolla, regista, vittima con altre 18 persone dell’attentato alla caserma italiana di Nassiriya. Una donna che, quel 12 novembre 2003, non fu neppure avvisata della morte del suo uomo; che non venne invitata alle cerimonie di commemorazione previste per le vittime; che non riceverà le donazioni destinate ai familiari; che non viene riconosciuta, in nulla e per nulla, quale parte essenziale di ciò che sopravvive alla morte della persona amata. Adele Parrillo, che con Stefano Rolla aveva congelato cinque embrioni per avere un figlio, e che aveva progettato di sposarsi a breve: la sua famiglia, quella unione, per lo stato e per la vita pubblica di questo paese semplicemente non è mai esistita. Strano o pietoso o crudele che sia, è proprio così.
E, infine, lasciamo perdere ‟la melassa”, che poi melassa non è: non necessariamente. A rispondere per le rime, senza tentazioni retoriche di alcun genere, ci pensa Mario Fortunato (‟il Riformista” del 15 settembre). Che dice, molto semplicemente, che non ha alcuna voglia di ‟mettersi col cappello in mano, per pietire il riconoscimento giuridico della propria condizione di convivente more uxorio con un individuo del medesimo sesso”; tantomeno ha voglia di stare a polemizzare con Mastella o con il Vaticano. Propone un patto allo Stato italiano: che si continui pure a discriminare giuridicamente la sua famiglia di fatto, ma che lo si esenti dal pagare le tasse. Ovvero quei contributi fiscali attraverso i quali le ‟altre” famiglie godono di diritti e garanzie che alla sua sono negati.
Ma la questione, evidentemente, è molto più ampia delle risposte che si possono dare a un comunicatino di un’agenzia di stampa. E riguarda, piuttosto, l’esistenza di un ‟fatto” (sì, ‟le coppie di fatto sono un ‟fatto”‟, come ricorda il cardinale Pompedda), che, con il semplice proporsi all’attenzione pubblica, segnala un vuoto normativo. Ovvero esiste una articolata fattispecie di dinamiche relazionali, che comportano ricadute sociali rilevantissime e che non sono riconosciute, in alcun modo, dal nostro ordinamento. Chi si ostina a ritenere la famiglia immutabile e ‟naturale”, compiuta e conclusa nel matrimonio (meglio se religioso), non sa fare i conti con la storia, con l’antropologia culturale, con i mutamenti in atto, segnalati da molte ricerche sociali. E, soprattutto, non considera che i cambiamenti che ‟minacciano” quel modello non vengono tanto da fattori ‟esterni”, quali la domanda di riconoscimento avanzata dalle coppie omosessuali o le istanze in favore della riproduzione assistita; piuttosto, ‟i cambiamenti più importanti - come ricorda Chiara Saraceno - sono avvenuti all’interno della famiglia ‟normale”, nei rapporti eterosessuali e di generazione”. Perché sono venuti meno i rapporti gerarchici sui quali quella ‟normalità” tradizionalmente si fondava; perché la sessualità è di fatta scollegata dalla riproduzione, come quest’ultima lo è dal matrimonio; perché la fragilità dei rapporti di coppia ha determinato una sostanziale ridefinizione dei confini della famiglia, mutando radicalmente l’esperienza della genitorialità quanto quella dell’essere figli, e indebolendo i rapporti di sangue in favore di rapporti elettivi; perché, infine, l’allungamento della vita media comporta profondi cambiamenti nei rapporti tra generazioni, dove le relazioni di responsabilità, di solidarietà e di assistenza, all’interno del nucleo familiare, appaiono maggiormente articolate, sovrapposte, intrecciate.
Tuttavia queste osservazioni - ragionevolissime e documentatissime - sarebbero superflue, in questa sede, se il dibattito sulla proposta di istituzione dei Patti civili di solidarietà non fosse stato indirizzato, strumentalmente, verso questioni estranee alle sue premesse e alla sua sostanza. Come un imputato che, innocente, si trovi dinanzi a un giudice che gli chiede perché ha commesso il reato di cui lo si accusa (anziché domandargli se quel reato lo ha effettivamente commesso), così noi vorremmo rifiutarci di dover sostenere queste tesi: perché, per quanto esse siano motivitissime, rispondono ad una accusa fasulla, che va negata all’origine. I Pacs, così come proposti nel nostro Paese, nulla hanno a che fare con il grado di tenuta sociale della famiglia tradizionale. Non la minacciano e non la ‟sbregano” in alcun modo. Propongono, semplicemente, l’allargamento del numero di cittadini garantiti da alcuni diritti: che sono una parte di quelli attualmente riconosciuti a due persone che contraggono matrimonio. Chi promuove una visione ‟esclusivizzante” di quei diritti (‟Vuoi usufruirne? Sposati!”), fraintende la sostanza stessa delle libertà cui essi sono preposti. Quella sostanza è ‟positiva”, tende a essere universale e generale. Se è vero che l’esercizio di un diritto non può condurre alla violazione di un altro diritto (da qui il principio della ‟coesistenza dei diritti”), è altresì vero che i diritti ‟sono tra di loro solidali, fanno insieme sistema; nessuno può essere sacrificato col pretesto di arrivare, mediante questo sacrificio, all’appagamento degli altri” (Giuseppe Capograssi). Ecco, esemplarmente, un caso in cui si rispettano entrambe le condizioni: riconoscere diritti ai cittadini impegnati in una convivenza duratura e solidale non minaccia i diritti di alcun altro. Per contro, riconoscere quei diritti vuol dire promuovere quel principio di mutualità appena ricordato, ‟fare sistema”, ridurre le disparità, garantire tutela e possibilità di convivenza: oltre che tra due persone, tra i cittadini tutti.
Altro riferimento polemico: i ‟casi pietosi”? Ma sanno di cosa parlano, questi pietosissimi e e soavemente efferati censori? Quei ‟casi”, cui forse si riferiscono, sono - spesso - un grande esempio di dignità. Si provi a considerare, a titolo di esempio, la vicenda di Adele Parrillo (raccontata da Claudia Fusani sulla ‟Repubblica” del 15 settembre), compagna di vita di Stefano Rolla, regista, vittima con altre 18 persone dell’attentato alla caserma italiana di Nassiriya. Una donna che, quel 12 novembre 2003, non fu neppure avvisata della morte del suo uomo; che non venne invitata alle cerimonie di commemorazione previste per le vittime; che non riceverà le donazioni destinate ai familiari; che non viene riconosciuta, in nulla e per nulla, quale parte essenziale di ciò che sopravvive alla morte della persona amata. Adele Parrillo, che con Stefano Rolla aveva congelato cinque embrioni per avere un figlio, e che aveva progettato di sposarsi a breve: la sua famiglia, quella unione, per lo stato e per la vita pubblica di questo paese semplicemente non è mai esistita. Strano o pietoso o crudele che sia, è proprio così.
E, infine, lasciamo perdere ‟la melassa”, che poi melassa non è: non necessariamente. A rispondere per le rime, senza tentazioni retoriche di alcun genere, ci pensa Mario Fortunato (‟il Riformista” del 15 settembre). Che dice, molto semplicemente, che non ha alcuna voglia di ‟mettersi col cappello in mano, per pietire il riconoscimento giuridico della propria condizione di convivente more uxorio con un individuo del medesimo sesso”; tantomeno ha voglia di stare a polemizzare con Mastella o con il Vaticano. Propone un patto allo Stato italiano: che si continui pure a discriminare giuridicamente la sua famiglia di fatto, ma che lo si esenti dal pagare le tasse. Ovvero quei contributi fiscali attraverso i quali le ‟altre” famiglie godono di diritti e garanzie che alla sua sono negati.
Ma la questione, evidentemente, è molto più ampia delle risposte che si possono dare a un comunicatino di un’agenzia di stampa. E riguarda, piuttosto, l’esistenza di un ‟fatto” (sì, ‟le coppie di fatto sono un ‟fatto”‟, come ricorda il cardinale Pompedda), che, con il semplice proporsi all’attenzione pubblica, segnala un vuoto normativo. Ovvero esiste una articolata fattispecie di dinamiche relazionali, che comportano ricadute sociali rilevantissime e che non sono riconosciute, in alcun modo, dal nostro ordinamento. Chi si ostina a ritenere la famiglia immutabile e ‟naturale”, compiuta e conclusa nel matrimonio (meglio se religioso), non sa fare i conti con la storia, con l’antropologia culturale, con i mutamenti in atto, segnalati da molte ricerche sociali. E, soprattutto, non considera che i cambiamenti che ‟minacciano” quel modello non vengono tanto da fattori ‟esterni”, quali la domanda di riconoscimento avanzata dalle coppie omosessuali o le istanze in favore della riproduzione assistita; piuttosto, ‟i cambiamenti più importanti - come ricorda Chiara Saraceno - sono avvenuti all’interno della famiglia ‟normale”, nei rapporti eterosessuali e di generazione”. Perché sono venuti meno i rapporti gerarchici sui quali quella ‟normalità” tradizionalmente si fondava; perché la sessualità è di fatta scollegata dalla riproduzione, come quest’ultima lo è dal matrimonio; perché la fragilità dei rapporti di coppia ha determinato una sostanziale ridefinizione dei confini della famiglia, mutando radicalmente l’esperienza della genitorialità quanto quella dell’essere figli, e indebolendo i rapporti di sangue in favore di rapporti elettivi; perché, infine, l’allungamento della vita media comporta profondi cambiamenti nei rapporti tra generazioni, dove le relazioni di responsabilità, di solidarietà e di assistenza, all’interno del nucleo familiare, appaiono maggiormente articolate, sovrapposte, intrecciate.
Tuttavia queste osservazioni - ragionevolissime e documentatissime - sarebbero superflue, in questa sede, se il dibattito sulla proposta di istituzione dei Patti civili di solidarietà non fosse stato indirizzato, strumentalmente, verso questioni estranee alle sue premesse e alla sua sostanza. Come un imputato che, innocente, si trovi dinanzi a un giudice che gli chiede perché ha commesso il reato di cui lo si accusa (anziché domandargli se quel reato lo ha effettivamente commesso), così noi vorremmo rifiutarci di dover sostenere queste tesi: perché, per quanto esse siano motivitissime, rispondono ad una accusa fasulla, che va negata all’origine. I Pacs, così come proposti nel nostro Paese, nulla hanno a che fare con il grado di tenuta sociale della famiglia tradizionale. Non la minacciano e non la ‟sbregano” in alcun modo. Propongono, semplicemente, l’allargamento del numero di cittadini garantiti da alcuni diritti: che sono una parte di quelli attualmente riconosciuti a due persone che contraggono matrimonio. Chi promuove una visione ‟esclusivizzante” di quei diritti (‟Vuoi usufruirne? Sposati!”), fraintende la sostanza stessa delle libertà cui essi sono preposti. Quella sostanza è ‟positiva”, tende a essere universale e generale. Se è vero che l’esercizio di un diritto non può condurre alla violazione di un altro diritto (da qui il principio della ‟coesistenza dei diritti”), è altresì vero che i diritti ‟sono tra di loro solidali, fanno insieme sistema; nessuno può essere sacrificato col pretesto di arrivare, mediante questo sacrificio, all’appagamento degli altri” (Giuseppe Capograssi). Ecco, esemplarmente, un caso in cui si rispettano entrambe le condizioni: riconoscere diritti ai cittadini impegnati in una convivenza duratura e solidale non minaccia i diritti di alcun altro. Per contro, riconoscere quei diritti vuol dire promuovere quel principio di mutualità appena ricordato, ‟fare sistema”, ridurre le disparità, garantire tutela e possibilità di convivenza: oltre che tra due persone, tra i cittadini tutti.
Luigi Manconi
Luigi Manconi insegna Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università IULM di Milano. È parlamentare e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato. Tra i suoi libri …