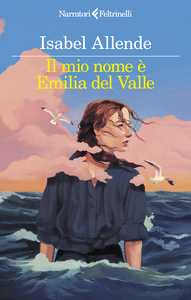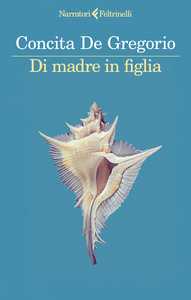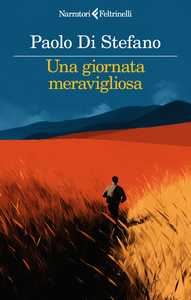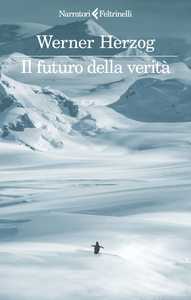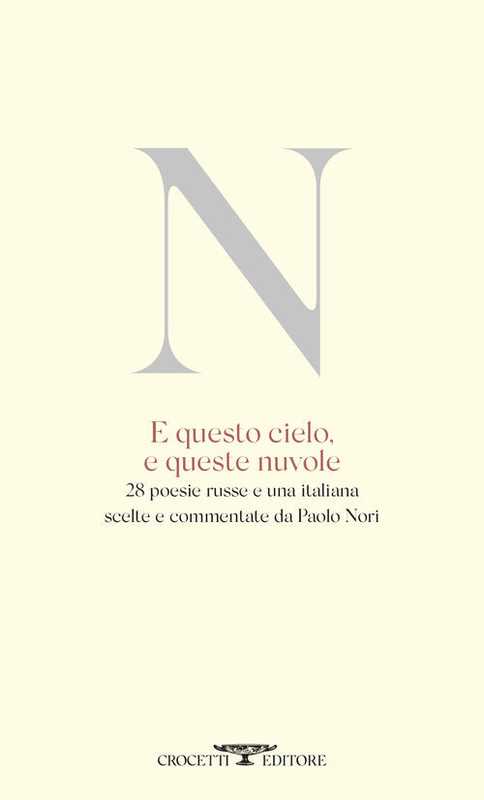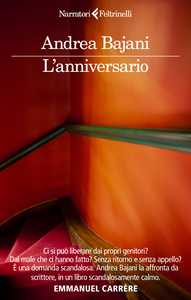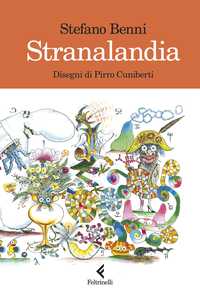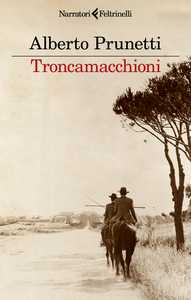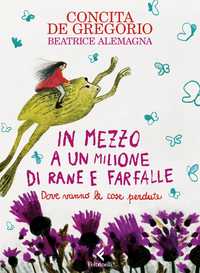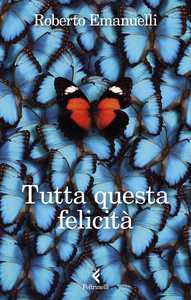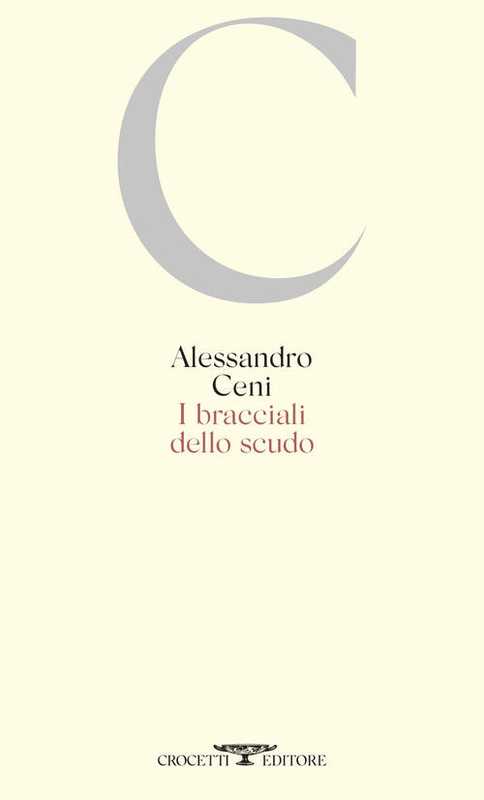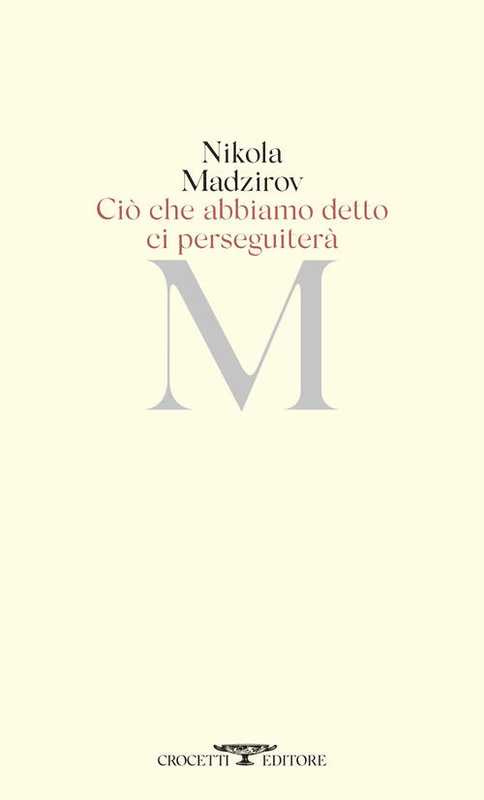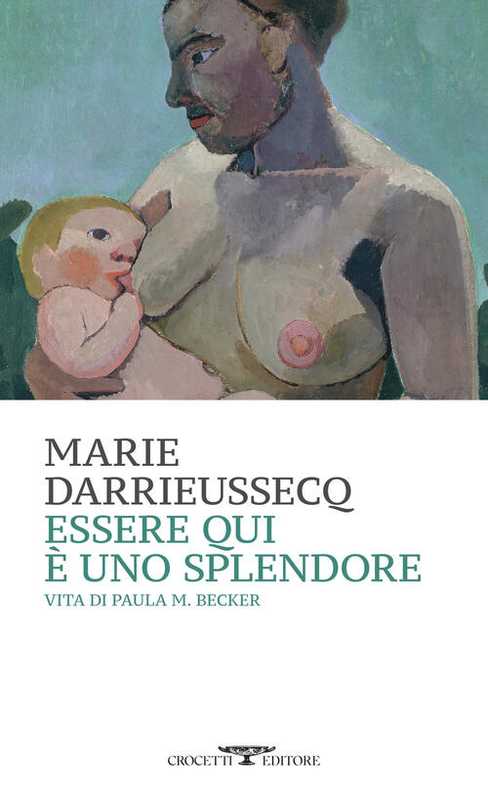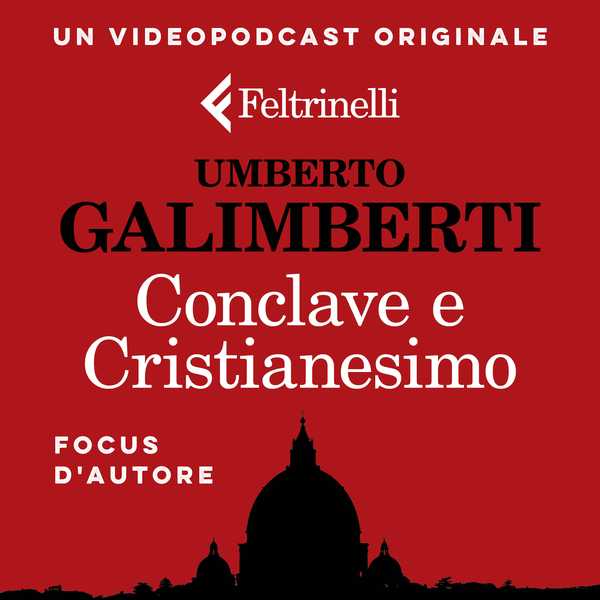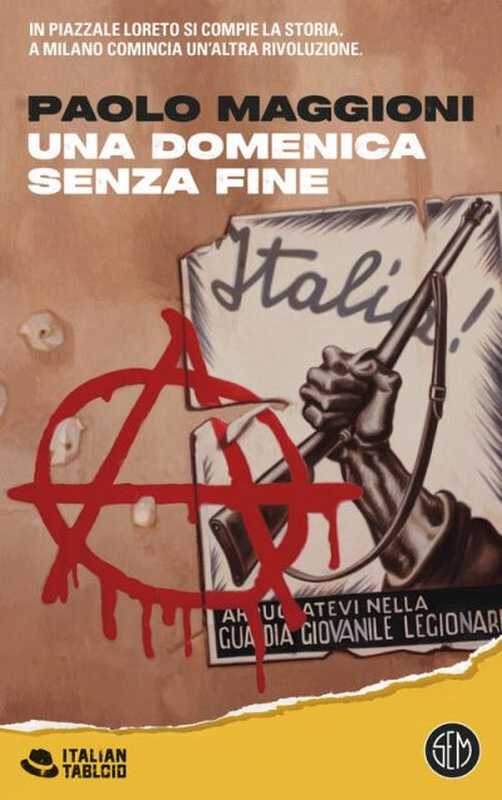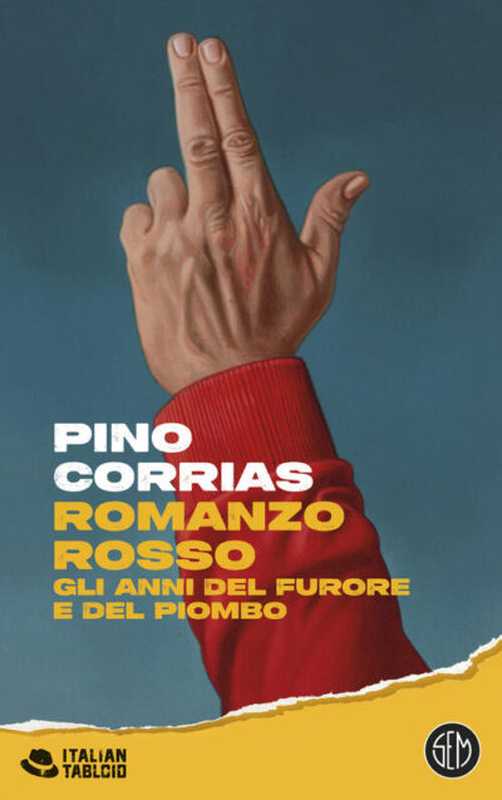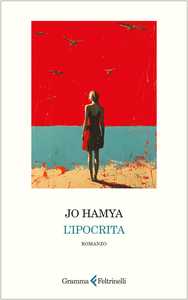Beppe Sebaste: Resistere ai mass-kitsch
20 Marzo 2006
‟Gli antichi sapevano quello che la nostra civilta tecnologica sembra aver dimenticato: vedere giusto. Sembrano aver conosciuto l’effetto propizio alla visione della pittura, del passaggio dalla luce alla penombra, per gustare le sue sottigliezze tonali: grotte, templi, chiese lo testimoniano (
) Si sa che la variazione del livello luminoso modifica la sensazione cromatica (
) e i pittori hanno sempre saputo che la visione giusta’ esige un'illuminazione minore, un cielo coperto o l’apertura di una finestra che si affaccia a nord-nordest (
) Le gallerie di quadri come quella di Rubens, e i musei concepiti e costruiti nel corso del XIX secolo hanno seguito questa regola (
) ma oggi la gran parte dei musei e gallerie snaturano la percezione della pittura. La luce artificiale, il cui spettro è incompleto rispetto alla luce naturale, sregola le grandezze colorimetriche e le tonalità cromatiche. Ci coglie un senso di incertezza di fronte ai quadri in una sala a illuminazione mista, sotto la quale ci si sentirà frustrati nella sensazione visiva e incapaci di identificare e quindi di apprezzare l’accordo di un giallo freddo con un giallo caldo. Vedere un Bonnard a luce mista è vederlo falso”. A scrivere è un grande pittore contemporaneo, già commissario al Louvre per mostre di Ingres e Poussin, e intimo amico dello scrittore Samuel Beckett. Mi piace proporle alla nostra attenzione alienata e assente in periodo per di piu elettorale, il peggiore per le sfumature e per cose ‟inutili” e inattuali come la pittura o la musica. A Parigi, in casa di una poetessa americana e del pittore citato, dopo l'ennesima domanda col sorriso sulla bocca sul nostro venditore di tappeti nazionale (c’era anche il regista di una storica messa in scena di Finale di partita, la profezia è stata quindi facile) si è parlato di arte. Ciò di cui non si parla è invece è il sopravvivere della politica-spettacolo, della retorica pubblicitaria, della sciatteria culturale, della perdita della possibilità di fare esperienze diverse da quelle volute dai mezzi di distrazione di massa. Quanto dello svuotamento della cultura nella sua specificità di alterità e lentezza ha già impregnato le nostre sensibilità e abitudini? Le parole riportate sopra sembrano estreme, ma sono concrete. Cosa vediamo quando vediamo (e quando compriamo, pagando il biglietto) ‟l’arte”? Rispetto alle grandi questioni politiche, certo essa impallidisce. Ma come direbbe Avigdor Arikha, ‟dipingere un pomodoro di fronte all'eroismo sembra irrisorio, non dipingerlo sarebbe rinunciare all'arte”.
Beppe Sebaste
Beppe Sebaste (Parma, 1959) è conoscitore di Rousseau e dello spirito elvetico, anche per la sua attività di ricerca nelle università di Ginevra e Losanna. Con Feltrinelli ha pubblicato Café …