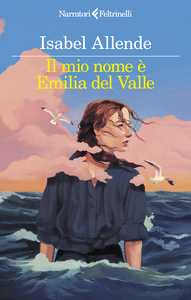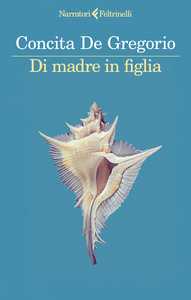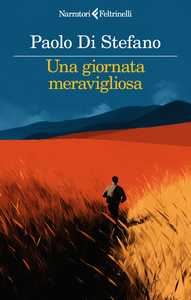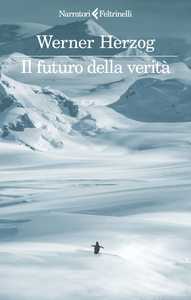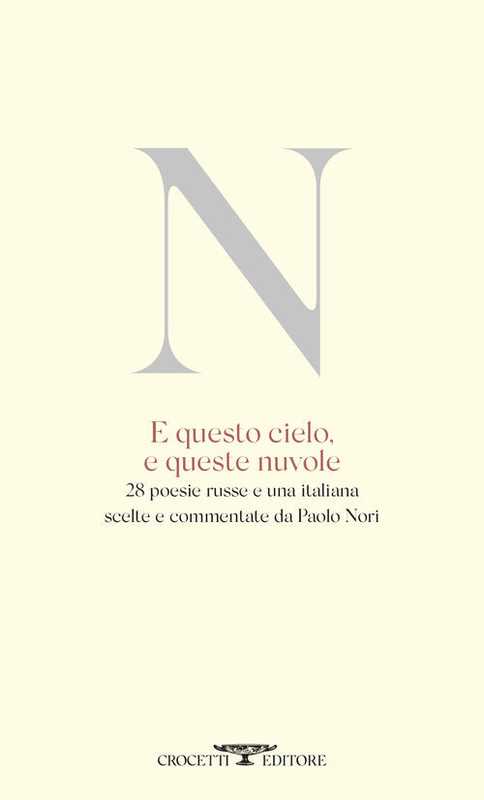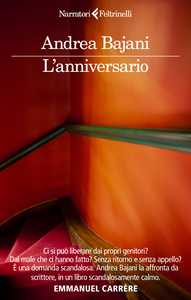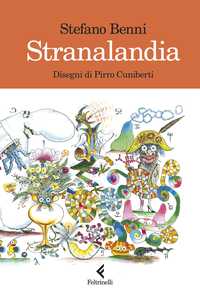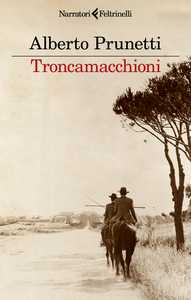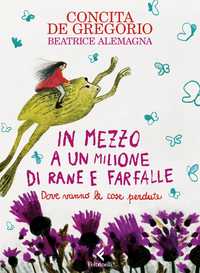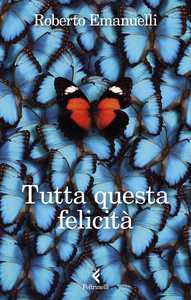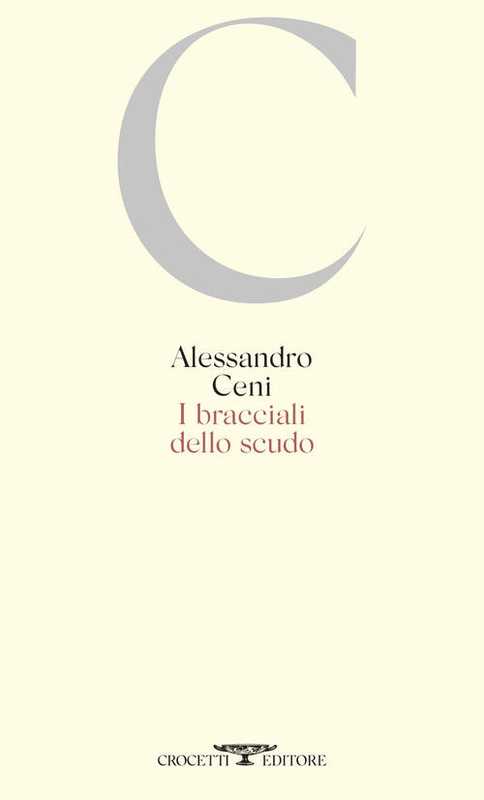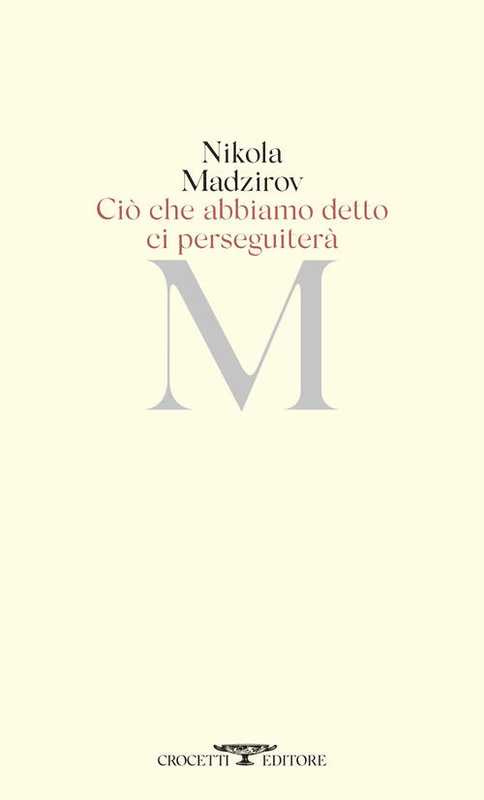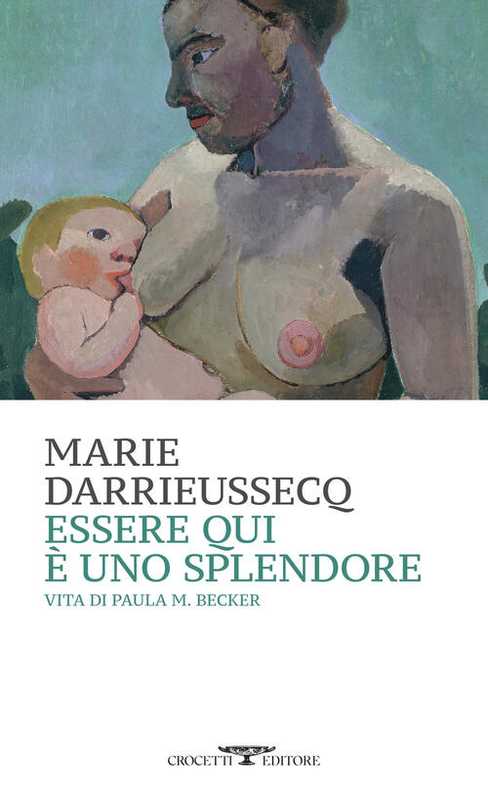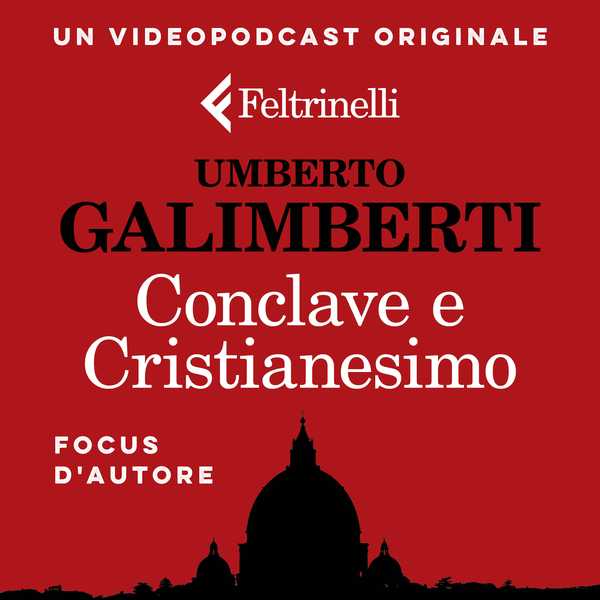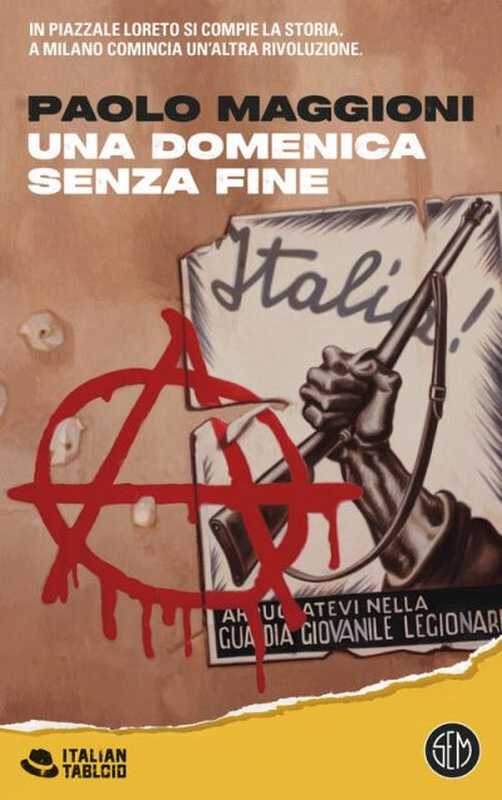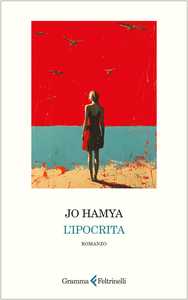Eva Cantarella: Il dio Visnu diventò una tartaruga e così riuscì a salvare il mondo
29 Maggio 2006
Che sia a causa del suo aspetto preistorico? Difficile saperlo. Quel che è certo è che la tartaruga, per noi piccolo, innocuo, non particolarmente attraente animale, ha un ruolo tutt’altro che secondario nelle più antiche storie di creazione del mondo. Più specificamente, nel mito indiano che racconta la lotta tra i Deva (dei della luce) e gli Asura (demoni della notte) per impossessarsi del soma (o amrita), la bevanda che dava l’immortalità. Durante il diluvio, infatti, essa era sparita, insieme a tutte le altre cose terrestri e celesti. Deva e Asura, in competizione, volevano recuperarlo, ciascuno a proprio beneficio. Ma per farlo era necessario ‟frullare” la materia primordiale, il mare di latte (sul quale, prima che il mondo avesse inizio, galleggiava un bianco fiore di loto). Come procedere? Usando il monte Mandara come bastone per mescolare - si decise - e servendosi del serpente gigante Vasuki come corda, a un’estremità della quale stavano gli dei, all’altra i demoni. Senonché la montagna, pesantissima, rischiava, perforandola, di fare a pezzi la Terra. Ed ecco, a questo punto, fare la sua comparsa il dio Visnu, che, trasformandosi in un’enorme tartaruga, la tartaruga Kurma, fornì una solida base al monte e al mondo. Ma la tartaruga non compare solo nel mito indiano. Anche se in forma e in ruolo diverso, è presente anche in quello greco, dove si presenta in vesti a noi più familiari: la piccola, timida, a noi familiare tartaruga dei prati. Più modesta, ma, di nuovo, legata a un racconto di fondazione, nel quale è associata al dio Ermes. Figlio di Zeus e di Maia, Ermes - come racconta uno degli Inni omerici - mostra dalla nascita un carattere singolarissimo: anziché restare nella sua culla, come tutti i neonati, si alza per passeggiare su un prato, dove si imbatte in una tartaruga. E subito pensa a come utilizzarla: ‟amica dall’amabile aspetto, le dice, ti porterò a casa, in qualche modo mi sarai utile..”. E utile fu, la tartaruga, non solo a Ermes, ma all’umanità: armato di una lama di ferro, dopo aver estratto la polpa dal guscio, l’intraprendente neonato taglia nella giusta misura steli di canna, li infigge nel guscio dell’animale, tende tutt’intorno una pelle di bue, fissa due bracci, li congiunge con una traversa, tende sette corde di interiora di pecora, in armonia fra loro, e infine, col plettro, saggia le corde: lo strumento, dice il poeta, emette un suono prodigioso, che Ermes accompagna con il canto. Nato all’aurora, a mezzogiorno il prodigioso infante suona la lira, termine che nell’Inno si alterna a phorminx, kitharys, e chelys, vale a dire, appunto, tartaruga. Sin qui i miti. Ma la tartaruga interessa anche scrittori di ogni genere: in particolare Eliano, vissuto a cavallo tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo e autore di una monumentale opera su ‟La natura degli animali”. Non sempre critico sulle informazioni che raccoglie e tramanda, Eliano descrive abitudini e caratteristiche delle tartarughe che lasciano a dir poco perplessi: ma almeno uno degli aneddoti, che coinvolge una tartaruga, va di necessità ricordato. Le aquile, racconta Eliano, per poter mangiare la carne delle tartarughe terrestri le afferrano e le scagliano su una roccia per romperne il guscio. E così accadde che un giorno una tartaruga, dall’alto, scambiò la testa lucida di Eschilo, completamente calva, per uno spunzone di roccia, e vi scagliò la sua preda. Una morte non particolarmente gloriosa, per il maggior tragico greco: ma un’occasione, per la tartaruga, per essere ricordata nei manuali di storia della letteratura. Oltre che, come è ben noto, grazie al celebre paradosso di Zenone, in quelli di filosofia: Achille, diceva Zenone, per quanto veloce, non potrà mai raggiungere la tartaruga, lentissima, che lo precede. Zenone infatti, membro della scuola eleatica, negava il divenire e il movimento: lo spazio, diceva, è divisibile in infiniti frammenti. Per quanto Achille avanzi, avrà sempre da percorrere la metà di un frammento di spazio, che gli impedirà di raggiungere la tartaruga. Grazie a Zenone, la povera tartaruga sconfigge "il pieveloce".
Eva Cantarella
Eva Cantarella ha insegnato Diritto romano e Diritto greco all’Università di Milano ed è global visiting professor alla New York University Law School. Tra le sue opere ricordiamo: Norma e sanzione …