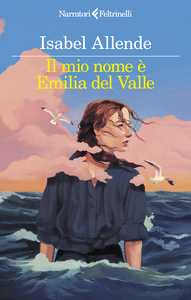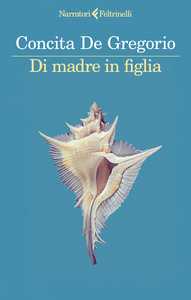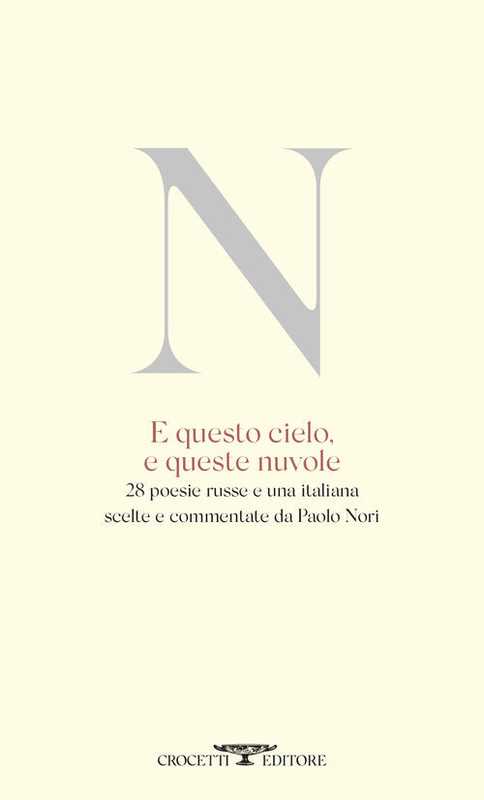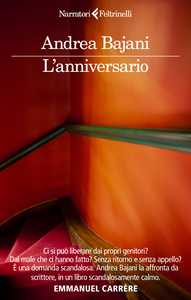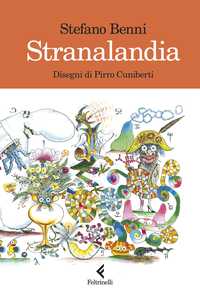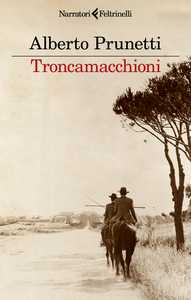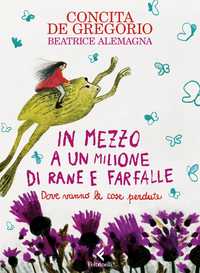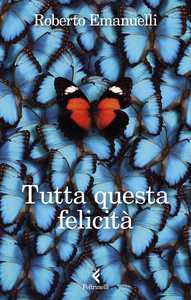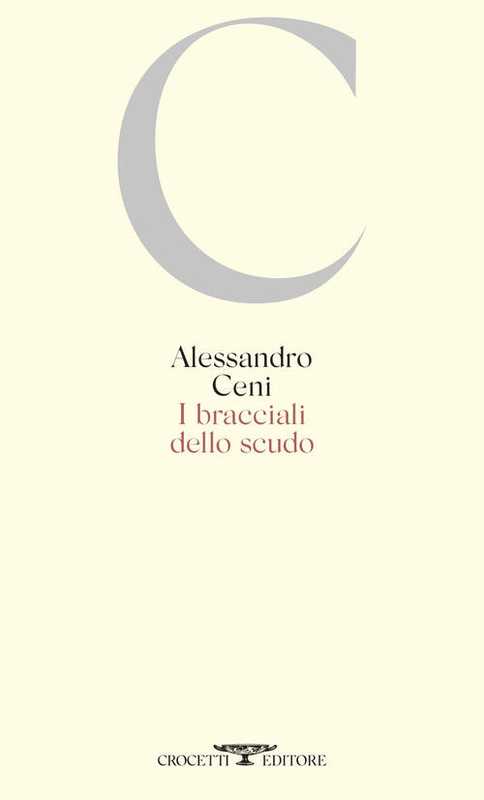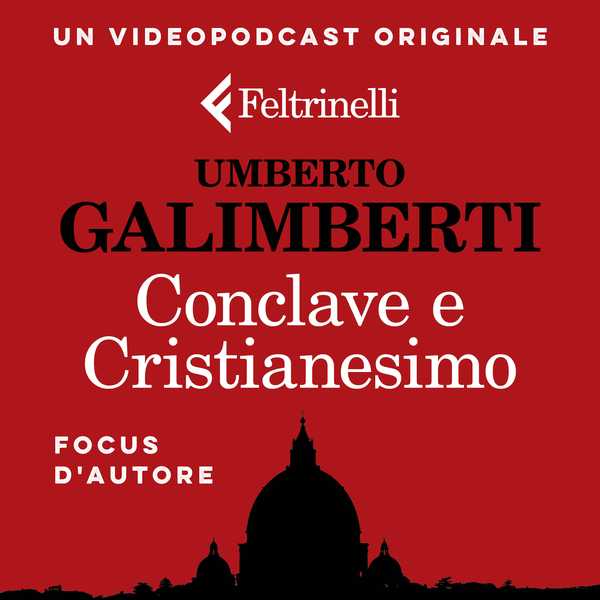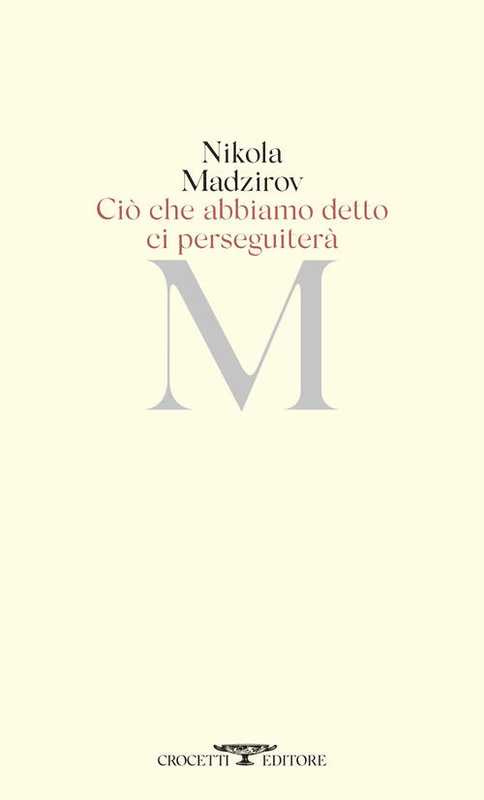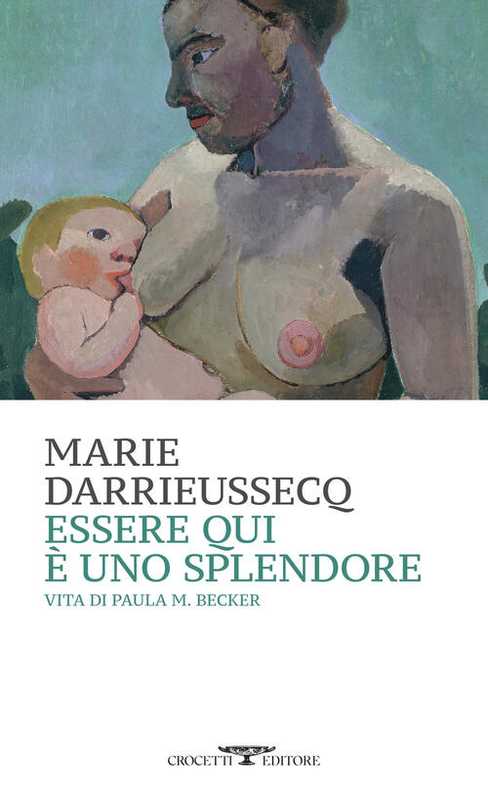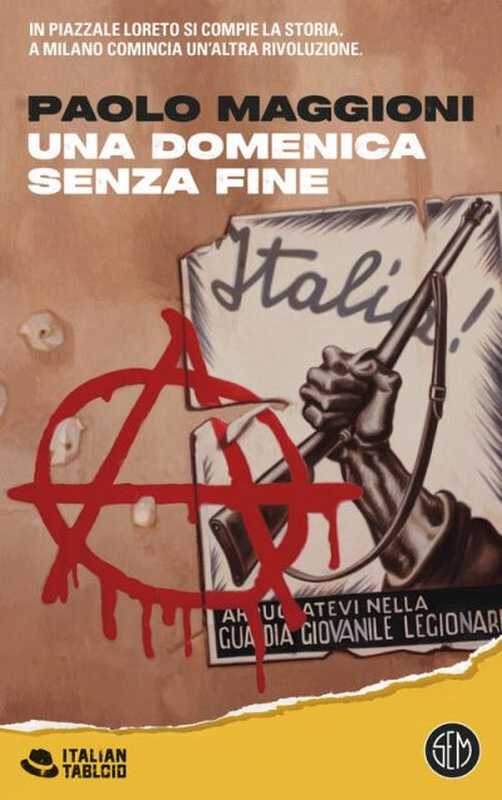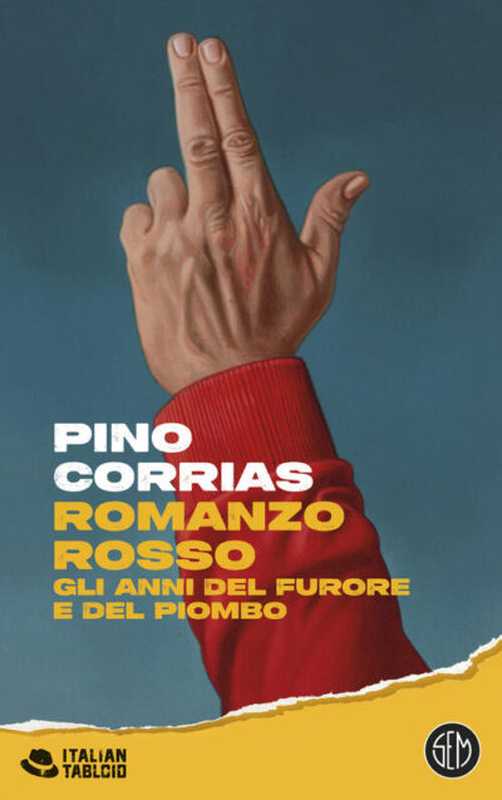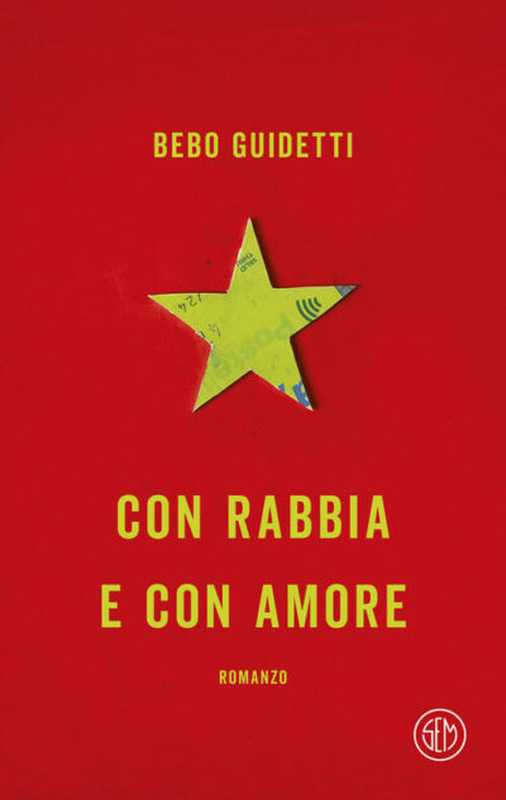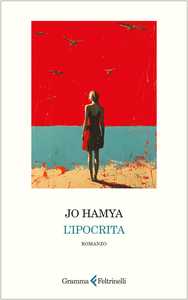Marina Forti: Afghanistan. L'impossibile convivenza tra civile e militare
21 Novembre 2006
La strada è sbarrata da blocchi di cemento che costringono i veicoli a rallentare e fare uno slalom, una guardia armata protetta da sacchi di sabbia sta di guardia a un cancello, altre guardie (e barriere di sacchi di terra) all'interno. È l'ingresso al Prt italiano, il Provincial Recontruction Team (Team di ricostruzione provinciale) di Herat, capitale dell'omonima provincia dell'Afghanistan occidentale e punto di riferimento della regione occidentale, quattro province, circa un terzo del paese. Gli sbarramenti, certo, hanno la loro utilità: lo scorso aprile il Prt italiano è stato preso di mira da un attacco suicida; l'esplosione ha fatto due vittime oltre all'attentatore (entrambe afghane, la guardia esterna e un passante) ma solo pochi danni materiali all'interno, vetri rotti per il botto (hanno ferito un tecnico della cooperazione) e poco altro. L'attentato al Prt italiano è rimasto per ora isolato, altri 4 attacchi invece hanno preso di mira convogli militari (di cui 2 italiani) fuori città: in confronto alla zona di Kabul, si può ben dire che Herat è tranquilla.
Il punto è che in quel recinto di muri e filo spinato convivono i militari dell'Esercito italiano e i civili della Cooperazione italiana, e a questi ultimi la convivenza sta decisamente stretta: tanto che chiedono la separazione, perché l'intervento civile e quello militare siano ben distinguibili. I militari sono circa 230, gli addetti della Cooperazione sono 5. Nell'ambito della missione Nato-Isaf (‟Forza internazionale di stabilizzazione dell'Afghanistan”), il contingente italiano ha il comando della regione ovest dell'Afghanistan, che fa capo a Herat; l'esercito italiano ha qui circa 750 persone, distribuite tra il Prt, una base all'aereoporto (sede del supporto logistico e del Comando regionale), e una terza base poco più a nord. Il Prt è la ‟missione di ricostruzione e sviluppo”, per usare il linguaggio dell'esercito; in quel recinto stanno uffici, alloggi, magazzini, e i servizi: infermeria, palestra, spaccio, mensa, la ‟pizzeria” (è il luogo della convivialità, con il bar, la tv e i tavolini all'aperto).
I militari non escono per la città in libera uscita, sarebbe contrario alle norme. E i civili? Di giorno escono a fare il proprio lavoro, solo se scortati da militari armati e con i vincoli di tempo dettati dalle regole militari; quando sono liberi non escono, neppure loro, se non in rare occasioni e solo con scorta militare: motivi di sicurezza.
Decisamente, la convivenza sta stretta ai cooperanti. Non hanno nulla contro i militari, lo ripetono: ‟Però ciascuno deve avere il suo ruolo”, dice Mario Barberini, coordinatore del settore costruzioni, nella palazzina del Prt che ospita gli uffici di quei 5 civili (un capo-progetto, un diplomatico e tre esperti di settore: costruzioni, sanità, acqua). ‟Il comando Isaf si rende conto che la presenza civile è importante per conquistare la fiducia della popolazione. Ma se accompagnata dai militari, la cooperazione cambia volto", dice l'ambasciatore Carlo Ungaro, consigliere diplomatico della Cooperazione: ‟La presenza militare crea diffidenza tra la popolazione”. ‟Il nostro obiettivo è separare la cooperazione dall'esercito”, continua Barberini.
L'ambiguità ‟civile-militare”
È questo che gli operatori della Cooperazione italiana di Herat sono andati a dire alla viceministro degli esteri Patrizia Sentinelli, quando ha visitato Kabul alla fine di settembre (sono volati là apposta: sembra che non sia stato possibile arrangiare un volo militare per portare la viceministro nella città dove il contingente italiano ha la sua base). In quell'occasione il gruppo ha proposto una ‟separazione consensuale”, chiedono di trasferirsi fuori dal recinto attuale del Prt, in un edificio adeguato. ‟Con questo non si mette in discussione il Prt”, fa notare Barberini, ma si evita la commistione di militare e civile. D'altra parte, aggiunge, è quanto indica una mozione approvata dal parlamento italiano in occasione del voto sulla legge di finanziamento della missione in Afghanistan, che impegna il governo a separare la missione di cooperazione civile da quella militare.
Si potrebbe osservare che l'ambiguità sta nella natura stessa dei ‟Team di ricostruzione provinciale”, strutture militari-civili create dall'esercito degli Stati uniti nell'ambito della missione Enduring Freedom fin del 2002, secondo un modello sperimentato a suo tempo in Vietnam (i team sono ‟composti da personale internazionale civile e militare che opera al fine di estendere sul territorio l'autorità del governo afghano e di facilitare lo sviluppo e la ricostruzione”). Più tardi i Prt sono stati inglobati dalla missione Isaf che dal 2003 è affidata formalmente alla Nato, e sono stati estesi a tutto il paese.
Il Prt di Herat è stato creato nel 2005 quando l'Italia ha assunto il comando di questa regione. In teoria ha un responsabile civile e uno militare ‟alla pari”; di fatto è una struttura integrata sotto comando militare. Come negli altri Prt sparsi in Afghanistan, l'ambiguità è tanto maggiore perché il Prt non associa i civili alle attività di ricostruzione: di quella si occupano i militari con la propria struttura di ‟r&d”, ricostruzione e sviluppo (in ambito Nato si chiama Cimic, Cooperazione civile-militare), in cui ci sono tecnici e ingegneri dell'esercito che si incaricano di costruire ponti, scuole e altro.
L'esercito ha speso 3,3 milioni nel 2005 e 5,3 milioni per il 2006 per interventi che vanno dalla costruzione di scuole e ambulatori allo scavo di pozzi artesiani in villaggi remoti (li definiscono progetti ‟quick impact”, di realizzazione rapida).
La Cooperazione civile (che dipende dal Ministero degli esteri) è del tutto a sé e segue le sue priorità, con progetti più a lungo termine: scuole, distribuzione di acqua potabile (acquedotti e allacci) in aree sia urbane che rurali, opere di assistenza sociale (stanno costruento un orfanotrofio femminile e un centro per ciechi), e soprattutto un intervento di sostegno per riabilitare l'ospedale regionale di Herat - lavoro appena all'inizio, anche se la Cooperazione italiana ci punta molto, proprio come ha fatto a Kabul con l'ospedale pubblico Esteqlal.
La cooperazione ha stanziato finora 8 milioni di euro per l'intervento civile nella regione di Herat, 3 milioni per il 2004 e 5 per il 2006: del budget 2004 però è stato speso finora solo il 27%, e questo riflette la difficoltà di movimento dei cooperanti civili ‟ingabbiati” nel Prt.
‟Mai incontrato ostilità”
Il presupposto per la cooperazione ‟è avere un buon rapporto con i civili: se non ci sono condizioni di sicurezza, manca il presupposto”, sostiene a Kabul Pietro De Carli, capo del programma di emergenza della Cooperazione italiana in Afghanistan: si occupa di tutto l'intervento umanitario del governo italiano (escluso il Prt di Herat). L'ho incontrato nell'ufficio della Cooperazione italiana a Kabul, in una normalissima zona residenziale della capitale afghana.
Uffici a pianoterra e alloggi al primo piano, e un muro di cinta come ogni casa di classe media: a parte un poliziotto afghano di guardia, non ci sono particolari fortificazioni. ‟In quattro anni non abbiamo mai avuto una manifestazione di ostilità, ovunque abbiamo lavorato. Qui siamo vulnerabili, sono convinto che gli antigovernativi sappiano chi siamo e dove siamo. Se non ci è mai successo nulla forse è perché hanno calcolato che non gli conviene rendersi ostili alla popolazione che beneficia dei nostri progetti”.
Il confronto è stridente: a Herat la cooperazione è obbligata a muoversi sotto scorta e ha movimenti limitati; a Kabul lavora in tutta autonomia, come anche nel progetto stradale che collega Maydan Shar a Bamyan. Anche De Carli è convinto che la cooperazione civile non deve sovrapporsi ai contingenti militari: ‟Il loro ruolo non è in discussione ma è diverso dal nostro”. E poi, dice, occorre verificare l'efficacia della cooperazione, dice, ovvero l'incidenza dei fondi rivolti ai beneficiari rispetto ai costi di esercizio: ‟nel nostro lavoro il 95% dei fondi in loco sono spesi nei progetti, cioè va ai beneficiari. La cooperazione civile costa meno, per gli effetti ottenuti, rispetto a quella fatta con il Prt”.
‟Il vulcano Iraq”
Certo, le condizioni generali del lavoro in Afghanistan sono peggiorate: ‟Quando abbiamo cominciato a lavorare qui nel 2003 avevamo una libertà di movimento oggi impensabile”, fa notare De Carli. All'inizio la Cooperazione italiana lavorava in 9 province afghane, incluse quelle di Kandahar nel sud e di Khost, Nangahar e Paktya nell'est del paese, al confine con il Pakistan; ‟col tempo abbiamo limitato le nostre attività a 2 province, Kabul e Baghlan”, spiega De Carli (Herat è un capitolo a sé). Il motivo? ‟In parte il problema della sicurezza, che ha reso off limits le province del sud e dell'est, ma anche il calo dei finanziamenti”, che in effetti sono crollati (vedi il box in questa pagina).
Il lavoro umanitario subisce i contraccolpi del ‟vulcano Iraq”, dice De Carli: ‟Lo chiamo così perché quello che succede in Iraq manda onde d'urto fino a qui, alimenta tensioni e ostilità verso l'occidente. E ha fatto sì che la comunità internazionale destinasse più risorse alle operazioni militari, pensando di sconfiggere così il terrorismo, e meno alla ricostruzione e all'assistenza umanitaria e sociale”. Per conquistare la fiducia degli afghani (‟i cuori e le menti”, dicono gli americani), le forze Isaf-Nato hanno invece puntato sui Prt: la ‟cooperazione militare”. Ma il modello non funziona.
Le Organizzazioni non governative italiane presenti in Afghanistan hanno rifiutato di lavorare nella provincia di Herat proprio per non stare sotto la protezione militare. E non solo Emergency, che in ogni caso conduce i suoi tre ospedali in modo del tutto indipendente dalla Cooperazione e dal governo italiano, ma anche le Ong che invece lavorano con finanziamenti pubblici (per lo più europei o multilaterali): Intersos, Cesvi, Coopi, Aispo e Alisei.
Per le Ong il punto è chiarissimo: se lavorassero nell'ambito del Prt sarebbero viste come parte integrante dell'intervento (militare) italiano e perderebbero la neutralità che è elemento essenziale dell'azione umanitaria - lo hanno detto e ripetuto pubblicamente. Per la Cooperazione, che è parte del Ministero degli esteri, dunque un'espressione del governo italiano, l'intervento civile va comunque distinto da quello in divisa: è in parte una questione di efficacia, come dice De Carli, e una questione di etica: ‟Ai militari spetta difendere le condizioni di pace e sicurezza, ai civili gestire progetti umanitari e di cooperazione”. Non si può entrare in una scuola o in ospedale scortati dai mitra...
Il punto è che in quel recinto di muri e filo spinato convivono i militari dell'Esercito italiano e i civili della Cooperazione italiana, e a questi ultimi la convivenza sta decisamente stretta: tanto che chiedono la separazione, perché l'intervento civile e quello militare siano ben distinguibili. I militari sono circa 230, gli addetti della Cooperazione sono 5. Nell'ambito della missione Nato-Isaf (‟Forza internazionale di stabilizzazione dell'Afghanistan”), il contingente italiano ha il comando della regione ovest dell'Afghanistan, che fa capo a Herat; l'esercito italiano ha qui circa 750 persone, distribuite tra il Prt, una base all'aereoporto (sede del supporto logistico e del Comando regionale), e una terza base poco più a nord. Il Prt è la ‟missione di ricostruzione e sviluppo”, per usare il linguaggio dell'esercito; in quel recinto stanno uffici, alloggi, magazzini, e i servizi: infermeria, palestra, spaccio, mensa, la ‟pizzeria” (è il luogo della convivialità, con il bar, la tv e i tavolini all'aperto).
I militari non escono per la città in libera uscita, sarebbe contrario alle norme. E i civili? Di giorno escono a fare il proprio lavoro, solo se scortati da militari armati e con i vincoli di tempo dettati dalle regole militari; quando sono liberi non escono, neppure loro, se non in rare occasioni e solo con scorta militare: motivi di sicurezza.
Decisamente, la convivenza sta stretta ai cooperanti. Non hanno nulla contro i militari, lo ripetono: ‟Però ciascuno deve avere il suo ruolo”, dice Mario Barberini, coordinatore del settore costruzioni, nella palazzina del Prt che ospita gli uffici di quei 5 civili (un capo-progetto, un diplomatico e tre esperti di settore: costruzioni, sanità, acqua). ‟Il comando Isaf si rende conto che la presenza civile è importante per conquistare la fiducia della popolazione. Ma se accompagnata dai militari, la cooperazione cambia volto", dice l'ambasciatore Carlo Ungaro, consigliere diplomatico della Cooperazione: ‟La presenza militare crea diffidenza tra la popolazione”. ‟Il nostro obiettivo è separare la cooperazione dall'esercito”, continua Barberini.
L'ambiguità ‟civile-militare”
È questo che gli operatori della Cooperazione italiana di Herat sono andati a dire alla viceministro degli esteri Patrizia Sentinelli, quando ha visitato Kabul alla fine di settembre (sono volati là apposta: sembra che non sia stato possibile arrangiare un volo militare per portare la viceministro nella città dove il contingente italiano ha la sua base). In quell'occasione il gruppo ha proposto una ‟separazione consensuale”, chiedono di trasferirsi fuori dal recinto attuale del Prt, in un edificio adeguato. ‟Con questo non si mette in discussione il Prt”, fa notare Barberini, ma si evita la commistione di militare e civile. D'altra parte, aggiunge, è quanto indica una mozione approvata dal parlamento italiano in occasione del voto sulla legge di finanziamento della missione in Afghanistan, che impegna il governo a separare la missione di cooperazione civile da quella militare.
Si potrebbe osservare che l'ambiguità sta nella natura stessa dei ‟Team di ricostruzione provinciale”, strutture militari-civili create dall'esercito degli Stati uniti nell'ambito della missione Enduring Freedom fin del 2002, secondo un modello sperimentato a suo tempo in Vietnam (i team sono ‟composti da personale internazionale civile e militare che opera al fine di estendere sul territorio l'autorità del governo afghano e di facilitare lo sviluppo e la ricostruzione”). Più tardi i Prt sono stati inglobati dalla missione Isaf che dal 2003 è affidata formalmente alla Nato, e sono stati estesi a tutto il paese.
Il Prt di Herat è stato creato nel 2005 quando l'Italia ha assunto il comando di questa regione. In teoria ha un responsabile civile e uno militare ‟alla pari”; di fatto è una struttura integrata sotto comando militare. Come negli altri Prt sparsi in Afghanistan, l'ambiguità è tanto maggiore perché il Prt non associa i civili alle attività di ricostruzione: di quella si occupano i militari con la propria struttura di ‟r&d”, ricostruzione e sviluppo (in ambito Nato si chiama Cimic, Cooperazione civile-militare), in cui ci sono tecnici e ingegneri dell'esercito che si incaricano di costruire ponti, scuole e altro.
L'esercito ha speso 3,3 milioni nel 2005 e 5,3 milioni per il 2006 per interventi che vanno dalla costruzione di scuole e ambulatori allo scavo di pozzi artesiani in villaggi remoti (li definiscono progetti ‟quick impact”, di realizzazione rapida).
La Cooperazione civile (che dipende dal Ministero degli esteri) è del tutto a sé e segue le sue priorità, con progetti più a lungo termine: scuole, distribuzione di acqua potabile (acquedotti e allacci) in aree sia urbane che rurali, opere di assistenza sociale (stanno costruento un orfanotrofio femminile e un centro per ciechi), e soprattutto un intervento di sostegno per riabilitare l'ospedale regionale di Herat - lavoro appena all'inizio, anche se la Cooperazione italiana ci punta molto, proprio come ha fatto a Kabul con l'ospedale pubblico Esteqlal.
La cooperazione ha stanziato finora 8 milioni di euro per l'intervento civile nella regione di Herat, 3 milioni per il 2004 e 5 per il 2006: del budget 2004 però è stato speso finora solo il 27%, e questo riflette la difficoltà di movimento dei cooperanti civili ‟ingabbiati” nel Prt.
‟Mai incontrato ostilità”
Il presupposto per la cooperazione ‟è avere un buon rapporto con i civili: se non ci sono condizioni di sicurezza, manca il presupposto”, sostiene a Kabul Pietro De Carli, capo del programma di emergenza della Cooperazione italiana in Afghanistan: si occupa di tutto l'intervento umanitario del governo italiano (escluso il Prt di Herat). L'ho incontrato nell'ufficio della Cooperazione italiana a Kabul, in una normalissima zona residenziale della capitale afghana.
Uffici a pianoterra e alloggi al primo piano, e un muro di cinta come ogni casa di classe media: a parte un poliziotto afghano di guardia, non ci sono particolari fortificazioni. ‟In quattro anni non abbiamo mai avuto una manifestazione di ostilità, ovunque abbiamo lavorato. Qui siamo vulnerabili, sono convinto che gli antigovernativi sappiano chi siamo e dove siamo. Se non ci è mai successo nulla forse è perché hanno calcolato che non gli conviene rendersi ostili alla popolazione che beneficia dei nostri progetti”.
Il confronto è stridente: a Herat la cooperazione è obbligata a muoversi sotto scorta e ha movimenti limitati; a Kabul lavora in tutta autonomia, come anche nel progetto stradale che collega Maydan Shar a Bamyan. Anche De Carli è convinto che la cooperazione civile non deve sovrapporsi ai contingenti militari: ‟Il loro ruolo non è in discussione ma è diverso dal nostro”. E poi, dice, occorre verificare l'efficacia della cooperazione, dice, ovvero l'incidenza dei fondi rivolti ai beneficiari rispetto ai costi di esercizio: ‟nel nostro lavoro il 95% dei fondi in loco sono spesi nei progetti, cioè va ai beneficiari. La cooperazione civile costa meno, per gli effetti ottenuti, rispetto a quella fatta con il Prt”.
‟Il vulcano Iraq”
Certo, le condizioni generali del lavoro in Afghanistan sono peggiorate: ‟Quando abbiamo cominciato a lavorare qui nel 2003 avevamo una libertà di movimento oggi impensabile”, fa notare De Carli. All'inizio la Cooperazione italiana lavorava in 9 province afghane, incluse quelle di Kandahar nel sud e di Khost, Nangahar e Paktya nell'est del paese, al confine con il Pakistan; ‟col tempo abbiamo limitato le nostre attività a 2 province, Kabul e Baghlan”, spiega De Carli (Herat è un capitolo a sé). Il motivo? ‟In parte il problema della sicurezza, che ha reso off limits le province del sud e dell'est, ma anche il calo dei finanziamenti”, che in effetti sono crollati (vedi il box in questa pagina).
Il lavoro umanitario subisce i contraccolpi del ‟vulcano Iraq”, dice De Carli: ‟Lo chiamo così perché quello che succede in Iraq manda onde d'urto fino a qui, alimenta tensioni e ostilità verso l'occidente. E ha fatto sì che la comunità internazionale destinasse più risorse alle operazioni militari, pensando di sconfiggere così il terrorismo, e meno alla ricostruzione e all'assistenza umanitaria e sociale”. Per conquistare la fiducia degli afghani (‟i cuori e le menti”, dicono gli americani), le forze Isaf-Nato hanno invece puntato sui Prt: la ‟cooperazione militare”. Ma il modello non funziona.
Le Organizzazioni non governative italiane presenti in Afghanistan hanno rifiutato di lavorare nella provincia di Herat proprio per non stare sotto la protezione militare. E non solo Emergency, che in ogni caso conduce i suoi tre ospedali in modo del tutto indipendente dalla Cooperazione e dal governo italiano, ma anche le Ong che invece lavorano con finanziamenti pubblici (per lo più europei o multilaterali): Intersos, Cesvi, Coopi, Aispo e Alisei.
Per le Ong il punto è chiarissimo: se lavorassero nell'ambito del Prt sarebbero viste come parte integrante dell'intervento (militare) italiano e perderebbero la neutralità che è elemento essenziale dell'azione umanitaria - lo hanno detto e ripetuto pubblicamente. Per la Cooperazione, che è parte del Ministero degli esteri, dunque un'espressione del governo italiano, l'intervento civile va comunque distinto da quello in divisa: è in parte una questione di efficacia, come dice De Carli, e una questione di etica: ‟Ai militari spetta difendere le condizioni di pace e sicurezza, ai civili gestire progetti umanitari e di cooperazione”. Non si può entrare in una scuola o in ospedale scortati dai mitra...
Marina Forti
Marina Forti è inviata del quotidiano "il manifesto". Ha viaggiato a lungo in Asia meridionale e nel Sud-est asiatico. Dal 1994 cura la rubrica "TerraTerra" che riporta storie quotidiane in …