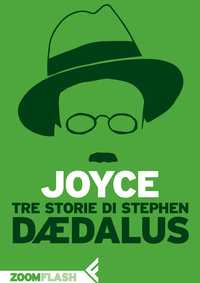James Joyce: l'esordio narrativo
Dall'Introduzione di Enrico Terrinoni a "Tre storie di Stephen Dædalus" di James Joyce
Ma tornando al merito di queste short stories; se non sono proprio, com’è evidente, narrazioni biografiche lineari, esse acquistano molto del loro interesse proprio sotto le lenti della necessità, per Joyce, di raccontare sempre e solo la propria storia: qualcosa che non lo abbandonerà mai, neanche nelle prove più ardite.
In una luce simile stupisce, e in certi casi può persino irritare, il fatto che i tre brevi racconti siano stati studiati (a dire il vero soprattutto il primo, per le evidenti distanze dalla versione poi inclusa in Gente di Dublino) quasi prettamente dal punta di vista stilistico, e questo per paragonarli ovviamente alle stesure successive, chiaramente più raffinate e consone a uno stile maggiormente maturo. Quasi a considerarli delle semplici bozze, cosa che invece non furono. Come ripeto, si trattò del suo primo biglietto da visita, in quanto scrittore, presentato a un pubblico di lettori. Hanno quindi, e meritano, la dignità di scritti autonomi, con la loro storia e la loro audience. Hanno suscitato aspettative, fatto storcere il naso a più d’uno, e soprattutto contribuito a plasmare la fama di Joyce come quella, sin dagli albori, di un autore controverso e pericoloso.
Furono inoltre scritti occasionali, composti su commissione, in perfetto stile con la sua ambizione di trasformare il proprio talento in un mestiere – un mestiere scelto non per la gloria, e dunque degno di adeguata retribuzione. Joyce non si proponeva spassionatamente di intessere fili di vento attraverso il verbo, ma di cambiare, con le parole, l’animo di un popolo. Il suo mestiere di scrittore era una missione.
Proprio in virtù del fatto che si trattò – nel caso di questi tre racconti con cui Joyce dichiarò al mondo di essere un letterato – di opere compiute, stampate e lette, non ha molto senso sminuirne lo stile alla luce delle riscritture posteriori, più meditate, raffinate, e molto meno occasionali. Potremmo quasi asserire che, invertendo i termini del tempo, Gente di Dublino sia la versione adulta, invecchiata, d’annata, di questi racconti molto più freschi e straightforward, si direbbe in inglese: diretti, non mediati. Racconti che ebbero un pubblico allora e che lo meritano ancora oggi. A differenza di altre dubbie operazioni editoriali recenti sempre riguardanti Joyce, come ad esempio il tentativo di spacciare un insieme di bozzetti preliminari – di studi tenuti per anni nel cassetto, in vista della sostanziale riscrittura e rielaborazione di alcuni di essi, in quello che sarebbe poi stato il Finnegans Wake – come libro autonomo parte del canone joyciano.
Due su tre dei racconti qui inclusi sono estremamente simili alle stesure che poi trovarono posto in Gente di Dublino. Eveline mostra solo alcuni cambiamenti rispetto alla versione uscita nel 1915, e Dopo la corsa veramente soltanto una singola inezia, sebbene ancora una volta epifanica, soprattutto per la sua collocazione. Tuttavia, non essendo questa una presentazione stilistica, lascio al lettore il piacere, più che l’onere, di scovarla. Le sorelle, invece, è qualcosa d’altro rispetto alla versione che conosciamo. Pur volendo bypassare velleitari stilisticismi, qualcosa sulle differenze tra la versione del 1904 e quella pubblicata nel 1914 va detto. Le divergenze sono enormi e rivelatrici, e non solo ovviamente di come lo stile di uno scrittore possa raffinarsi nel tempo, ma anche di un certo impressionismo da cui Joyce parve inizialmente muovere i primi passi.
Iniziamo col dire che non fu opera originale. George Russell (alias AE – sodale e intimo amico di Yeats), chiese al ventiduenne Joyce, che sapeva essere costantemente in bolletta, di comporre, per una sovrana a storia, dei racconti per la rubrica Our Weekly Story dell’Irish Homestead. Questo nel luglio del 1904. Nella lettera in cui lo invitava a scrivere per il giornale, Russell gli indicò, come modello, tre storie brevi precedentemente pubblicate nella stessa rubrica, e in particolare una dal titolo The Old Watchman, di Berkeley Campbell (pseudonimo di Charles Lionel Duddington). Joyce prese da quel racconto enormi spunti: il duo di personaggi: un sessantacinquenne e un giovane che gli sta accanto; la malattia dell’anziano, la sua degradazione morale, e tanto altro. Quegli spunti tradusse sul piano più ampio e politico del degrado di un popolo. Vi inserì poi subdolamente tutta una serie di piccoli riferimenti al tema della sifilide del protagonista in absentia, il vecchio prete. Sono riferimenti che, se individuati da alcuno, come può ben essere accaduto, devono aver contribuito, in un Irlanda stretta tra le maglie della religione, a quelle lamentele dei lettori cui si accennava sopra. La demenza cui il prete perviene, e dunque il sospetto di una malattia venerea che potrebbe averla causata, è ovviamente simbolica, e ben si accorda con il tema più ampio della paralisi (morale, spirituale ma anche fisica), non menzionato direttamente in questo racconto, ma ben evidente sin dalle prime righe della versione pubblicata nel 1914.
Ma per quanto riguarda la malattia del prete una domanda resta: perché scegliere la dissimulazione, l’occultamento, e poi finire per sciogliere tutto nella stesura più matura (e potremmo aggiungere, più controllata)? A chi stava mandando i suoi messaggi in codice il giovane Joyce? Innanzitutto al suo circolo di conoscenti, quei colleghi di università che popoleranno il Portrait of the Artist as a Young Man (il Dedalus) e poi l’Ulisse. Forse a Russell stesso, con cui aveva condiviso per qualche mese, in quegli anni dublinesi, interessi per il mondo dell’occulto e della teosofia – un mondo intriso di segretezza e immerso nel fascino del disvelamento iniziatico. Questa tecnica del nascondere perché sia poi l’occhio del lettore attento a svelare è ben riassunta nel motto pronunciato a mezza bocca da un Leopold Bloom allucinato, nel quindicesimo episodio dell’Ulisse (“mai rivelerò, nessuna parte o parti, arte o arti”). Si tratta della vera cifra della scrittura joyciana. Una crittografia da decriptare che è metafora della conoscenza (dall’ignoto al noto, attraverso la logica), ma anche dell’esistenza stessa (dall’innocenza acritica alla maturità critica – sempre sperando di non finire nelle secche della demenza senile…)
Dei motivi poi perché, molto probabilmente, dopo la terza storia s’interruppe la sua collaborazione con il settimanale, si occupano puntualmente le note a questa edizione, e risparmio in questa sede al lettore la rivelazione dell’arcano.
Nell’ottica finora descritta forse si comprendono ancor di più i limiti interpretativi, nell’affrontare la scrittura di Joyce, di una qualunque strategia di lettura che porti a fermarsi al “come” tralasciando “il cosa” e soprattutto i “perché”. Sarebbe come, direbbe Wilde, restare a fissare il fango in cui viviamo, senza alzare lo sguardo verso le stelle. E le stelle sono, in Joyce, quella sapienza e maturità della conoscenza cui si può pervenire soltanto dopo aver accettato e affrontato la complessità delle cose, la complessità del vivere. Poco importa che il destino sia il nulla, il vuoto, una pienezza di significati che è poi assenza di senso, di un senso ultimo.
Joyce era un materialista col tocco del nichilista. Ma lo era dopo esser passato per le fitte maglie di una religiosità che mai smise di ossessionarlo. La sua guida teologica principale, l’Aquinate San Tommaso, e quelle vagamente periferiche (tutta una selva di mistici che vanno da Dionigi l’Areopagita a Gioacchino da Fiore, a Giovanni della Croce, e altri) e quelle “extraterritoriali” (Böhme, Swedenborg, i teosofi, gli occultisti), compongono un dedalo di spiritualità e pseudo-spiritualità (sarebbe meglio parlare di spiritualismo?) da cui Joyce infine emerge per lanciare il suo messaggio umano, un messaggio politico. Un po’ pessimista, forse, ma guidato dalla necessità di rimanere hilaris anche nella tristitia. Questo secondo l’insegnamento di quello che è forse il mentore più importante per Joyce, Giordano Bruno da Nola, arso vivo il 17 febbraio del 1600, a Roma, nei pressi di Campo de’ Fiori. Chissà se il cognome del personaggio più riuscito e “umano” di Joyce, Mr Bloom, non sia un’altra obliqua e occulta allusione al luogo in cui Bruno, attraverso la morte, pervenne all’immortalità.
In questa continua fuga narrativa che colloca il noto sul piano della scoperta – simile quasi a una fuga musicale da un tema – si configurerà, negli anni a venire, quell’altra particolare fuga di Joyce dalla propria terra, una fuga da lui oculatamente rinominata “esilio volontario”. Fu un esilio che ironicamente lo costringerà per tutta la vita, non solo a scrivere di sé o dei suoi sé perduti, ma anche della sua Irlanda e del suo popolo abbandonati. Ma per farlo dovrà calarsi la maschera. Se questi primi racconti di gioventù sono infatti firmati Stephen Daedalus, in seguito Joyce appenderà al chiodo, forse semplicemente per amor di verità o di esattezza, questa sua “persona”. E il tutto per non dover abiurare. Come Bruno. Fuggire come unica via di ritorno a casa. Dal sé non si scappa, e in Joyce, il “sé” diviene immancabilmente un “noi”. Ma perché tutto ciò? Come ebbe a sintetizzare magistralmente il compianto Giorgio Melchiori nel dettare nel 1982 la targa che tuttora segnala un alloggio romano di James Joyce e famiglia: affinché la “sua Dublino” divenisse “il nostro universo”.
Roma, 24 settembre 2015
Tre storie di Stephen Dædalus di James Joyce
TRE RACCONTI INEDITI DI JAMES JOYCE Quelli compresi in questa raccolta sono l'esordio narrativo di James Joyce, qui in prima traduzione italiana. Come scrive il curatore e traduttore Enrico Terrinoni, si tratta letterariamente del suo “primo biglietto da visita, sebbene con su impres…