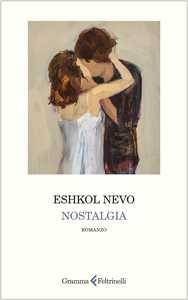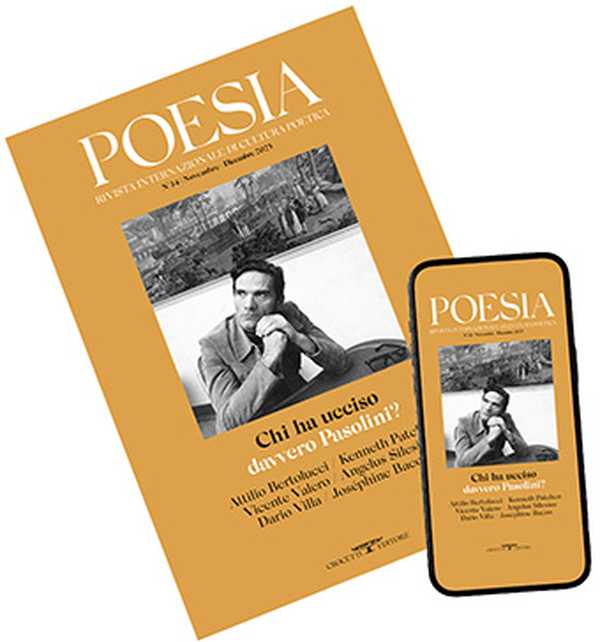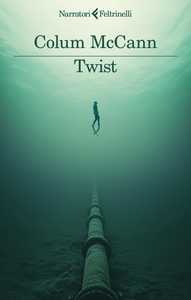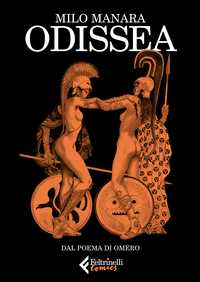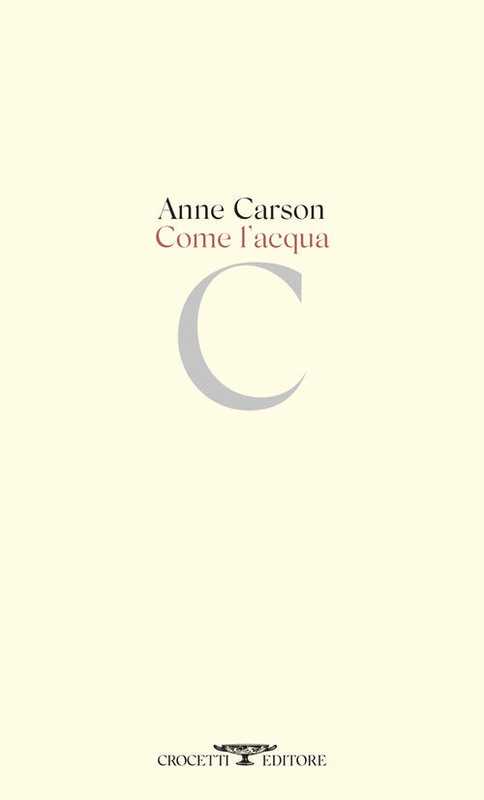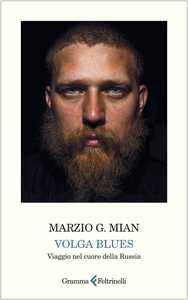Ahmed Rashid: Domino asiatico
16 Settembre 2002
In tutti i paesi dell’Asia centrale e meridionale le conseguenze della
guerra in Afghanistan hanno provocato più instabilità e più crisi interne.
Finora queste crisi politiche sono state virtualmente ignorate dall’occidente,
ma i loro sviluppi sono imprevedibili ed è probabile che condizionino i
prossimi dodici mesi più della lunga guerra contro al Qaeda.
Gli Stati Uniti, ossessionati dall’idea di dare la caccia ai leader di al Qaeda, non hanno cercato di affrontare i fermenti politici della regione. Il Pentagono e la Cia dominano ancora la politica di Washington e la sua strategia, per non parlare del fatto che la tattica americana è cambiata ben poco dal dicembre 2001, quando i taliban sono stati sconfitti.
L’emarginazione del buonsenso
La stessa cerchia ristretta di uomini dell’intelligence e di funzionari della difesa che ha condotto la guerra in Afghanistan continua a prendere tutte le decisioni cruciali. Il dipartimento di stato e il segretario di stato Colin Powell, che mostrano più buonsenso, sembrano tagliati fuori, e così altri settori del governo statunitense come l’Agenzia americana per lo sviluppo internazionale, i dipartimenti del tesoro e della giustizia e il congresso. Dovrebbero partecipare al processo decisionale e spingere per una strategia più ampia che punti a convincere i vicini dell’Afghanistan ad avviare riforme politiche ed economiche in grado di scongiurare l’instabilità e la crescente simpatia dell’opinione pubblica per i gruppi fondamentalisti islamici locali.
Nove mesi dopo essere diventato presidente Hamid Karzai deve ancora estendere l’autorità del governo all’intero paese e trovare una formula politica per ridurre alla ragione i signori della guerra fuori della capitale, che diventano ogni giorno più forti e non esitano a sfidare l’autorità centrale.
Karzai è stato ostacolato dalle persistenti tensioni etniche e tribali in un paese devastato da 23 anni di guerra, ma anche dal mancato rispetto di due impegni fondamentali assunti dalla comunità internazionale nel dicembre scorso alla firma dell’accordo di Bonn che ha insediato il nuovo governo di Kabul. Il primo era quello di mobilitare una Forza internazionale di assistenza per la sicurezza (Isaf) che consentisse di stabilizzare Kabul e altre cinque città. Ma a tutt’oggi l’Isaf è presente solo a Kabul, e se in passato sono stati gli Stati Uniti a bloccarne l’espansione ora sono gli europei a non inviare truppe per il mantenimento della pace.
Ancora più pericoloso è il fatto che il mondo non abbia garantito fondi per contribuire a ricostruire il paese, fondi da cui Karzai dipende pesantemente per ridurre il potere dei signori della guerra, creare posti di lavoro e rimettere in moto l’economia. Del miliardo di dollari americani consegnati finora, il 90 per cento è andato ad aiuti umanitari invece che a progetti di ricostruzione a lungo termine. Il risultato è che non è ancora partito un solo progetto per la realizzazione di alloggi o di strade. Eppure, in una regione dove le dittature e l’autoritarismo sono la norma, Hamid Karzai è forse il leader più legittimo: a giugno la loya jirga, l’assemblea delle tribù, lo ha eletto presidente per i prossimi due anni con una schiacciante maggioranza.
La questione della legittimità
Nelle cinque repubbliche dell’Asia centrale, dove si tengono ancora elezioni in stile sovietico con il presidente come unico candidato e malgrado ciò il voto è macchiato da gravi irregolarità, la questione della legittimità non è mai stata più attuale. Dall’ottobre scorso l’Uzbekistan, il Kirghizistan e il Tagikistan ospitano truppe occidentali per la guerra in Afghanistan, ma hanno approfittato della loro nuova importanza per l’occidente come una comoda scusa per intensificare la repressione del popolo e dei loro avversari politici. Il Turkmenistan e il Kazakistan, che non ospitano forze occidentali ma hanno messo a loro disposizione impianti e strutture, non hanno esitato a fare altrettanto.
Paradossalmente la presenza militare occidentale ha determinato una reazione esattamente opposta. Per la prima volta dopo il crollo dell’Unione Sovietica, dieci anni fa, l’opposizione politica laica dell’Asia centrale, a lungo addormentata e per lo più clandestina, si sta mobilitando contro la dittatura e a sostegno della democrazia. Quasi tutti i leader dell’Asia centrale sono oggi minacciati dai primi movimenti politici significativi dell’opinione pubblica e dalla ripetuta richiesta di dimissioni, mentre permane il pericolo degli estremisti islamici che un tempo erano sostenuti da al Qaeda. Ma l’occidente si è rifiutato di intervenire o di usare la sua nuova influenza per convincere questi governanti a cambiare le loro abitudini e a promuovere riforme politiche ed economiche.
In Pakistan la crisi interna è ancora più vasta e sta per esplodere, ma finché il generale al potere, il presidente Pervez Musharraf, continua a sostenere la guerra contro il terrorismo e a fornire basi militari agli Stati Uniti, Washington preferisce ignorarla. Musharraf si sta avvicinando alla fine del suo mandato triennale e ha promesso le elezioni per il 10 ottobre. Ma è chiaro che sta programmando delle elezioni truccate a cui Benazir Bhutto e Nawaz Sharif, i leader dei due maggiori partiti politici, non potranno partecipare.
Con un referendum discusso e truccato tenuto nell’aprile scorso Musharraf si è consacrato presidente per i prossimi cinque anni. Attualmente sta cercando di modificare la costituzione per dare all’esercito un ruolo permanente nel sistema politico e introdurre un consiglio di sicurezza nazionale dominato dai militari che potrà scavalcare qualsiasi futuro parlamento o primo ministro. La crisi scoppierà poco prima delle elezioni o subito dopo, quando neanche il parlamento "selezionato" dell’esercito potrà approvare a scatola chiusa tutti gli emendamenti costituzionali sollecitati dal presidente.
Una crisi in Pakistan avrebbe enormi ripercussioni internazionali e regionali. Con un’India bellicosa alle porte, le cellule di al Qaeda saldamente installate all’interno del paese, il crollo della legge e dell’ordine provocato dall’uccisione di occidentali e pachistani di religione cristiana per mano di gruppi militanti, una grave recessione economica e una profonda polarizzazione fra i partiti democratici laici e i gruppi islamici, è il futuro stesso del paese a essere in gioco.
Finora l’India ha approfittato della guerra al terrorismo per portare avanti le sue politiche repressive in Kashmir, che quest’anno hanno spinto il Pakistan ad aumentare gli aiuti ai militanti del Kashmir, il che a sua volta ha portato a una situazione di quasi guerra tra i due stati, entrambi dotati di armi nucleari. Gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti sono riusciti solo a disinnescare la crisi contingente, ma il Kashmir rimane esplosivo. L’India è decisa a tenere delle elezioni in questa regione a settembre, mentre il Pakistan e i militanti sono decisi a sabotarle. È inevitabile che si scateni una nuova ondata di forti tensioni.
L’Iran vive un contrasto paralizzante tra il governo moderato del presidente Mohammed Khatami e la linea dura dei mullah, una situazione che potrebbe portare a un’esplosione di piazza alla prima scintilla. I falchi sono ora decisi a destabilizzare il presidente appoggiando tutti i gruppi islamici antioccidentali presenti nella regione, che siano in Afghanistan, in Asia centrale o nel Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti hanno evitato di aprire un dialogo con Khatami.
Strategie europee
L’instabilità politica della regione è proprio quello che vogliono e auspicano al Qaeda e altri gruppi di estremisti islamici per pianificare la loro rinascita. Un Pakistan instabile lacerato dalle tensioni tra esercito e politici o da una guerra con l’India che porti alla sconfitta di Islamabad potrebbe offrire ai fondamentalisti l’occasione a lungo cercata di instaurare uno stato islamico nel paese. Il crollo di uno o più regimi centroasiatici in mancanza di un’alternativa democratica e il grave malessere economico potrebbero dare agli estremisti islamici l’opportunità di creare nuovi comandi e centri di controllo terroristici. È indispensabile un grande sforzo dell’occidente per convincere questi regimi che la guerra al terrorismo implica anche un cambiamento delle loro abitudini e del loro rapporto con i propri cittadini. Non esistono alternative al governo rappresentativo che possano risanare queste società estremamente polarizzate invece di dividerle ulteriormente. La strategia della comunità internazionale deve prevedere anche un sostegno economico molto più forte alla regione nel suo insieme.
Le implicazioni più ampie di tale strategia sarebbero profondamente positive per migliorare le relazioni tra l’occidente e il mondo islamico, perché anche i musulmani più arrabbiati dovrebbero affrontare la realtà che l’occidente contribuisce a ricostruire i paesi e le economie, e non si limita a distruggere i governi terroristi come quello dei taliban.
Ma è difficile che tutto ciò avvenga se gli Stati Uniti insisteranno nella loro volontà di attaccare l’Iraq senza l’appoggio internazionale e mentre il Medio Oriente è in fiamme. Il mondo arabo e musulmano esploderà di rabbia e il terrorismo potrebbe diventare l’unica piattaforma politica di molti altri gruppi per muovere guerra agli Stati Uniti.
Per scoprire le cellule di al Qaeda che tuttora operano negli Stati Uniti o in Europa occorrerà un paziente lavoro della polizia e dell’intelligence, ma al Qaeda e i suoi cloni estremisti non possono sperare di ricostruire in occidente una base di comando e di appoggio come quella che avevano in Afghanistan. Eppure nella regione dell’Asia centrale e meridionale l’instabilità, gli imprevedibili cambiamenti di regime o i movimenti di massa sulle strade possono offrire ad al Qaeda enormi possibilità di rilancio.
La guerra contro il terrorismo è entrata in una fase critica e complessa, che implica uno sforzo per risanare i grandi squilibri politici ed economici della regione. E occorrerà un impegno ancora maggiore della comunità internazionale per raccogliere questa sfida. Il primo anniversario dell’11 settembre, quindi, non è un’occasione per autocompiacersi, ma per affrontare i problemi che ci stanno davanti.
Traduzione di Giuseppina Cavallo
Gli Stati Uniti, ossessionati dall’idea di dare la caccia ai leader di al Qaeda, non hanno cercato di affrontare i fermenti politici della regione. Il Pentagono e la Cia dominano ancora la politica di Washington e la sua strategia, per non parlare del fatto che la tattica americana è cambiata ben poco dal dicembre 2001, quando i taliban sono stati sconfitti.
L’emarginazione del buonsenso
La stessa cerchia ristretta di uomini dell’intelligence e di funzionari della difesa che ha condotto la guerra in Afghanistan continua a prendere tutte le decisioni cruciali. Il dipartimento di stato e il segretario di stato Colin Powell, che mostrano più buonsenso, sembrano tagliati fuori, e così altri settori del governo statunitense come l’Agenzia americana per lo sviluppo internazionale, i dipartimenti del tesoro e della giustizia e il congresso. Dovrebbero partecipare al processo decisionale e spingere per una strategia più ampia che punti a convincere i vicini dell’Afghanistan ad avviare riforme politiche ed economiche in grado di scongiurare l’instabilità e la crescente simpatia dell’opinione pubblica per i gruppi fondamentalisti islamici locali.
Nove mesi dopo essere diventato presidente Hamid Karzai deve ancora estendere l’autorità del governo all’intero paese e trovare una formula politica per ridurre alla ragione i signori della guerra fuori della capitale, che diventano ogni giorno più forti e non esitano a sfidare l’autorità centrale.
Karzai è stato ostacolato dalle persistenti tensioni etniche e tribali in un paese devastato da 23 anni di guerra, ma anche dal mancato rispetto di due impegni fondamentali assunti dalla comunità internazionale nel dicembre scorso alla firma dell’accordo di Bonn che ha insediato il nuovo governo di Kabul. Il primo era quello di mobilitare una Forza internazionale di assistenza per la sicurezza (Isaf) che consentisse di stabilizzare Kabul e altre cinque città. Ma a tutt’oggi l’Isaf è presente solo a Kabul, e se in passato sono stati gli Stati Uniti a bloccarne l’espansione ora sono gli europei a non inviare truppe per il mantenimento della pace.
Ancora più pericoloso è il fatto che il mondo non abbia garantito fondi per contribuire a ricostruire il paese, fondi da cui Karzai dipende pesantemente per ridurre il potere dei signori della guerra, creare posti di lavoro e rimettere in moto l’economia. Del miliardo di dollari americani consegnati finora, il 90 per cento è andato ad aiuti umanitari invece che a progetti di ricostruzione a lungo termine. Il risultato è che non è ancora partito un solo progetto per la realizzazione di alloggi o di strade. Eppure, in una regione dove le dittature e l’autoritarismo sono la norma, Hamid Karzai è forse il leader più legittimo: a giugno la loya jirga, l’assemblea delle tribù, lo ha eletto presidente per i prossimi due anni con una schiacciante maggioranza.
La questione della legittimità
Nelle cinque repubbliche dell’Asia centrale, dove si tengono ancora elezioni in stile sovietico con il presidente come unico candidato e malgrado ciò il voto è macchiato da gravi irregolarità, la questione della legittimità non è mai stata più attuale. Dall’ottobre scorso l’Uzbekistan, il Kirghizistan e il Tagikistan ospitano truppe occidentali per la guerra in Afghanistan, ma hanno approfittato della loro nuova importanza per l’occidente come una comoda scusa per intensificare la repressione del popolo e dei loro avversari politici. Il Turkmenistan e il Kazakistan, che non ospitano forze occidentali ma hanno messo a loro disposizione impianti e strutture, non hanno esitato a fare altrettanto.
Paradossalmente la presenza militare occidentale ha determinato una reazione esattamente opposta. Per la prima volta dopo il crollo dell’Unione Sovietica, dieci anni fa, l’opposizione politica laica dell’Asia centrale, a lungo addormentata e per lo più clandestina, si sta mobilitando contro la dittatura e a sostegno della democrazia. Quasi tutti i leader dell’Asia centrale sono oggi minacciati dai primi movimenti politici significativi dell’opinione pubblica e dalla ripetuta richiesta di dimissioni, mentre permane il pericolo degli estremisti islamici che un tempo erano sostenuti da al Qaeda. Ma l’occidente si è rifiutato di intervenire o di usare la sua nuova influenza per convincere questi governanti a cambiare le loro abitudini e a promuovere riforme politiche ed economiche.
In Pakistan la crisi interna è ancora più vasta e sta per esplodere, ma finché il generale al potere, il presidente Pervez Musharraf, continua a sostenere la guerra contro il terrorismo e a fornire basi militari agli Stati Uniti, Washington preferisce ignorarla. Musharraf si sta avvicinando alla fine del suo mandato triennale e ha promesso le elezioni per il 10 ottobre. Ma è chiaro che sta programmando delle elezioni truccate a cui Benazir Bhutto e Nawaz Sharif, i leader dei due maggiori partiti politici, non potranno partecipare.
Con un referendum discusso e truccato tenuto nell’aprile scorso Musharraf si è consacrato presidente per i prossimi cinque anni. Attualmente sta cercando di modificare la costituzione per dare all’esercito un ruolo permanente nel sistema politico e introdurre un consiglio di sicurezza nazionale dominato dai militari che potrà scavalcare qualsiasi futuro parlamento o primo ministro. La crisi scoppierà poco prima delle elezioni o subito dopo, quando neanche il parlamento "selezionato" dell’esercito potrà approvare a scatola chiusa tutti gli emendamenti costituzionali sollecitati dal presidente.
Una crisi in Pakistan avrebbe enormi ripercussioni internazionali e regionali. Con un’India bellicosa alle porte, le cellule di al Qaeda saldamente installate all’interno del paese, il crollo della legge e dell’ordine provocato dall’uccisione di occidentali e pachistani di religione cristiana per mano di gruppi militanti, una grave recessione economica e una profonda polarizzazione fra i partiti democratici laici e i gruppi islamici, è il futuro stesso del paese a essere in gioco.
Finora l’India ha approfittato della guerra al terrorismo per portare avanti le sue politiche repressive in Kashmir, che quest’anno hanno spinto il Pakistan ad aumentare gli aiuti ai militanti del Kashmir, il che a sua volta ha portato a una situazione di quasi guerra tra i due stati, entrambi dotati di armi nucleari. Gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti sono riusciti solo a disinnescare la crisi contingente, ma il Kashmir rimane esplosivo. L’India è decisa a tenere delle elezioni in questa regione a settembre, mentre il Pakistan e i militanti sono decisi a sabotarle. È inevitabile che si scateni una nuova ondata di forti tensioni.
L’Iran vive un contrasto paralizzante tra il governo moderato del presidente Mohammed Khatami e la linea dura dei mullah, una situazione che potrebbe portare a un’esplosione di piazza alla prima scintilla. I falchi sono ora decisi a destabilizzare il presidente appoggiando tutti i gruppi islamici antioccidentali presenti nella regione, che siano in Afghanistan, in Asia centrale o nel Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti hanno evitato di aprire un dialogo con Khatami.
Strategie europee
L’instabilità politica della regione è proprio quello che vogliono e auspicano al Qaeda e altri gruppi di estremisti islamici per pianificare la loro rinascita. Un Pakistan instabile lacerato dalle tensioni tra esercito e politici o da una guerra con l’India che porti alla sconfitta di Islamabad potrebbe offrire ai fondamentalisti l’occasione a lungo cercata di instaurare uno stato islamico nel paese. Il crollo di uno o più regimi centroasiatici in mancanza di un’alternativa democratica e il grave malessere economico potrebbero dare agli estremisti islamici l’opportunità di creare nuovi comandi e centri di controllo terroristici. È indispensabile un grande sforzo dell’occidente per convincere questi regimi che la guerra al terrorismo implica anche un cambiamento delle loro abitudini e del loro rapporto con i propri cittadini. Non esistono alternative al governo rappresentativo che possano risanare queste società estremamente polarizzate invece di dividerle ulteriormente. La strategia della comunità internazionale deve prevedere anche un sostegno economico molto più forte alla regione nel suo insieme.
Le implicazioni più ampie di tale strategia sarebbero profondamente positive per migliorare le relazioni tra l’occidente e il mondo islamico, perché anche i musulmani più arrabbiati dovrebbero affrontare la realtà che l’occidente contribuisce a ricostruire i paesi e le economie, e non si limita a distruggere i governi terroristi come quello dei taliban.
Ma è difficile che tutto ciò avvenga se gli Stati Uniti insisteranno nella loro volontà di attaccare l’Iraq senza l’appoggio internazionale e mentre il Medio Oriente è in fiamme. Il mondo arabo e musulmano esploderà di rabbia e il terrorismo potrebbe diventare l’unica piattaforma politica di molti altri gruppi per muovere guerra agli Stati Uniti.
Per scoprire le cellule di al Qaeda che tuttora operano negli Stati Uniti o in Europa occorrerà un paziente lavoro della polizia e dell’intelligence, ma al Qaeda e i suoi cloni estremisti non possono sperare di ricostruire in occidente una base di comando e di appoggio come quella che avevano in Afghanistan. Eppure nella regione dell’Asia centrale e meridionale l’instabilità, gli imprevedibili cambiamenti di regime o i movimenti di massa sulle strade possono offrire ad al Qaeda enormi possibilità di rilancio.
La guerra contro il terrorismo è entrata in una fase critica e complessa, che implica uno sforzo per risanare i grandi squilibri politici ed economici della regione. E occorrerà un impegno ancora maggiore della comunità internazionale per raccogliere questa sfida. Il primo anniversario dell’11 settembre, quindi, non è un’occasione per autocompiacersi, ma per affrontare i problemi che ci stanno davanti.
Traduzione di Giuseppina Cavallo
Ahmed Rashid
Ahmed Rashid (1948) è stato corrispondente per la “Far Eastern Economic Review”, attualmente scrive per “Daily Telegraph”, “International Herald Tribune”, “The New York Review of Books”, “Bbc Online”, “The Nation”. …