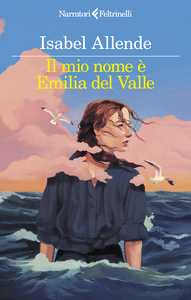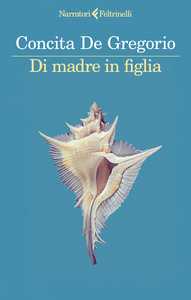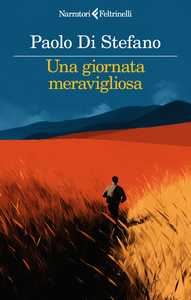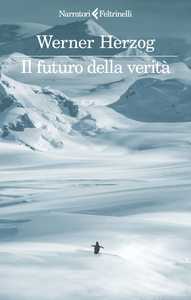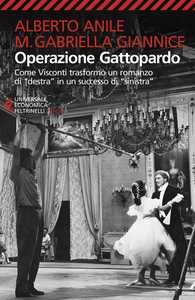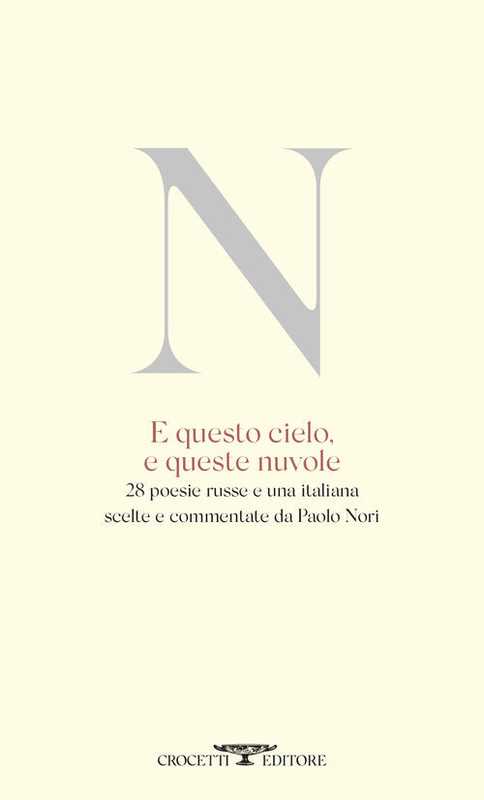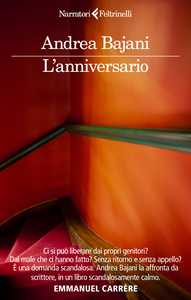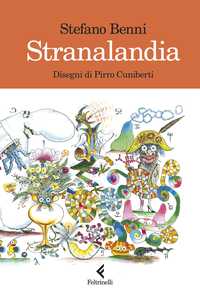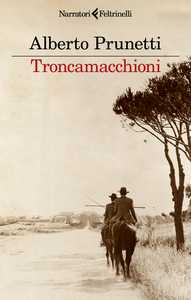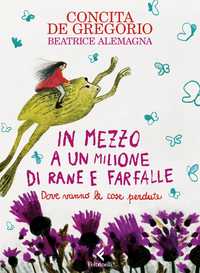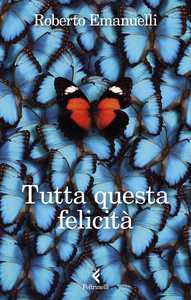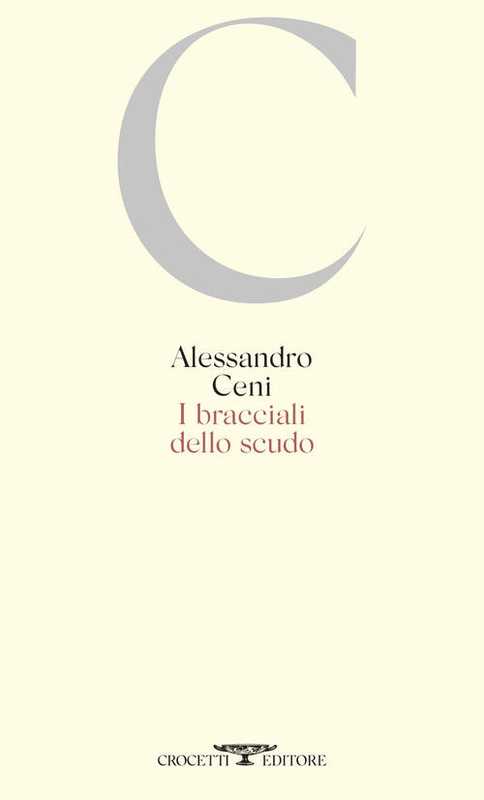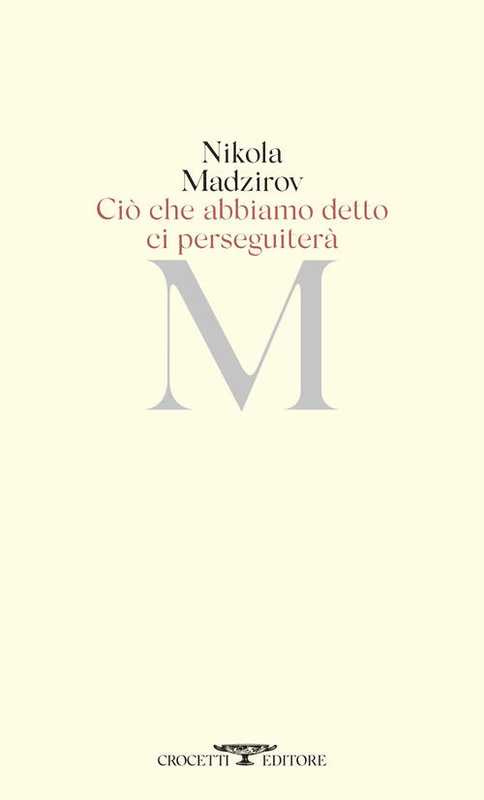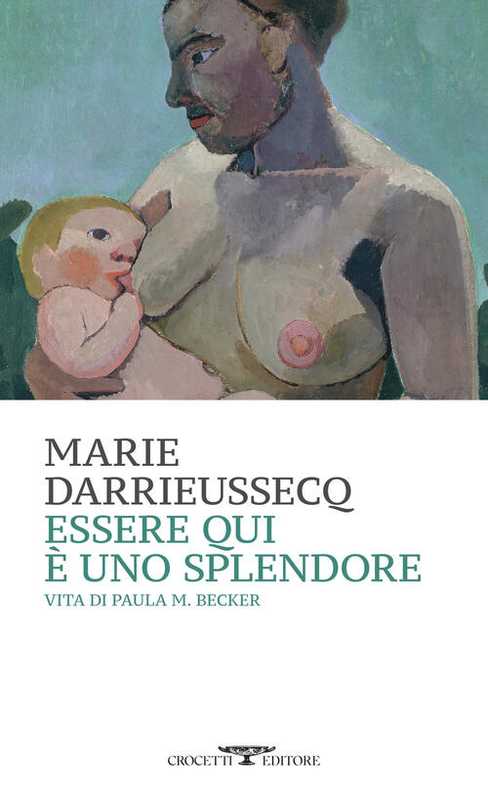Paolo Di Stefano: Amori e odi, da Arbasino a Volponi
16 Settembre 2002
Visto che il significato delle amicizie letterarie va ben
oltre il gusto del pettegolezzo, proviamo a rispondere alla domanda di Raboni:
fra gli scrittori d'oggi che cosa prevale, l'amicizia, l'inimicizia o
l'indifferenza? Se si guarda agli attuali sessanta-settantenni, forse non c'è
da essere pessimisti. E non dovrebbe esserlo neppure Raboni, che d'amicizia e
d'ammirazione è rimasto legato per anni a molti scrittori: da Sereni a Testori
a Volponi a Fortini a Pontiggia. Senza dimenticare i critici: Baldacci e
Mengaldo, per esempio (con Garboli forse è sopraggiunto qualche problema legato
alla giuria del Viareggio). Su altro versante, opposto e speculare ma non certo
indifferente, ci sono i coetanei più "irriducibili" della
neoavanguardia: almeno, Sanguineti, Balestrini, Giuliani, Guglielmi e forse
anche Arbasino e Malerba. Ex amici con persistenti affinità. La biografia di
Eco si è portata dietro, anno per anno, le sue amicizie: con Enrico Filippini
alla Bompiani, con Antonio Porta durante il Gruppo 63, con Furio Colombo alla
Rai, con Maria Corti e con l'"allievo" Paolo Fabbri ai tempi della
semiotica, con Emilio Tadini nel periodo milanese. Sempre per parlare di
schieramenti, forse mai una rivista era riuscita a favorire forti sintonie umane
come quelle nate con i Quaderni piacentini tra Bellocchio, Fofi e Grazia
Cherchi. Che rivolgendosi a maestri come Fortini e Cases erano in esplicito
antagonismo rispetto ai neoavanguardisti.
Poi il gruppo si disgregò e da quelle ceneri nacque, con la rivista Diario , l'amicizia Bellocchio-Berardinelli. Mentre Fofi stabilisce sempre nuove affinità, specie con i più giovani (da Bettin a Scarpa), grazie a iniziative come Linea d'ombra e, oggi, Lo straniero , Grazia Cherchi in veste di "editor" si avvicinò a Benni e lanciò Veronesi e Baricco (ma fu vera amicizia?), senza mai dimenticare però le affinità con Giovanni Giudici e Lalla Romano. La quale era capace di grandi amicizie e di colossali antipatie: come quelle (maturate in tarda età) per Maria Corti e per Citati. Ma sempre rimanendo alle riviste, non bisognerà dimenticare che Alfabeta fu un crocevia dove si intrecciavano militanza e accademia (Porta ne era il vero tessitore). Amicizie e inimicizie sono intrecci strambi e capricciosi (non solo in letteratura), per i quali non vale la proprietà transitiva. Così può accadere che Citati e Garboli, pur essendo ambedue notoriamente stimati da Roberto Calasso e da Scalfari, sembrano da anni non guardarsi con grande simpatia reciproca. L'uno legato a Calvino e a Fruttero & Lucentini; l'altro vicino a Morante, Ginzburg, Soldati. L'uno e l'altro non certo portati ad ammirare senza riserve un filosofo come Cacciari con cui Calasso ha invece un rapporto di sincera amicizia. Come con l'editore Piero Gelli, che del resto è amico inseparabile anche di Fleur Jaeggy, musa e amica di Franco Battiato.
E si potrebbe andare avanti, aggiungendo che Cacciari ha un amico sicuro in Daniele Del Giudice, che a sua volta è amico di Cesare Segre, il quale dopo una celebre polemica di qualche anno fa non nasconde la sua distanza culturale dallo stesso Calasso. E non ci spingiamo oltre, se non per evocare l'inimicizia più cruenta degli ultimi anni: quella tra i critici Asor Rosa e Ferroni.
Si può poi passare ai più giovani. All'asse di coetanei Vassalli-Cordelli-Montefoschi. Per ricordare che se attorno a Cordelli gravitano i giovani critici romani più interessanti, da Cortellessa a Gabriele Pedullà, a Milano sono Scarpa, Nove e Montanari, coautori di una fortunata plaquette poetica, a fare gruppo. Le cui solidarietà vanno ben al di là dell'anagrafe, se è vero che con Antonio Moresco si è stabilito subito un feeling molto solido. Ben visibile nella recente raccolta Scrivere sul fronte occidentale , curata dallo stesso Moresco e da Voltolini. Qualche volta le amicizie confluiscono, oltre che in riviste (per esempio Riga di Belpoliti e Grazioli), nelle antologie. Anche quando non sono amicizie da antologia. Né antologie da antologia.
Poi il gruppo si disgregò e da quelle ceneri nacque, con la rivista Diario , l'amicizia Bellocchio-Berardinelli. Mentre Fofi stabilisce sempre nuove affinità, specie con i più giovani (da Bettin a Scarpa), grazie a iniziative come Linea d'ombra e, oggi, Lo straniero , Grazia Cherchi in veste di "editor" si avvicinò a Benni e lanciò Veronesi e Baricco (ma fu vera amicizia?), senza mai dimenticare però le affinità con Giovanni Giudici e Lalla Romano. La quale era capace di grandi amicizie e di colossali antipatie: come quelle (maturate in tarda età) per Maria Corti e per Citati. Ma sempre rimanendo alle riviste, non bisognerà dimenticare che Alfabeta fu un crocevia dove si intrecciavano militanza e accademia (Porta ne era il vero tessitore). Amicizie e inimicizie sono intrecci strambi e capricciosi (non solo in letteratura), per i quali non vale la proprietà transitiva. Così può accadere che Citati e Garboli, pur essendo ambedue notoriamente stimati da Roberto Calasso e da Scalfari, sembrano da anni non guardarsi con grande simpatia reciproca. L'uno legato a Calvino e a Fruttero & Lucentini; l'altro vicino a Morante, Ginzburg, Soldati. L'uno e l'altro non certo portati ad ammirare senza riserve un filosofo come Cacciari con cui Calasso ha invece un rapporto di sincera amicizia. Come con l'editore Piero Gelli, che del resto è amico inseparabile anche di Fleur Jaeggy, musa e amica di Franco Battiato.
E si potrebbe andare avanti, aggiungendo che Cacciari ha un amico sicuro in Daniele Del Giudice, che a sua volta è amico di Cesare Segre, il quale dopo una celebre polemica di qualche anno fa non nasconde la sua distanza culturale dallo stesso Calasso. E non ci spingiamo oltre, se non per evocare l'inimicizia più cruenta degli ultimi anni: quella tra i critici Asor Rosa e Ferroni.
Si può poi passare ai più giovani. All'asse di coetanei Vassalli-Cordelli-Montefoschi. Per ricordare che se attorno a Cordelli gravitano i giovani critici romani più interessanti, da Cortellessa a Gabriele Pedullà, a Milano sono Scarpa, Nove e Montanari, coautori di una fortunata plaquette poetica, a fare gruppo. Le cui solidarietà vanno ben al di là dell'anagrafe, se è vero che con Antonio Moresco si è stabilito subito un feeling molto solido. Ben visibile nella recente raccolta Scrivere sul fronte occidentale , curata dallo stesso Moresco e da Voltolini. Qualche volta le amicizie confluiscono, oltre che in riviste (per esempio Riga di Belpoliti e Grazioli), nelle antologie. Anche quando non sono amicizie da antologia. Né antologie da antologia.
Paolo Di Stefano
Paolo Di Stefano, nato ad Avola (Siracusa) nel 1956, giornalista e scrittore, già responsabile della pagina culturale del “Corriere della Sera”, dove attualmente è inviato speciale, ha lavorato anche per …