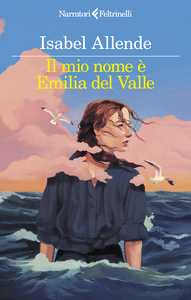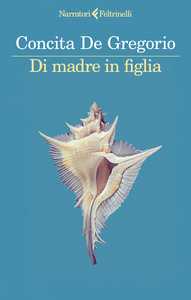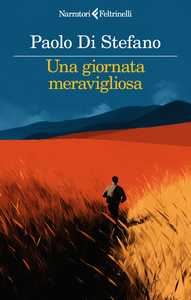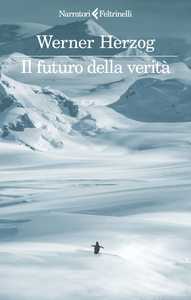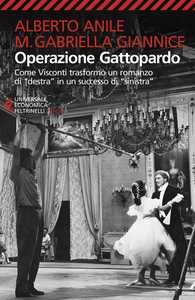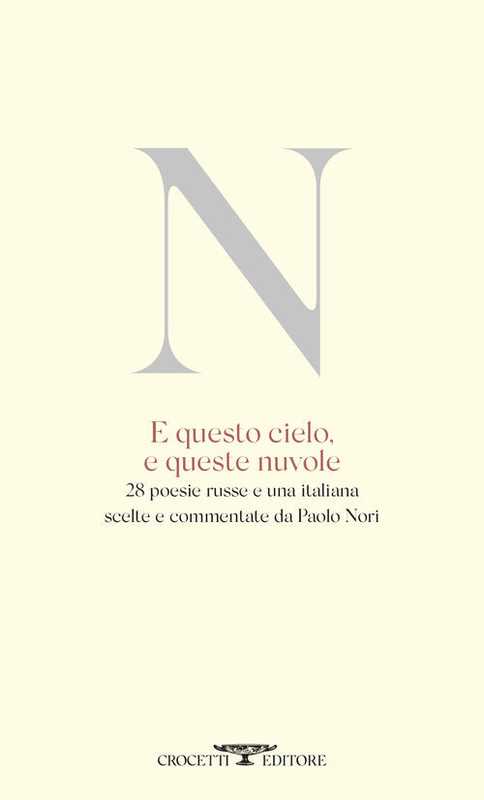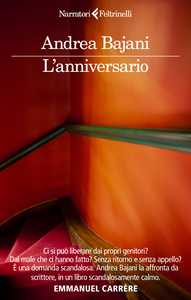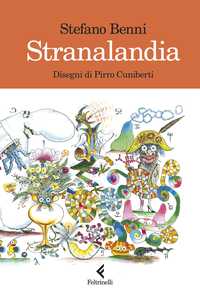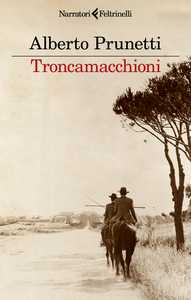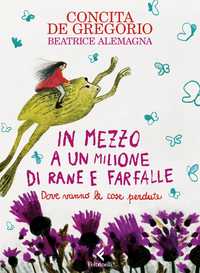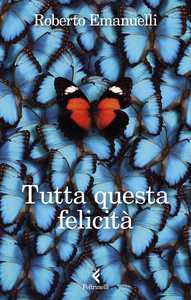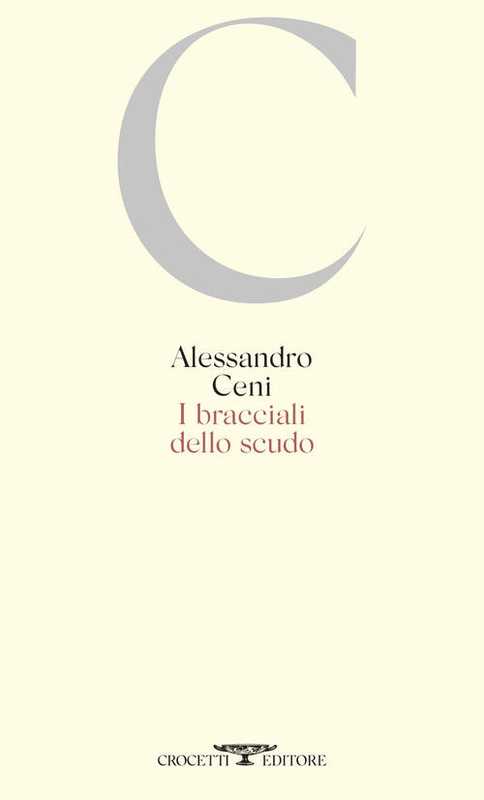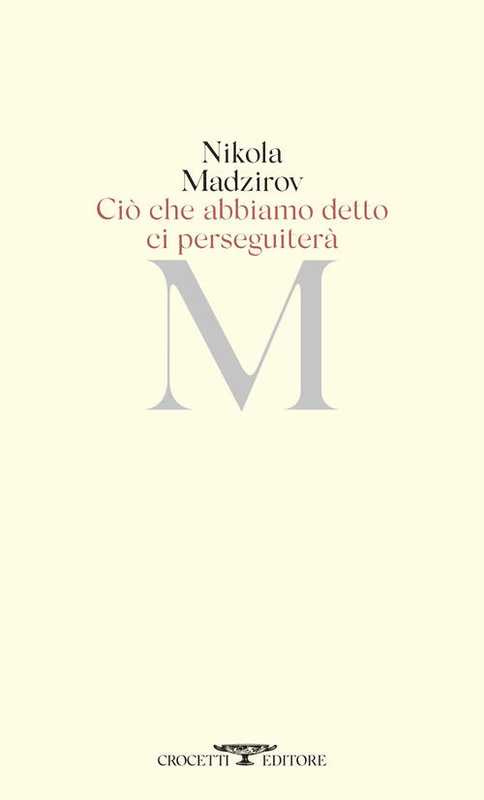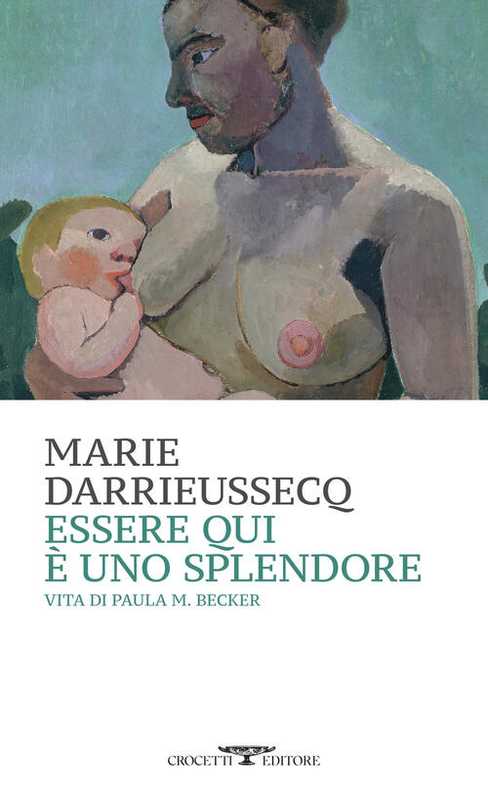Michele Serra: Quando passava Nuvolari
26 Agosto 2003
Cinquant’anni fa, l’11 agosto del 53, moriva a Mantova Tazio Nuvolari,
ricco quanto poteva essere ricco un campione sportivo di allora (cioè non
molto), famoso quando poteva essere famoso un campione sportivo prima della
televisione (cioè infinitamente più di adesso). La fama era allora un vento
propriamente mitologico: istantanee in bianco e nero, rare volte una voce
gracchiante alla radio, sui giornali la secca epica delle classifiche d’arrivo
e qualche tonante cronaca, poi l’infinita sequenza di punti irripetibili lungo
le strade di precario asfalto granuloso, quando la macchina appariva in fondo al
rettilineo e si intraversava verso la curva, e l’occhio umano poteva fissare
quella breve apparizione con ammirato sgomento.
Quando lo sbraito del motore lasciava dietro di sé solo eco e polvere, la gente in piedi tra le stoppie poteva ben dire di avere visto Nuvolari: un paio di lenti affumicate sotto un casco di cuoio, i mezzi guanti al volante, la bestia di vernice che lo ingoiava per quanto era piccolo (uno e sessanta, "un fascio di nervi spiccio e caustico" nella memoria di Enzo Ferrari). Sapere come parlava e che cosa pensava, come vestiva da civile, che fidanzate o mogli avesse, insomma che "personaggio" fosse, era il privilegio (o la sfortuna) della sua cerchia privata e di lavoro, e dei pochi giornalisti al seguito.
Per la folla, che è la sola vera depositaria dei miti, Nuvolari era solo un nome filante a bordo della Chiribiri, dell’Alfa, dell’Auto Union, della Ferrari: una folgore intravista da parecchi ma solo per pochi istanti, e percepita da tutti come fenomenale icona della destrezza e del fegato, della velocità e dello sprezzo della morte. Da fine anni Venti ai primi Cinquanta, l’epoca d’oro dell’automobile e dell’automobilismo sportivo, quando si correva nel territorio, tra il granturco e i pioppi, tra le case e i campi dell’Italia contadina, con pochi denari, molta incoscienza e una cieca fede nel rombo generoso di una modernità tutta ancora da verificare... Se partiamo proprio da qui, cioè dalla coincidenza tra la scomparsa di Nuvolari e la comparsa, in Italia, del piccolo schermo, possiamo capire meglio l’unicità del suo mito. Non fece in tempo, come Bartali e Coppi, a partecipare al Musichiere e scherzare con Mario Riva, dando al nascente pubblico di massa l’idea familiare e smagata dei campioni come vicini di casa, il tiepido brivido di vederli in abiti borghesi.
Morì che era ancora una fotografia, un breve e nebbioso filmato, una divinità sfuggente e misteriosa. Morì che era puro talento, non inquadrato nell’umanamente noto, il fantino prodigioso in grado di domare le infernali lamiere che già allora sfioravano i trecento all’ora, ma su gomme quasi rudimentali, strette e dalla presa avventurosa, con i freni a tamburo che si scioglievano dopo poche strette di ganascia, senza l’elettronica correttiva che facesse da filtro tra il corpo del pilota e la pazzesca ferraglia da indirizzare, bene o male, lungo i declivi e le pianure della campagna italiana.
Si dice che il suo stile di guida consistesse in due fondamentali abilità: una generica, pigiare sempre sull’acceleratore senza mai farsela sotto, l’altra molto personale, le curve imboccate tutte in dérapage, anticipando con il muso la traiettoria e ritrovandosi avvantaggiati sul dritto successivo, con la macchina già puntata al rettilineo. Collezionava uscite di strada, incidenti, fratture, ma fu tra i pochi, della sua leva, a chiudere gli occhi nel suo letto.
La fioritura di aneddoti e leggende sulla sua invulnerabilità è clamorosa, appassionante e probabilmente infarcita di esagerazioni e frottole: tenuto insieme a furia di cerotti, gesso e fil di ferro, riparato e raddrizzato come un pezzo della meccanica complessiva macchina-pilota, nessun dolore lo fermava perché era una creatura mossa dai nervi - non dai muscoli e dalle ossa. (Cose simili si dissero di un altro esserino, più giovane di lui e quasi coevo, Edith Piaff, minata dalla vita, da uscite di strada e da altri incidenti esistenziali proprio come un pilota, ma amorosa e vibrante a oltranza, come un diapason. Gli estremamente nervosi possono diventare estremamente sensibili, sapere meglio degli altri come si prende una curva o una nota, come si sale a bordo della storia). Nuvolari su Chiribiri è del resto, lo si sente subito, già una canzone, e senza scomodare Roversi-Dalla si ammira, ancora oggi, la musicalità di quel cognome, la sua predestinazione celeste. Anche i motori, che avevano già cilindrate molto frazionate, otto e anche dieci cilindri, dovevano cantare da far paura, e sentirli fuori dagli autodromi, lungo i circuiti tracciati nelle comuni strade e per i paesi, sicuramente faceva un effetto strepitoso, anche per il contrasto così novecentesco, e così italiano, tra l’immobile paesaggio contadino e il mostro metalmeccanico che lo violava. Di quell’ossimoro sociologico e cronologico - le stoppie e il bolide, i campi e la velocità - si ha ancora traccia nell’Emilia della Ferrari, della Maserati e della Lamborghini. Il Museo Maserati, amorevolmente messo assieme da un facoltoso privato modenese, è custodito in una fattoria piena di vacche e forme di parmigiano. Ma certo è ormai trascorso, è tramontato (e si è mutato in ferita irrimediabile ai luoghi e allo spirito) quell’equilibrio magico e fragile tra il cuore arcaico e rurale del nostro paese - specie nella grande pianura del Nord - e la sua febbrile sapienza artigiana.
E a nessun pilota, oggi, potrebbe più accadere quanto accadde a Tazio Nuvolari in una Targa Florio degli anni Trenta. La macchina uscì di strada e ruzzolò tra i rovi, in fondo a un terrapieno. Il meccanico di bordo (la Florio si correva in coppia), sbalzato dall’abitacolo già durante la sbandata, si rialza e corre verso il ciglio della strada, guardando in basso e temendo il peggio. Non vede Nuvolari. Grida spaventato: "Tazio! Tazio!" Nuvolari sbuca intatto da un cespuglio, con il casco in mano, fa cenno al suo partner di tacere e gli bisbiglia: "Fai silenzio, asino! C’è un nido di quaglie con i piccoli. Li stiamo disturbando". Ruote all’aria, lì a fianco, la macchina agonizza sfiatando vapori di benzina.
Quando lo sbraito del motore lasciava dietro di sé solo eco e polvere, la gente in piedi tra le stoppie poteva ben dire di avere visto Nuvolari: un paio di lenti affumicate sotto un casco di cuoio, i mezzi guanti al volante, la bestia di vernice che lo ingoiava per quanto era piccolo (uno e sessanta, "un fascio di nervi spiccio e caustico" nella memoria di Enzo Ferrari). Sapere come parlava e che cosa pensava, come vestiva da civile, che fidanzate o mogli avesse, insomma che "personaggio" fosse, era il privilegio (o la sfortuna) della sua cerchia privata e di lavoro, e dei pochi giornalisti al seguito.
Per la folla, che è la sola vera depositaria dei miti, Nuvolari era solo un nome filante a bordo della Chiribiri, dell’Alfa, dell’Auto Union, della Ferrari: una folgore intravista da parecchi ma solo per pochi istanti, e percepita da tutti come fenomenale icona della destrezza e del fegato, della velocità e dello sprezzo della morte. Da fine anni Venti ai primi Cinquanta, l’epoca d’oro dell’automobile e dell’automobilismo sportivo, quando si correva nel territorio, tra il granturco e i pioppi, tra le case e i campi dell’Italia contadina, con pochi denari, molta incoscienza e una cieca fede nel rombo generoso di una modernità tutta ancora da verificare... Se partiamo proprio da qui, cioè dalla coincidenza tra la scomparsa di Nuvolari e la comparsa, in Italia, del piccolo schermo, possiamo capire meglio l’unicità del suo mito. Non fece in tempo, come Bartali e Coppi, a partecipare al Musichiere e scherzare con Mario Riva, dando al nascente pubblico di massa l’idea familiare e smagata dei campioni come vicini di casa, il tiepido brivido di vederli in abiti borghesi.
Morì che era ancora una fotografia, un breve e nebbioso filmato, una divinità sfuggente e misteriosa. Morì che era puro talento, non inquadrato nell’umanamente noto, il fantino prodigioso in grado di domare le infernali lamiere che già allora sfioravano i trecento all’ora, ma su gomme quasi rudimentali, strette e dalla presa avventurosa, con i freni a tamburo che si scioglievano dopo poche strette di ganascia, senza l’elettronica correttiva che facesse da filtro tra il corpo del pilota e la pazzesca ferraglia da indirizzare, bene o male, lungo i declivi e le pianure della campagna italiana.
Si dice che il suo stile di guida consistesse in due fondamentali abilità: una generica, pigiare sempre sull’acceleratore senza mai farsela sotto, l’altra molto personale, le curve imboccate tutte in dérapage, anticipando con il muso la traiettoria e ritrovandosi avvantaggiati sul dritto successivo, con la macchina già puntata al rettilineo. Collezionava uscite di strada, incidenti, fratture, ma fu tra i pochi, della sua leva, a chiudere gli occhi nel suo letto.
La fioritura di aneddoti e leggende sulla sua invulnerabilità è clamorosa, appassionante e probabilmente infarcita di esagerazioni e frottole: tenuto insieme a furia di cerotti, gesso e fil di ferro, riparato e raddrizzato come un pezzo della meccanica complessiva macchina-pilota, nessun dolore lo fermava perché era una creatura mossa dai nervi - non dai muscoli e dalle ossa. (Cose simili si dissero di un altro esserino, più giovane di lui e quasi coevo, Edith Piaff, minata dalla vita, da uscite di strada e da altri incidenti esistenziali proprio come un pilota, ma amorosa e vibrante a oltranza, come un diapason. Gli estremamente nervosi possono diventare estremamente sensibili, sapere meglio degli altri come si prende una curva o una nota, come si sale a bordo della storia). Nuvolari su Chiribiri è del resto, lo si sente subito, già una canzone, e senza scomodare Roversi-Dalla si ammira, ancora oggi, la musicalità di quel cognome, la sua predestinazione celeste. Anche i motori, che avevano già cilindrate molto frazionate, otto e anche dieci cilindri, dovevano cantare da far paura, e sentirli fuori dagli autodromi, lungo i circuiti tracciati nelle comuni strade e per i paesi, sicuramente faceva un effetto strepitoso, anche per il contrasto così novecentesco, e così italiano, tra l’immobile paesaggio contadino e il mostro metalmeccanico che lo violava. Di quell’ossimoro sociologico e cronologico - le stoppie e il bolide, i campi e la velocità - si ha ancora traccia nell’Emilia della Ferrari, della Maserati e della Lamborghini. Il Museo Maserati, amorevolmente messo assieme da un facoltoso privato modenese, è custodito in una fattoria piena di vacche e forme di parmigiano. Ma certo è ormai trascorso, è tramontato (e si è mutato in ferita irrimediabile ai luoghi e allo spirito) quell’equilibrio magico e fragile tra il cuore arcaico e rurale del nostro paese - specie nella grande pianura del Nord - e la sua febbrile sapienza artigiana.
E a nessun pilota, oggi, potrebbe più accadere quanto accadde a Tazio Nuvolari in una Targa Florio degli anni Trenta. La macchina uscì di strada e ruzzolò tra i rovi, in fondo a un terrapieno. Il meccanico di bordo (la Florio si correva in coppia), sbalzato dall’abitacolo già durante la sbandata, si rialza e corre verso il ciglio della strada, guardando in basso e temendo il peggio. Non vede Nuvolari. Grida spaventato: "Tazio! Tazio!" Nuvolari sbuca intatto da un cespuglio, con il casco in mano, fa cenno al suo partner di tacere e gli bisbiglia: "Fai silenzio, asino! C’è un nido di quaglie con i piccoli. Li stiamo disturbando". Ruote all’aria, lì a fianco, la macchina agonizza sfiatando vapori di benzina.
Michele Serra
Michele Serra è nato a Roma nel 1954, è vissuto quasi sempre a Milano e ora abita in Appennino. Giornalista, scrittore, autore teatrale, scrive su “Repubblica” la rubrica l’Amaca e sul Post …