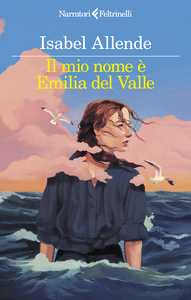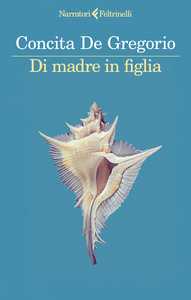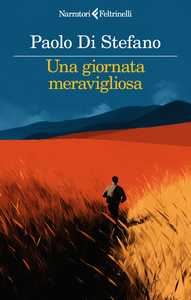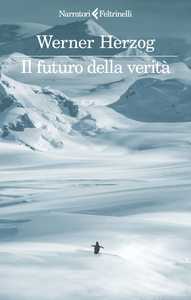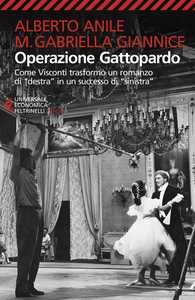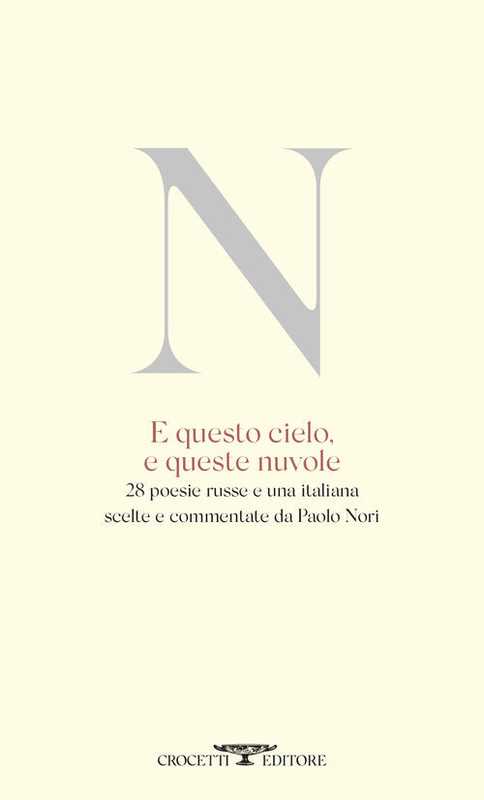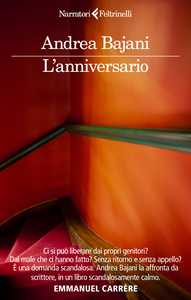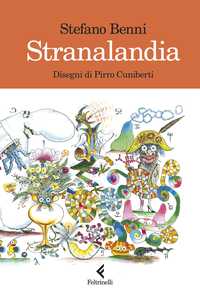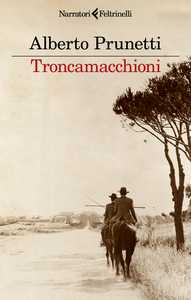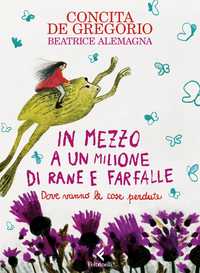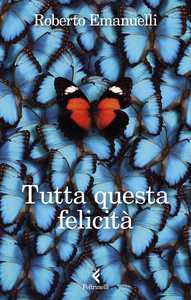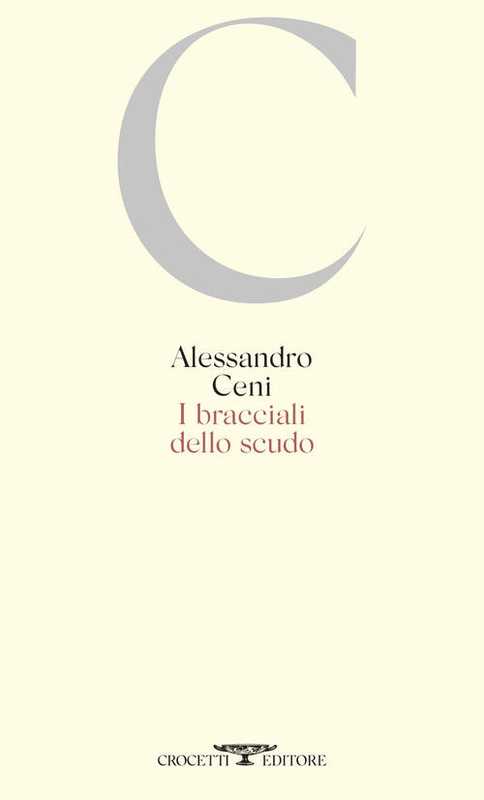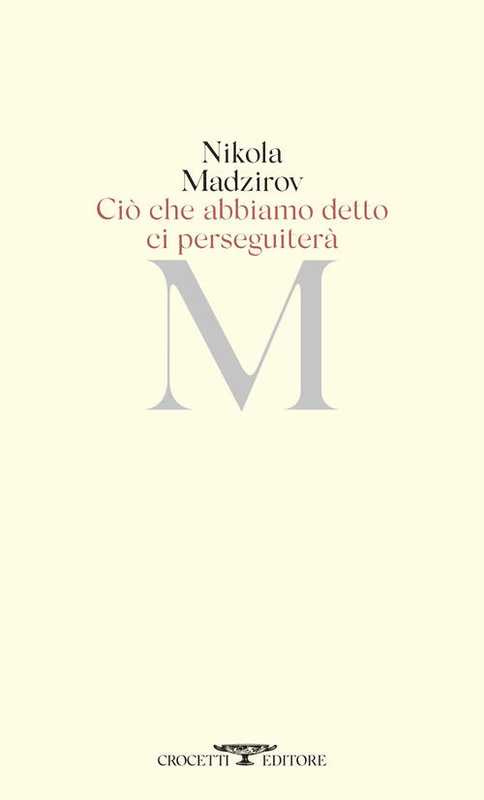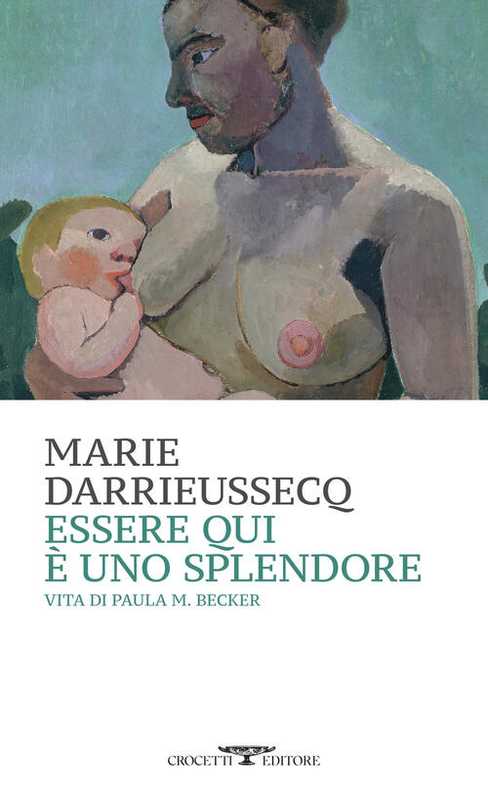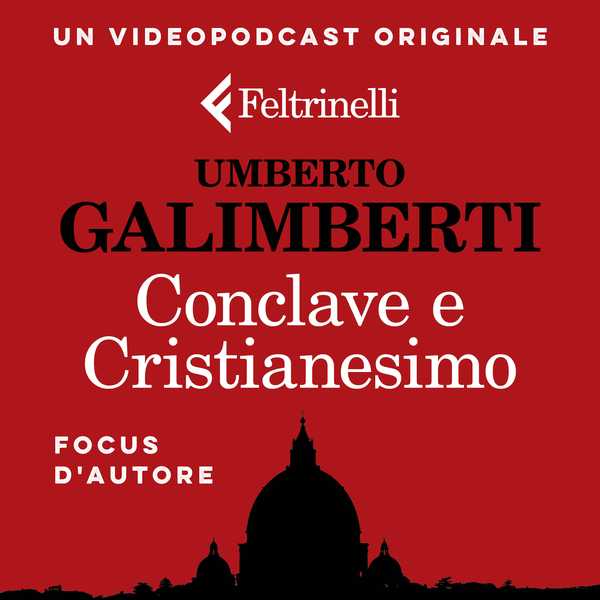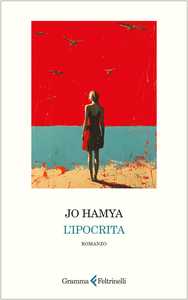Breve ancorché esaustiva storia della Triglia e dei molti piaceri che ne derivano pei palati da un certo livello in su.
07 Ottobre 2003
Il dotto medico ippocratico Galina nelle sue "Anotationi" al "Trattato de la natura de' cibi e del bere" dell'altrettanto esimio seppur galenico Pisanelli da Prato, se ne sbotta a un certo punto con tanta folgorante dottrina: "...la triglia non la mangia chi la piglia." Tale mirabile sintesi di saggia cognizione delle cose dell’appetito ha due profondissime ragioni intrinseche alla storia dell’uomanità e dei suoi travagli. In primis, la triglia è stata per quei quattro millenni e rotti di dieta mediterranea che antecedono il barocchismo e le sue schizzinerie, tra i pesci quello forse più pregiato, ragion per cui il pescatore, spesso schiavo e sempre poverello, ne ha con sicuro rammarico privato se stesso per le fauci dell’abbiente compratore; in secondis: chi, tra gli umani muniti di cuore, ha sostenuto lo sguardo della triglia morente, chi ha assistito alla coreografia straziante della sua capitolazione ad inferi, non potrebbe mai e poi mai commettere l'imfamia di cibarsene. C’è del cuore anche tra i vili mestieri; il pescatore è di spirito meditabondo e di sentimenti languidi; transeat l’agonia di uno stupido cefalo, ma la fine della triglia può anche rompergli il cuore. Perché il lettore intenda e a suo nutrimento spirituale, riproponiamo la tragica scena.. Una coppia di giovani triglie dal manto rosso nuoticchia tra gli scogli. Sfiorandosi si incrociano leggeri i baffi bargigli e gli sguardi languidi inebriati amorevoli (sguardo di triglia, si è detto in epoche cavalleresche, e a ragione); cinguettano i due (triglia da trizein = emettere un lieve suono) boccheggiando eccitati al vedere un verme a mezz'acqua. Il nobile maschio, perchè l'ama, si mette da parte e lascia abboccare la sinuosa, ancorché d’appetito robusto, compagna. Ahi, lasso! Un trillo acuto all'aggancio del'amo celato nel verme, e quindi repentino uno scoloramento dal rosso vivace marezzato dorato al grigio opaco e maculato della morte, mentre lui, disperato, si avventa con la pinna dorsale spinata a recidere il filo. Impotente. sibilerà fino allo stremo il suo dolore finché non galleggerà anch’egli grigiastro e riverso nell’abbandono della morte.
I romani, quelli dell’antica roma intendiamo, essendo di gusti tanto raffinati quanto criminali, erano soliti gustarsi lo spettacolo a mensa, facendo introdurre al banchetto le triglie vive a coppie in bocce di un vetro fenicio che esaltasse come in una sorta di tecnicolor le mutazioni cromatiche dell'agonia. Consumata la tragedia se le mangiavano, le amorevoli triglie, in molti gustosi e perversi modi.
Innanzitutto loro le triglie, o rossioli o pesci capra per via del colore e dei baffi, se le facevano venire dal meditteraneo meridionale e in particolare dal mare di Siria, perchè questo pesce raggiunge la sua magnificenza di gusto e di taglia nei mari caldi temperati e in quelli tropicali. Preferivano quelle di scoglio che, pagate in argento, potevano costare cifre favolose e, se è stato tradotto berne il "De Re Coquinaria" di Apicio, anche il controvalore di uno schiavo per una cesta. Apicio stesso propone ai suoi imperiali lettori di consumarle preparate in "patina", adagiate sventrate in un tegame sopra uno strato di cipolla e cotte a forno lento con un poco d'olio e di gorum e infine servite cosparse di aceto e santoreggia, arabescate con striscioline di aringa affumicata.
A proposito di perversioni, il gorum migliore si faceva proprio con la triglia. Gorum o, in epoca tarda e scanzonata, liquamen, era una salsa preziosissima e orribilmente schifosa composta dal prodotto liquido della fermentazione e dalla marcescenza controllata, con sale e spezie varie, del ventriglio del pesce Tutta l’antichità ne andava pazza per condire le carni e i pesci; sotto il ferreo tallone di Roma solo quattro fabbriche in tutto il Mediterraneo erano autorizzate a produrla e gli operai impiegati soggiacevano a regime militare. È certo che gli Ostrogoti erano formidabili contrabbandieri di gorum, convinti, a ragione, di affossare così buona parte dell’economia dell’impero. Bisogna arrivare all’età dei stilnovisti prima che quella sordida salsa risultasse disgustosa e per liquamen si cominciasse ad intendere propriamente il contenuto della fogna. Sarà una coincidenza, ma a vantarsi di aver dopo secoli riscoperto la ricetta del gorum è stato Rabelais.
Ma la triglia è gentile e delicata, la sua carne saporosa e fine, e dal secondo millennio in poi si è cominciato a mangiarla come dio comanda e dunque soprattutto arrosto e accomodata in salse profumate e leggiere. Maestro Martino da Como, ‟gran servitor di vescovi” del XIV secolo, è il primo a intuire che, a differenza di ogni altro pesce della sua taglia, la triglia non va volgarmente sbuzzata, ma semplicemente e delicatameznte lavata con molta acqua salata, avendo cura di estrarne il fegatello attraverso la bocca. C’è una bella differenza e chi sa capisce. Ma la ristocratica triglia risplende nella "Cucina Galante" di Vincenzo Corrado, napoletano di corte settecentesca, il quale propone trenta diversissimi modi di cottura assai delicati. E in particolare con la carta, presumiamo assai resistente e pura, nella quale possono essere avvolte accompagnate dalle erbette, origano, aglio e pevero e olio, e quindi bollite o messe in forno.
Nell'oggi la triglia non pare appetire più di tanto. Probabilmente per ragioni di estetica dell'occhio e stupidità generica le si preferiscono speci più appariscenti e di carni più chiare e meno sapide. Persino il ragionevole e pratico Artusi ne parla bene ma usando i verbi al passato; fornisce poi le ricette che sono quelle di uso comune: prevalentemente in gratella condite di limone aglio e prezzemolo con burro o olio o accomodate nel pomodoro, modo che si dice alla livornese come per tutto il pesce cotto in tal modo.
La baffuta e squittente triglietta occhidolci se ne stà ora perlopiù nei piatti di quelli che l'han presa e dei loro amici. Giustizia è fatta e un ripensamento dei ricchi non sarebbe forse d'uopo.
I romani, quelli dell’antica roma intendiamo, essendo di gusti tanto raffinati quanto criminali, erano soliti gustarsi lo spettacolo a mensa, facendo introdurre al banchetto le triglie vive a coppie in bocce di un vetro fenicio che esaltasse come in una sorta di tecnicolor le mutazioni cromatiche dell'agonia. Consumata la tragedia se le mangiavano, le amorevoli triglie, in molti gustosi e perversi modi.
Innanzitutto loro le triglie, o rossioli o pesci capra per via del colore e dei baffi, se le facevano venire dal meditteraneo meridionale e in particolare dal mare di Siria, perchè questo pesce raggiunge la sua magnificenza di gusto e di taglia nei mari caldi temperati e in quelli tropicali. Preferivano quelle di scoglio che, pagate in argento, potevano costare cifre favolose e, se è stato tradotto berne il "De Re Coquinaria" di Apicio, anche il controvalore di uno schiavo per una cesta. Apicio stesso propone ai suoi imperiali lettori di consumarle preparate in "patina", adagiate sventrate in un tegame sopra uno strato di cipolla e cotte a forno lento con un poco d'olio e di gorum e infine servite cosparse di aceto e santoreggia, arabescate con striscioline di aringa affumicata.
A proposito di perversioni, il gorum migliore si faceva proprio con la triglia. Gorum o, in epoca tarda e scanzonata, liquamen, era una salsa preziosissima e orribilmente schifosa composta dal prodotto liquido della fermentazione e dalla marcescenza controllata, con sale e spezie varie, del ventriglio del pesce Tutta l’antichità ne andava pazza per condire le carni e i pesci; sotto il ferreo tallone di Roma solo quattro fabbriche in tutto il Mediterraneo erano autorizzate a produrla e gli operai impiegati soggiacevano a regime militare. È certo che gli Ostrogoti erano formidabili contrabbandieri di gorum, convinti, a ragione, di affossare così buona parte dell’economia dell’impero. Bisogna arrivare all’età dei stilnovisti prima che quella sordida salsa risultasse disgustosa e per liquamen si cominciasse ad intendere propriamente il contenuto della fogna. Sarà una coincidenza, ma a vantarsi di aver dopo secoli riscoperto la ricetta del gorum è stato Rabelais.
Ma la triglia è gentile e delicata, la sua carne saporosa e fine, e dal secondo millennio in poi si è cominciato a mangiarla come dio comanda e dunque soprattutto arrosto e accomodata in salse profumate e leggiere. Maestro Martino da Como, ‟gran servitor di vescovi” del XIV secolo, è il primo a intuire che, a differenza di ogni altro pesce della sua taglia, la triglia non va volgarmente sbuzzata, ma semplicemente e delicatameznte lavata con molta acqua salata, avendo cura di estrarne il fegatello attraverso la bocca. C’è una bella differenza e chi sa capisce. Ma la ristocratica triglia risplende nella "Cucina Galante" di Vincenzo Corrado, napoletano di corte settecentesca, il quale propone trenta diversissimi modi di cottura assai delicati. E in particolare con la carta, presumiamo assai resistente e pura, nella quale possono essere avvolte accompagnate dalle erbette, origano, aglio e pevero e olio, e quindi bollite o messe in forno.
Nell'oggi la triglia non pare appetire più di tanto. Probabilmente per ragioni di estetica dell'occhio e stupidità generica le si preferiscono speci più appariscenti e di carni più chiare e meno sapide. Persino il ragionevole e pratico Artusi ne parla bene ma usando i verbi al passato; fornisce poi le ricette che sono quelle di uso comune: prevalentemente in gratella condite di limone aglio e prezzemolo con burro o olio o accomodate nel pomodoro, modo che si dice alla livornese come per tutto il pesce cotto in tal modo.
La baffuta e squittente triglietta occhidolci se ne stà ora perlopiù nei piatti di quelli che l'han presa e dei loro amici. Giustizia è fatta e un ripensamento dei ricchi non sarebbe forse d'uopo.
Maurizio Maggiani
Maurizio Maggiani (Castelnuovo Magra, La Spezia, 1951) con Feltrinelli ha pubblicato: Vi ho già tutti sognato una volta (1990), Felice alla guerra (1992), màuri màuri (1989, e poi 1996), Il …